Il bonifico degli editori
Quando l’editoria diventa una questione di pancia
di
Carlo Baghetti
Con un’intervista a Christian Raimo
Tra il 10 ottobre e il 14 ottobre sono apparsi on-line due articoli che parlano grosso modo dello stesso tema, anche se da prospettive molto diverse: la crisi dell’editoria. Il primo pezzo è un’intervista fatta da Tim Small a Martina Testa, attualmente traduttrice freelance ma che in passato ha lavorato per minimum fax; il secondo articolo è di Simone Cosimi dai toni più accesi della polemica, comparso sul sito di Wired.
I due articoli sono collegati, perché l’articolo di Cosimi prende lo spunto da alcune frasi riportate da Small, che servono al giornalista di Wired per sostanziare la sua tesi: se l’editoria è in crisi, la colpa è degli editori, i quali non hanno saputo fare bene il loro lavoro durante gli ultimi anni e le conseguenze della loro reiterata inettitudine è che oggi la maggior parte dei creativi che gravitano nell’universo editoriale, come ad esempio Federico Di Vita, sono costretti a lavorare gratis.
La frase di Martina Testa incriminata e riportata interamente da Cosimi è la seguente:
“Intorno a quegli anni abbiamo iniziato effettivamente a parlare di soldi, di vendite, di copie, a chiederci se un libro avrebbe ripagato le spese. Forse anche per imperizia, per scarsa competenza, professionalità, quel che vuoi, ma erano cose fatte con passione più che in maniera studiata, seria. Certi discorsi non li affrontavamo proprio. Ma il fatto che non li affrontassimo era anche sintomo del fatto che forse non era necessario affrontarli. Il modo di campare – nessuno è mai diventato ricco – si trovava. Anche senza un’attenzione alla parte commerciale, anche se non sapevamo bene come si facesse, i libri, in qualche maniera, si vendevano. Forse anche da soli. Nei primi anni non parlavamo mai di questo”.
E dopo aver riportato la frase, il giornalista di Wired conclude il suo pensiero sommando le cifre, facendo il bel segno dell’uguale e dicendo: siete degli incapaci. Basta giustificazioni.
La questione, posta così, è risolta: noi bravi e preparati non veniamo pagati (si percepisce in filigrana il risentimento personale), voi incapaci continuate a posare nei salotti in cui non siamo ammessi; vi odiamo tutti, siete cattivi.
Sto esagerando, ma il discorso di Cosimi è uno sfogo che rischia di essere infantile, nulla di più. Non ha alcuna sostanza critica, proprio come il fenomeno dei #coglioniNo che giustamente il giornalista cita. Detto ciò, appoggio la protesta di Di Vita – del quale ho apprezzato il testo uscito anni fa per Effequ – e sono contento di vedere che il problema del ritardo dei pagamenti e la crisi del mondo editoriale venga dibattuto pubblicamente, così da attivare la mente di tutti alla ricerca di soluzioni pratiche e teoriche.
Nessuna necessità di grida, di appendere sulla croce i colpevoli, di mettere alla gogna editori, di insultarli pubblicamente; questo è solo un metodo scandalistico che allevia il sintomo e non cura il problema, unico metodo che in Italia ha un successo clamoroso da vari anni.
A star cambiando è il modo di fruire le storie da parte del pubblico, non mi riferisco unicamente alla rivalità cartaceo vs digitale, che oggi appare sempre più una scelta obbligata, ma parlo proprio del contenitore nel quale il “narrativo” è trasportato. La necessità di ascoltare storie, di viverle, è sempre nell’uomo molto forte (nessuna mutazione genetica, state tranquilli!), solo che ad essere cambiata è l’espressione, il mezzo. Il libro, mi riferisco qui al romanzo di fiction, è diventato da veicolo incontrastato di storie un mezzo tra i tanti, e anche dalle scarse potenzialità. Se ci pensiamo bene, il libro in sé è un oggetto alquanto vintage, non ha neanche un dizionario incorporato, per esplorare come si deve il linguaggio di un autore è necessario avere a portata di mano un mattone di tremila pagine (il dizionario, cioè) o un bloc-notes in cui appuntare continuamente parole; con il libro cartaceo non si possono fare verifiche in tempo reale su eventi citati da un autore (cosa che capita più spesso con i saggi che con i romanzi, ma provate a leggere Eco o Genna senza aver voglia di andare a vedere se tale personaggio o talaltro è veramente esistito); e via dicendo. La passione per il libro cartaceo sembra una questione per feticisti.
Oltre i limiti fisici del libro cartaceo ce ne sono altri, strutturali, e meno gravi, perché pertengono al gusto personale dei consumatori: il romanzo è linguistico nel primo senso della parola, è attraverso il linguaggio che io esploro le immagini, intreccio le storie, vivo le narrazioni; altri tipi di narrazione allargano il senso di “linguistico” attraverso l’impiego di immagini e suoni (è il caso di alcune serie tv che raggiungono livelli narrativi di altissimo livello, in maniera molto più strutturata del lungometraggio), oppure attraverso complessi meccanismi tecnici che permettono al consumatore di creare da sé una storia (questa frase scritta trentacinque anni fa forse avrebbe fatto pensare solo a Rayuela di Cortázar, oggi si riferisce ai videogame).
La “narratività” ha raggiunto oggi una tale stabilità che può passare attraverso moltissimi materiali senza problemi, libri certo, ma anche serie tv e videogame. Siamo circondati da storie, si sono continuamente moltiplicate in vario modo, con la conseguenza però di stravolgere il panorama che abbiamo contemplato finora: il mondo editoriale, per forza di cose, subirà una nettissima restrizione, e i primi segnali di questo violento passaggio sono, ahimè, i #coglioniNo, in particolare quelli che bazzicano il campo editoriale. Oltre questo passaggio culturale influiscono anche fattori economici di grande portata, come chiarisce meglio l’intervista a Christian Raimo.
Aspetto, questo dell’ affacciarsi di nuovi potenti mezzi di trasmissibilità del narrativo, che Cosimi non prende per nulla in considerazione, seppure offerti bellamente da Martina Testa che limpidamente afferma: “E devo ammettere che se quando avevo 18 anni ci fosse stata la PlayStation3 con giochi come The Last Of Us, e la sua suspense, francamente col cazzo che avrei passato tutto quel tempo a leggermi Baricco”.
La questione sembra piuttosto essere questa: gli editori hanno risposto con molta lentezza al cambio di paradigma culturale, operando scelte sbagliate e svuotando le sacche di ricchezza presenti nel paese, ma questo non vuol dire che debbano cedere e lasciarsi inglobare da armi di distruzione culturale e appiattimento generale dell’umanità come Amazon o Google, solo perché sono “più abili” nella gestione economica dell’editoria. Il narrativo, quello che passa attraverso la forma romanzo, ha ancora un buon numero di estimatori e delle grandi potenzialità di crescita, anche se il bacino economico è nettamente inferiore rispetto a quello da cui attingeva anni fa, ovvero negli anni in cui deteneva il monopolio della narrazione.
Intervista a Christian Raimo
Hai letto l’articolo apparso su wired.it “Cari editori, non può essere sempre colpa della crisi” scritto da Cosimi? Cosa ne pensi?
Monnezza.
Nel senso?
Nel senso che riporta la fenomenologia della questione senza andare ad indagare le cause. La difficoltà delle aziende editoriali, oggi, è un dato di fatto. Dire che questa questione è solo responsabilità degli editori, per me, è fare del grillismo, non rendersi conto di quale sia il contesto sociale politico economico nel quale operano gli editori d’oggi. Quando si dànno delle colpe personali e non delle colpe legislative, sociali, economiche, non si arriva da nessuna parte. È vero, ci sono degli editori che si sono comportati male, che si comportano male, e sarebbe anche giusto fare i nomi; ci sono vari editori che non pagano o che hanno tali ritardi nei pagamenti che è come se non pagassero.
Cosimi non centra il punto della questione, ma qual è il vero punto della questione dal tuo punto di vista?
Ci sono tanti livelli del problema, diversi. Il migliore libro italiano sulla questione editoriale è un testo da me curato, non perché l’abbia curato io, ovviamente, si chiama Come finisce il libro dello scrittore Alessandro Gazoia. C’è un problema di passaggio di paradigma storico rispetto alla cultura: stiamo passando da un paradigma storico in cui c’è l’industria culturale e, poi, un’utenza, ad uno in cui c’è un’industria culturale diffusa. Questo è innegabile: oggi gli editori sono Google, Apple, Amazon. In realtà, la distribuzione ha assunto un ruolo di agenzia culturale: questo è un passaggio fondamentale. Amazon sta creando un sistema proprietario, dove la distribuzione si è reinventata come edizione, stravolgendo la funzione della lettura come agenzia educativa, agenzia critica, facendola diventare una mera industria legata semplicemente al mercato.
Martina Testa parla del concetto e del ruolo dell’intrattenimento, cosa ne pensi?
La questione fondamentale è capire come il libro si lega, da una parte, alla tradizione del libro – ed è quindi fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà -, dall’altra, analizzare lo sviluppo che ha avuto l’industria editoriale nella formazione civile delle società attuali. Se tutto questo viene ridotto semplicemente al funzionamento dell’industria culturale, per me, viene meno una grossa parte della politica e della civiltà di un paese. Per quanto Amazon sia iper-funzionante, non ha quel ruolo di agente culturale che deve avere un’industria culturale.
Come si fa, secondo te, per restituire un ruolo di guida all’industria culturale?
Con delle leggi, anche solo un paio, tassando chi ha dei regimi di monopolio. Ad esempio, Amazon paga le tasse in Lussemburgo, per dirne una, quindi non reinveste in Italia, nell’educazione alla lettura. Amazon crea reddito per gli azionisti, per i dividendi. Bisogna investire, con aiuti di Stato, nell’editoria di qualità. Non capisco come è possibile che la Fiat non vendendo le auto è sopravvissuta per decenni con aiuti di Stato e aziende che hanno avuto un ruolo centrale nell’educazione degli italiani non abbiano questo diritto.
Sono cresciuto in una cultura in cui il dibattito pubblico era alimentato da testi critici, saggistica, editoriali, commenti; questo è il modo in cui io ho imparato a fare cultura. Mi sembra un modo centrale di fare cultura: una posizione critica nei confronti della società, che si rinnova, che crea cittadini consapevoli. È una cultura del libro nata in àmbito umanistico, a cui mi rifaccio. Questo è indipendente dai supporti che si usano, può avvenire con la carta o con il digitale. Se penso all’eventualità che le fictions sostituiscano i libri, che Facebook rimpiazzi il romanzo: no, per me non è così. Sono forme di intrattenimento competitive, ma come dice Martina Testa, dedichiamo al libro una minore quantità di tempo. Per questo, vorrei dedicarmi a libri che meritano veramente.
Non pensi che la “narratività” si stia trasferendo su altri supporti che la accolgono molto bene? Penso a Breaking Bad, a True Detective, a House of Cards, che hanno solidissimi impianti narrativi; non credi che questo vada a prendere un posto che fino ad allora era occupato quasi esclusivamente dal romanzo di fiction?
Penso che per il romanzo questa sia una sfida ancora più interessante. Penso sia ovvio che cercheremo nella qualità di un romanzo qualcosa di competitivo con Breaking Bad. Breaking Bad è scritta da Dio, è ovvio che mi faccia appassionare. Recentemente sono andato a vedere uno spettacolo di Lucia Calamaro, che possiede una delle scritture migliori in Italia, e uscendo da lì, ho pensato che la drammaturgia italiana non sia in perdita rispetto a Breaking Bad. Ovviamente Lucia Calamaro non è una persona che ha letto solo Lacan o Proust, ma ha visto anche Breaking Bad, quindi ha pensato un teatro che sia competitivo anche con quello. Ho letto recentemente bei libri che non prescindono dall’esistenza di Breaking Bad o The Wire. Wallace ha scritto il Re Pallido dopo aver visto The Wire.
La mia domanda era piuttosto su chi avesse un ruolo preminente nel trasmettere narrazioni…
Quando eravamo piccoli, ci fu l’invasione dei cartoni animati giapponesi. Si credeva che questi cartoni togliessero completamente ai ragazzi la possibilità di leggere libri. Io passavo moltissimo tempo guardare la televisione, ma questo mi ha insegnato a leggere in maniera diversa i romanzi, a chiedere delle formule narrative altre. Dopo aver visto Breaking Bad, se trovo un noir scritto male, mi annoio. E magari mi guardo un’altra serie. Ma se trovo un romanzo che concilia la qualità della trama con una scrittura eccelsa, me lo “ciuccio da morire”. Limonov non è concorrente con Les revenantes sebbene siano scritti dallo stesso autore: sono due opere complesse e meravigliose, scritte da un autore che cerca di fare il meglio, sia come scenarista che come romanziere.
Nonostante il cambiamento di paradigma pensi che il romanzo conservi il suo posto preminente e…
…Si deve sempre reinventare. “Romanzo” vuol dire tutto e non vuole dire niente, possiede una grande plasticità: se pensiamo il romanzo… è Don Chisciotte, è Proust, ma anche Margaret Mazzantini e Daria Bignardi. Il romanzo si reinventa, rinasce dalle proprie ceneri, qualcosa di talmente classico che non morirà. Negli ultimi anni sono usciti romanzi bellissimi e la gente ha continuato a leggerli. Breaking Bad non sarebbe stato possibile senza i Demoni di Dostoevskij.
Il romanzo come simbolo di una classe sociale è definitivamente finito?
Questo non è vero. Anche le serie tv sono simbolo di una classe sociale. Pensa che 3,5 milioni di persone vedono le fiction di Raiuno e in confronto coloro che vedono Breaking Bad sono una minoranza.
Che classe sociale?
Secondo me, c’è un grande “classismo dell’intelligenza”, nel senso che la possibilità di accesso alle piattaforme più costose o la possibilità di codificare meccanismi di significato più complessi, come Breaking Bad, divide la società in maniera classista: persone intelligenti e persone non intelligenti. Tutto questo è una nuova forma di classe sociale. Noi parliamo di Breaking Bad che rivoluziona il romanzo. Ma quanta gente guarda Breaking Bad? Noi guardiamo Breaking Bad! Se vai in qualunque paese di provincia, se vai in un liceo qualunque, la gente non guarda Breaking Bad. I ragazzi stanno di fronte alla televisione, guardando una tv generalista che fa schifo. Ci sono consumi culturali per fasce alte e consumi culturali per fasce basse.
Pensi che un diciassettenne iscritto ad un istituto tecnico nella provincia di Varese non abbia visto Breaking Bad?
Penso che la percentuale sia molto limitata. Ci sono statistiche che dicono che gli under 18 del sud non hanno mai visto un film al cinema, non hanno mai fatto sport, non hanno un computer e non hanno mai letto un libro. Io insegno in un liceo “bene” e anche in un liceo “bene” l’accesso a prodotti culturali alti è una cosa che la maggior parte dei ragazzi non fa. La tv generalista, per il 95% delle persone, è la principale fonte di accesso all’informazione. Ci sono tassi di analfabetismo funzionale. L’ultima fiction della Rai, Nuova vita, ha avuto 9 milioni di persone di audience. Ogni fiction che vada bene, in Italia, ottiene tra 6 e 9 milioni di spettatori. Breaking Bad, in Italia, se lo hanno visto 100.000 persone, è grasso che cola.
Ultima domanda: secondo te la nostra esperienza esistenziale è ancora “narrativizzabile”? Il romanzo ha ancora la capacità di contenere le nostre esperienze sempre più frammentarie?
Mi sono laureato su Ricoeur, il quale pensa che le esistenze si strutturino come storie e, in questo senso, penso che ci sia un eccesso di storytelling. Oggi tutto è storia. Storia la morte, storia la malattia: c’è un eccesso di storytelling e un difetto di critica. Ovviamente, lo storytelling si adatta a varie ristrutturazioni. Oggi il romanzo deve considerare una grande quantità di sub-plot, perché non solo le nostre esistenze sono più frammentarie e meno prevedibili, ma è aumentata anche la nostra capacità di tenere insieme più livelli narrativi. Se vedi oggi una puntata di Magnum P.I. appare terribilmente noiosa con una sola linea narrativa. Una qualunque serie di oggi presenta sei o sette linee narrative e si riesce a seguirle in maniera tranquilla. Questo dipende dalla nostra percezione, che sta cambiando; è in corso la trasformazione di un’area del cervello, che si chiama “Area di Brodmann”, incaricata della funzione di multitasking, che sviluppiamo fin da piccoli giocando ai videogiochi e guardando la tv.


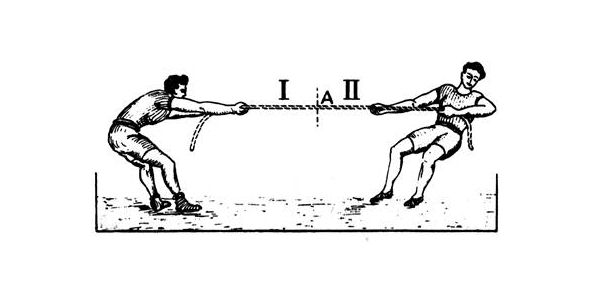

Non voglio criticare il contenuto (sono perlopiù d’accordo con Christian, tranne per “I ragazzi stanno di fronte alla televisione, guardando una tv generalista che fa schifo” — i ragazzi tutto guardano tranne la tv generalista; guardano i video di Fedez, di Salmo, di Bello Gu, nonché di Cane Secco e altri YouTubers da centinaia di migliaia di visualizzazioni) ma la forma: le interviste andrebbero editate con cura, sennò restano refusi [“è fare di grillismo”; “riesci la seguirle”; “due opere complesse e meravigliosa”; “la fiction sostituisci il libro”], ripetizioni, anacoluti, frasi confuse [“un ruolo centrale nell’educazione degli italiani delle generazioni italiane”; ma anche “La questione fondamentale è capire come il libro si lega da una parte alla tradizione del libro, e quindi fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà” o “Tutto questo è una nuova forma di classe sociale” (semmai CREA)] che non solo nuocciono alla comprensibilità ma tolgono credibilità sia all’intervistato sia all’autore dell’intervista. È un peccato.
Condivido l’elefante evocato da Christian Raimo, il sostegno pubblico alla cultura è cosa da capire e sostenere, se poi sia sostegno all’editoria, alla scrittura, all’autore, vediamo. In Lombardia non pagano il bollo i motorini più vecchi e inquinanti a due tempi, non vedo perché non si possa sostenere la vita culturale del paese.
Detto questo, ricordo che alcuni anni fa (progetto: controllo di versione per umanisti) cercai di capire come si lavorasse materialmente nelle case editrici e ne ricavai un quadro desolante: file Microsoft Word impaginati come su macchina da scrivere, scambiati e rigirati e ripetuti, finché tutto passa a un grafico con una copia craccata di Xpress o InDesign. Quali editori usano il controllo di versione oltre ad Apogeo?
Cara Martina, colpa mia, per una questione bassamente tecnica. da quattro giorni sono senza computer e ho potuto solo oggi ricollegarmi. Converrai che si tratta di un’eccezione a cui rimedio ora, scusandomi con lettori e commentatori per questo “inconveniente”. effeffe
Provo a spiegare perché l’editoria non dovrebbe ricevere aiuti dallo Stato.
Il fatto che la Fiat abbia ricevuto aiuti è un chiaro segno del perché l’Italia ha fatto la fine dell’Italia, per citare Guzzanti. Negli anni ’60 la Olivetti era all’avanguardia nel settore informatico, provò a tentare il colpaccio negli USA, ma le andò male. Intervenne lo Stato per aiutarla, ma le imposero di abbandonare il settore informatico per tornare alle macchine da scrivere, facendo fuori i manager migliori. Tuttò ciò fu imposto da Fiat, Mediobanca, IMI. In un economia di mercato le aziende che non producono profitti devono chiudere, morire, lo Stato al limite è bene che aiuti le aziende produttive, vincenti, che si modernizzano, che hanno un’idea vincente come l’Olivetti, ma che sono ancora deboli dal punto di vista finanziario. Oggi ci sono valenti start-up italiane (anche nel meridione) che producono software all’avanguardia che attirano capitali per milioni di euro dall’estero e che non ricevono finanziamenti dal credito locale che è abbarbicato all’economia improduttiva del posto. In secondo luogo è bene che aiuti le persone che perdono il lavoro, non le aziende fallite tenendole in piedi con la cassa integrazione, che è il modo più idiota che esiste per spendere denaro pubblico inutilmente. In Italia abbiamo ereditato le corporazioni dal periodo fascista, e ce le siamo tenute, vedi il caso dei tassisti che adesso devono smuovere il culo e inserire pure loro le app, grazie all’innovazione portata da uber. Vedi anche un cosa inutile come la confindustria. Il mercato funziona così. Sono le scelte manageriali che fanno la differenza per quanto riguarda la produttività. In Giappone negli ultimi vent’anni sono invecchiati, hanno meno gente che lavora e per meno ore eppure hanno aumentato la produttività. Se ancora pensiamo che lo Stato debba aiutare le aziende purchessia stiamo messi male.
Tutto molto bello, ma “Capri” non è certo l’ultima fiction della Rai (è finita nel 2010), e nove milioni di spettatori li avrà avuti forse (ma molto forse) la prima serie del 2006, non certo adesso, periodo in cui si esulta per molto meno. Niente da fare: la serialità americana qui non ha mai attecchito più di tanto, il picco massimo è di Dr House. Perché strapparsi le vesti?
Non mi leggo tutto l’articolo manco se mi paghi. Ma è così difficile capire che se un lavoro lo commissioni lo devi pagare? E che se un editore commissiona lavori per tre anni, senza pagarli, e senza avvertire nessuno dei suoi lavoranti che c’è la possibilità che non sia pagato, merita tutta la gogna possibile o immaginabile? Non è difficile da capire, non c’è alcun bisogno di approfondimento critico. Se un operaio in cantiere non viene pagato per 6 mesi al settimo di tira i mattoni, non rilascia interviste a nazioneindiana.
Quella a cui si riferisce Raimo non è l’area di Brodmann, ma “una delle” aree di Brodmann, precisamente la numero dieci (BA10). E che sia in corso la sua *trasformazione* è una cosa che risulta solo a Raimo, che ha un’idea piuttosto imprecisa dell’anatomia cerebrale e della sua evoluzione. Il che non toglie sostanza al discorso, ma diminuisce di molto la credibilità dell’intervistato e delle sue argomentazioni. Perdonatemi l’off topic, ma ci resto sempre un po’ male quando un umanista conferma la pessima idea che gli scienziati hanno di noi.
“Dire che questa questione è solo responsabilità degli editori, per me, è fare del grillismo, non rendersi conto di quale sia il contesto sociale politico economico nel quale operano gli editori d’oggi”.
L’editore è un impreditore. Se un’azienda va male la responsabilità è dell’imprenditore. Solo in ambito editoriale la responsabilità è del potenziale cliente (il lettore) che non compra il bene che gli viene offerto. Immaginatevi qualcosa del genere in un altro ambito. Immaginatevi, che so, Steve Jobs che si lamenta del fatto che la gente non compra l’iPhone. Cosa fa invece uno come Steve Jobs? Si interroga sul perché l’iPhone non venda e magari propone l’iPhone2. Cosa fa l’intellettuale di area editoriale? Chiede sussidi di Stato
“Bisogna investire, con aiuti di Stato, nell’editoria di qualità. Non capisco come è possibile che la Fiat non vendendo le auto è sopravvissuta per decenni con aiuti di Stato e aziende che hanno avuto un ruolo centrale nell’educazione degli italiani non abbiano questo diritto”.
Io credo che le facoltà umanistiche dovrebbero essere chiuse per legge. Fermo restando che non sono favorevole agli aiuti di Stato in nessun settore come si fa a non capire la differenza tra un’azienda che avrà dato lavoro a decine di migliaia di persone e una casa editrice che dà “lavoro” a qualche decina di eterni 30-40enni e di cui, con ogni probabilità, la maggior parte dei parlamentari (che sono quelli che fanno le leggi, lo spiego agli umanisti presenti in sala) non ha nemmeno sentito parlare? (uso in questo contesto “lavoro” nell’accezione diffusa in ambito editoriale: lavoro in nero, lavoro mal pagato, lavoro forse pagato un giorno, lavoro forse pagato mai, stage)
infine la tirata su Amazon. ma che Amazon venda libri, persino i vostri, l’avete capito? http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=christian%20raimo&sprefix=christian+ra%2Caps
Caro Francesco Rende,
cerco di rispondere brevemente e per punti ai suoi interventi.
Innanzitutto direi che leggere interamente gli articoli che si decide di commentare è un buon metodo per non incappare in errori interpretativi e affermazioni fuori contesto, pericoli nei quali è caduto con entrambi i piedi. È ovvio che l’editore, o l’imprenditore in generale, debba pagare il lavoro commissionato, il problema non è questo. La questione è piuttosto il modo in cui si sceglie di esprimere il proprio disaccordo, la propria rabbia, e tutta la gamma di sentimenti che va insieme. La gogna, che lei puntualmente evoca, mi sembra strumento assai povero e un tantino vintage, persino incivile e medievale (con tutto il rispetto per il Medioevo), e lo sono anche gli articoli che condensano riflessioni inconsistenti come quello da cui il mio intervento prende spunto. La protesta è giusta, il diritto ad essere pagati indiscutibile e sacrosanto, ma il discorso che si oppone deve essere ragionato, tutto qui. Gli isterismi non portano da nessuna parte, così come il lancio di mattoni che menziona in seconda battuta.
Circa la seconda questione che lei solleva, direi che ancora una volta si tratta di una visione monolitica e miope: non credo sia necessario spiegare nel dettaglio cosa differenzia un’opera di narrativa da un iPhone2, ma che l’editoria non persegua (in teoria) unicamente fini commerciali dovrebbe essere, ancora una volta, scontato. L’esempio che fa di Jobs, ammesso che possa intervenire dall’oltretomba, è un esempio non valido se rapportato al mondo dell’editoria (e specifico, “di qualità”). Trovo ad ogni modo preoccupante paragonare un potenziale acquirente della Apple a un potenziale lettore.
A me sembra che ormai siamo arrivati a un livello di autoreferenzialità, all’interno del mondo della piccola e media editoria, tale da identificare il problema con il tentativo di assolversi da tutto il macello che sta succedendo. Mi spiego: i grandi editori di tutta questa manfrina se ne fregano bellamente, sono anni che precarizzano, sempre più selvaggiamente; i medio piccoli invece, vuoi la crisi, vuoi la fine della storia del libro come prodotto anticiclico, si sono visti crollare il pavimento sotto i piedi. E che fanno ora? Creano un nuovo genere letterario: la lamentatio dell’editore. “Eh, ma non è mica colpa nostra!”, “Nemmeno ne parlavamo della parte commerciale, dieci anni fa, figurati…” “Sai, ma io non ho una formazione imprenditoriale, come faccio?”, “Dovremmo provare a pubblicare di meno, sai la decrescita ci fa belli.”.
Di ricette per risolvere questi problemi io non ne ho, ma da lettore e da libraio piccolo piccolo mi permetto di dire che questo modo di fare, pensare all’editoria è diventato inammissibile. Mi sembra inutile richiamare a un’assunzione di responsabilità chi fino a oggi si è nascosto dietro un dito, ma un po’ di onestà in più non guasterebbe.
Franco Di Battista:
i grandi editori di tutta questa manfrina se ne fregano bellamente, sono anni che precarizzano, sempre più selvaggiamente; i medio piccoli invece, vuoi la crisi, vuoi la fine della storia del libro come prodotto anticiclico, si sono visti crollare il pavimento sotto i piedi.
Mi pare che i piccoli e medi editori usino collaborazioni esterne tanto quanto i grandi editori, se non più.
Almeno i grandi non fanno finta di sentirsi in colpa. (Risposta basica, se del mio post hai capito solo quelle tre righe).
Dialogo di un potenziale acquirente della Apple e di un potenziale lettore
Cioè no, aspetta, monologo.
Battute a parte, è piuttosto arduo sostenere che la Apple persegua unicamente fini commerciali, immagino che coloro che ci lavorano per svilupparne i prodotti non pensino solo a quello. E mi pare che ci siano infinite discussioni sulla qualità dei prodotti informatici. Ma qualunque fine persegua un’azienda, se sta sul mercato conta il profitto. Non vedo alcun buon argomento per dire che i soldi pubblici debbano finanziare un’azienda o un settore intero, usando un discrimine del tutto arbitrario e inconsistente come quello della qualità. Lo si è fatto con l’agricoltura, e abbiamo distrutto un settore. Allora si abbia il coraggio di uscire dal mercato.
Circa la protesta è molto semplice: tutti gli operatori creino una pagina online con i resoconti delle esperienze e i comportamenti degli editori, così chiunque saprà a cosa va incontro.
Che poi, col cavolo che li fate i libri, senza i “prodotti informatici” torniamo al torchio, eh.
E’ notizia piuttosto recente che Richard Branson, proprietario della Virgin, ha destrutturato il lavoro di ufficio; i suoi lavoratori non hanno più orari e non devono neppure venire in ufficio, è sufficiente che l’obiettivo concordato venga perseguito e raggiunto.
Da questo esempio di imprenditoria estrema (con evidenti implicazioni fenomenologiche) si capisce quanto sia lontana l’imprenditoria editoriale.
L’atteggiamento miope è di colui che, appurato e riconosciuta l’esistenza di un problema, identificati i tratti, le origini e le implicazioni, non solo non ne ricerca una soluzione, ma punta il dito contro il cliente ignorante (e invece l’esempio della Apple è pertinentissimo) e fa spallucce di fronte alle rimostranze dei sottoposti che non vengono pagati.
Quasi dieci anni fa ricevetti la prima offerta ad essere pubblicato dietro corresponsione di un obolo e non mi pare che si sia fatta tanta strada, mi sbaglio?
[…] l’articolo uscito su Nazione Indiana il 5 […]
Io sono d’accordo sulla questione del trasferimento narrativo verso altri linguaggi, meno sulla fine del libro come mezzo (i saggi continuo a comprarli) ma certa della morte cerebrale del romanzo.
L’opinione di Raimo ha smesso di avere senso e valore nel momento in cui – a proposito di autoreferenzialitá – infila una marchetta spudorata al suo testo (giacché c’è crisi), quindi non la commento che si autocommenta da solo (a proposito di certi automatismi degli umanisti). Ciò di cui mi rendo conto con sommo dispiacere è che -stesso a chi ci “lavora” dentro – non entra nel cervello che quella del libro è un’industria, come quella del cinema e quella discografica, soggetta alle medesime regole di mercato subite da chi fa industria. Non è che vive ed opera nell’iperuriamo, né è soggetta ad una etica diversa, né ha particolari obblighi morali da dover soddusfare (come l’innalzare l’animo dei propri lettori). Se in un periodo di crisi non sei capace di riconfigurare i tuoi obiettivi, la tua offerta, la tua – volgarmente ahivoi – idea di business e adattarla ai fattori ambientali per sopravvivere (darwin?) beh non ti resta che chiudere baracca. Aiuti di stato? Cioè io dovrei sovvenzionare un’industria editoriale e non, chessò, una manufatturiera o discografica? E perché? Secondo quale idea dovrebbe valere più un settore anziché l’altro? E poi per quale motivo dovrei lavorare senza percepire un introito economico? Per la gloria ed amor di Proust? Voi vivete nell’iperuranio! Gratuitamente vado a prestare aiuto ad un xanile, in un reparto pediatrico, col cavolo che svendo il mio tempo e le mie competenze dietro a 4 vanesi che fanno quello che fanno per amor di patria. Sine pecunia non cantantum misse. È la prima cosa che impari al ginnasio.
è davvero dura leggere pezzi come questi, dove si parla di “narratività” come una categoria dello spirito, un’invariante antropologica, un concetto autoevidente senza definire minimamente di cosa si stia in realtà parlando. Va bene, facciamo a meno di Adorno, Debord, tutto quello che volete. Ma se iniziamo a ignorare tutto quanto si è scritto sulle forme (storiche) della narratività novecentesca, ossia romanzo, novelle, prosa, scrittura drammaturgica, poi non ci resteranno che questi lampi aforistici:”se quando avevo 18 anni ci fosse stata la PlayStation3 con giochi come The Last Of Us, e la sua suspense, francamente col cazzo che avrei passato tutto quel tempo a leggermi Baricco”.
In più, mi trovo a leggere anche frasi di Raimo di questo genere:
“Che classe sociale?
Secondo me, c’è un grande “classismo dell’intelligenza”, nel senso che la possibilità di accesso alle piattaforme più costose o la possibilità di codificare meccanismi di significato più complessi, come Breaking Bad, divide la società in maniera classista: persone intelligenti e persone non intelligenti. Tutto questo è una nuova forma di classe sociale.”
Ma dove sono atterrato?
Non so, ma forse il problema è leggere Baricco. Così, almeno ai miei occhi.
Andrea, le analisi, riflessioni che emergono da questa intervista sono tano più interessanti in quanto legate a delle pratiche editoriali e narrative molto più reali e concrete di quanto non accada in altri casi seppure ispirati ai mostri sacri che citi tu. Possiamo preferire trentamila volte un Debord a Ricoeur per quanto riguarda il concetto stesso di narratività però non possiamo non vedere come a parte brevi lampi soprattutto in campo pubblicitario, in generale il mondo editorial-letterario attuale non mi sembra contenere quella carica sovversiva del linguaggio e della visione di tipo situazionista. Che poi si possa considerare una playstation alla stregua dei western o dei roman-photo evocati da Debord, questa via mi sembra più che ragionevole. Il problema, in un certo senso, è che né tu né io, né tanti over 40 non sappiamo che cazzo sia una playstation. effeffe
Caro Francesco, se devo servirmi di queste analisi per capire 1) che cosa sia una playstation 2) di come funzioni il lavoro collettivo che accompagna la nascita e la realizzazione delle serie televisive americane più di tendenza 3) per capire cosa s’intenda per narratività, siamo messi male. Non basta evocare un problema reale, per avere di seguito un’analisi efficace. Dire che i videogiochi utilizzano in modo straordinariamente efficace aspetti propri della narrazione “letteraria” o “cinematografica”, e dire che ci sono serie televisive che sono più affascinanti dei romanzi di Genna, mi sembra semplicemente affermare una verità più o meno condivisa da ormai parecchi anni a questa parte. Il problema non è la nostalgia dei “mostri sacri” del passato, il problema è la latitanza di nuovi mostri da sacralizzare nel presente. Se rimaniamo a quanto leggo qui sopra, posso dormire tranquillo. Il tipo di aggiornamento culturale e critico che qui mi è proposto posso anche perdermelo. Anche se non sono cosa è la divisione per classi d’intelligenza, avanzata da Raimo, ho l’impressione che nulla di decisivo mi è sfuggito. Dopodiché, è anche utile a volte constatare la difficoltà e la debolezza delle analisi che in un certo contesto si cercano di sviluppare. Quindi, per quanto mi riguarda, trovo il tuo post utile.
Non pensavo di dire delle cose mirabolanti in un’intervista fatta su skype, però forse mi viene da ribadire un paio di robe.
Non facevo un discorso critico sulle forme, che altrimenti ha ragione Inglese, è scontato, ma sulla ricezione: sociologia della lettura.
Un videogioco o una serie tv sono più coinvolgente di un romanzo di Genna o di Falco? è una questione irrilevante in sé, malposta, giustamente Inglese lo dice. ma so che da un punto di vista non solo culturale ma antropologico e persino neurologico, c’è un nuovo pubblico che si è formato sulle serie tv e sui videogiochi, come la mia generazione si è formata sui cartoni animati giapponesi e sui telefilm. (L’idea di cosa voglia dire costruire il proprio romanzo di formazione e quindi di ricezione attraverso i videogiochi non lo descrive Martin Amis nel suo Space invaders, ma Tom Bissell nel suo Voglia di vincere: per me è il libro che farei leggere a Bourdieu se vuole aggiornare la sua Distinzione, oggi).
Questo ha influenzato la fruzione, credo abbastanza ovviamente, molto di più delle teorie di Debord, Genette e Ricoeur messi insieme, no?
A un certo punto alcune di queste serie tv o di questi videogiochi, come qualunque forma culturale sono riusciti a inglobare il lavoro delle avanguardie e a porsi come Nuovi Mostri. Il lavoro di David Simon su The Wire e Treme, per dire, o quello di Charlie Brooker su Black Mirror…
Per il resto rimandavo al libro di Gazoia non per marchetta, ma perché oltre a evocare le questioni, le analizza, ma appunto in un libro e non in un post.
Da un punto di vista dell’analisi non delle forme, ma anche qui della ricezione, credo sia fondamentale
a christian raimo,
tengo per buona l’indicazione Gazoia (jumpinshark), che per altro ho potuto ascoltare con grande interesse in un incontro organizzato un po’ di tempo fa da Nazioneindiana.
Quanto alla necessità di analisi di prodotti culturali complessi come i videogiochi, le serie televisive, e io aggiungerei i film d’animazione anche grande pubblico (di dreamworks o pixar), benissimo, sopratutto se si vogliono mettere in rapporto queste forme di produzione d’immaginario con quelle più tradizionali del romanzo, della poesia, del teatro, ecc.
Il pericolo che io vedo, però, è quello di allinearsi a posizioni tipo quelle di Steven Johnson in un libro come “Tutto quello che fa male ti fa bene”.
Benissimo che un libro così venga letto con attenzione in Italia. Dopodiché converrà costruirsi anticorpi critici appositi nei confronti delle analisi alla Johnson che evacuano completamente la questione dell’ideologia, per tradurre tutto in termini “neutri”, di marca cognitivista, attraverso categorie come “quoziente d’intelligenza emotiva”.
Su questo tipo di discorso e su questo tipo di categorie ci sarebbe un lavoro di analisi critica da fare, non per demonizzare il discorso di Johnson in toto, ma per ricontestualizzarlo dentro una realtà storica e conflittuale dove l’immaginario è una posta in gioco non solo “cognitiva”, ma anche “politica” e “ideologica”.
Quando Christian vedo che butti lì categorie come “classi d’intelligenza” senza nessuna precisazione, mi dico che il gioco è fatto. Che certe categorie sono ormai passate nel discorso ordinario, viaggiano come acquisite, sono prese per buone, senza che su di esse si sia fatto alcun lavoro critico preventivo.
Scusate, è possibile capire di cosa state parlando o è un discorso fra di voi che potete benissimo fare in privato? Non c’era bisogno di intervistare Martina Testa per capire che i videogiochi sono spettacolari, e non c’entra nulla la loro narratività. Resident Evil, tanto per dirne uno, già quando uscì parecchi anni fa con una grafica pessima e con una storia semplice per la playstation 1, era un prodotto che superava in suspence qualsiasi film horror mai fatto e qualsiasi libro horror. è la natura del videogioco, non il modo in cui è scritto.
Francesco, cosa significa considerare la playstation alla stregua di un western? e che diamine c’entrano Debord e compagnia bella?
Penso che più che l’attenzione ai refusi, sarebbe più importante l’attenzione per il lettore. Chiarezza, dunque.
trattasi della nobile arte della masturbatio grillorum: se la eserciti in privato, si risolve in una pugnetta e finita lì; in pubblico, invece, si chiama cultura alternativa
lc
H ancora con sti refusi :-) la questione che sollevavo riguarda la pertinenza o meno di certi modelli di narratività rispetto a quelli più tradizionali. Poichè Andrea parlava di Debord il mio discorso era il seguente: quando il maestro “raccontava” la società dello spettacolo anche attraverso film come Johnny Guitar o con il détournement dei fotoromanzi o dei jingle pubblicitari, di fatto comprendeva nelle proprie analisi ogni tipo di materiale in grado di sostenere una narrazione, che fosse politica e filosofica o letteraria. A me sembra che in questo senso venissero nell’intervista evocati materiali poco immediatamente letterari, come le serie televisive o i giochi delle playstation per una riflessione sullo stato del romanzo e delle cose dette libri. Che l’impatto delle nuove tecnologie sui modelli narrativi sia stato enorme questo credo sia indiscutibile. Quello che di certo sorprende è l’ncapacità, a mio avviso, di far seguire a tali effetti una capacità di analisi e di elaborazione di questi mutamenti. in tal proposito trovo illuminanti gli articoli di Fabrizio Venerandi (l’ultimo è qui https://www.nazioneindiana.com/2014/11/06/quanta-iva-dare-agli-ebook-e-gli-ebook-sono-davvero-libri/ ) sulle questioni relative all’editoria digitale, per esempio. effeffe
Refusing to be amen!
Non credo di aver capito. Ti dico cosa ho capito. Da quando circa sono nato ho appreso il concetto di crisi. Il cinema è in crisi, la letteratura è in crisi. Anche la crisi è in crisi. Ora, in quest’intervista ci si chiede: ma sai, oggi ci sono prodotti così belli che è comprensibile che la gente dedichi più tempo a questi che a leggere un romanzo. E fin qui stiamo grossomodo a un modo come un altro per allontanare l’imbarazzo in ascensore. Può essere un’opportunità per chi scrive, scrivere dei bei videogiochi. Questo però in che modo interessa lo stato del romanzo? è cambiato forse il romanzo? boh. è cambiato il modo di leggere? Questo dipende dalle inclinazioni personali. Io ho passato l’adolescenza giocando ore a calcio e con i videogiochi, oggi leggo Policastro. Vogliamo scriverci un trattato?
Ciò che mi sfugge di più è quanto scrive Inglese, la questione ideologica associata a Johnson e la latitanza dei mostri sacri del presente. Ma credo di avere io un problema con il concetto di critica in sé. Cioè io non capisco la necessità di fare analisi critiche con una prospettiva ideologica dei videogiochi o di qualsiasi altro prodotto culturale. Se qualcuno me la spiega comunque mi interessa. Cioè vorrei che Inglese si spiegasse meglio, anche se so che gli farei perdere un po’ di tempo.
h ti rispondo come posso, cioè dovendo comunque essere sintetico. Mi rendo conto che alcune mie argiomentazioni possano sfuggire a chi nopn condivide certe esoperienze, letture, partiti presi. E’ inevitabile. Non pretendo che il mio discorso valga per tutti.
Vengo ora al merito della tua questione. Una delle questioni più importanti per chi s’interessa di letteratura, e quindi di romanzo (moderno), e quindi di forme narrative, è il rapporto che queste forme narrative hanno con l’ideologia. Ora, se si parla di forme narrative delle serie televisive, o anche dei videogiochi, bisognerebbe porsi queste stesse domande.
Un riferimento bibliografico? L’inconscio politico di Fredric Jameson.
Evvabè, diamo fiducia a jamie. grazie lo stesso
Raimo non è un fine pensatore ma fa il mestiere ed ha un pubblico da soddisfare, mentre non credo che Inglese parli per un pubblico. Per questo, dal primo mi aspetto sintesi spannometriche anche raffazzonate, dal secondo un discorso più rigoroso e profondo. Aggiungo che da over 40 mi diverte più Raimo e chi dai suoi e-book o videogiochi ci tira su qualche soldino, mi diverte bonariamente la necessità di vendere e quindi cosa si arriva a fare e a dire pur di vendere, come e quanto si entra nella maschera del venditore, ecc. Quanto cioè viene perso di proprio per conformarsi al proprio pubblico.
Giusco, ti ringrazio per la “nobiltà” delle aspettative che riponi in me, ma chissà mai perché io dovrei essere rigoroso e Raimo raffazzone, chissàa mai perché io non dovrei parlare per un pubblico, e solo Raimo dovrebbe. La questione è semmai a che pubblico uno vuole parlare. E questo si decide da quello che uno vuole dire. Anche nei tuoi confronti, mi chiedo semplicemente: ma dove sono atterrato? E’ senz’altro un problema mia. Per spiegarmi dovrei mettermi a scrivere un saggio, ma probabilmente quel saggio a te NON divertirebbe. E io, senza dubbio, non mi divertirei a scriverlo per te. Una cosa è chiara Giusco, al di là delle simpatie personali, gli elementi di condivisione che permettono un dialogo, anche estemporaneo, mi sembra manchino. Niente di male, per carità.
Concordo. Suggerisco, per finirla su questo filone aperto da FF, uno sguardo ad Alex Osterwalder e mi taccio. Ciao.
ho perso il filone del discorso, mo
effeffe
devi trovà un buco nero/tornà indietro nel tempo/trasmette messaggi quantistici in codice attraverso i post de valenap/poi ce fai un film e sbanchi/alla faccia de inglese
un filino trop facile pour moi
effeffe
Intervengo solo ora perché il thread è abbastanza lungo da farmi pensare che verrà letto solo da chi ne ha davvero voglia.
a) da editore digitale / scrittore mi sento di dire che la funzione creativa è talmente entusiasmante nel proporre storie che è davvero un peccato che tutto questo debba avvenire in economia di mercato. Le cose che *potrei fare* con l’editoria digitale e quelle che faccio passano per il denaro. Sembra un abc, ma è meglio ricordarlo: fare editoria costa e non è genericamente una delle attività più redditizie del mondo. Detto questo, svolto il mio rammarico di cui sopra, non riesco a non associare gli “incentivi per la cultura” a intellettuali che fanno prodotti ad uso interno senza sporcarsi le mani. Allora fatelo a gratis nelle pause universitarie. Se invece si vuole portare queste storie fuori, è necessario avere progetti per conquistarsi lettori che in genere non ti leggono. Andare dalle “persone non intelligenti”. Un tempo c’era addirittura chi pensava che l’editoria servisse a questo
b) “I videogiochi e i serial tv hanno storie da brivido”. Ora: sto anche leggendo l’ultimo spinazzola, e quando leggo certe cose metto le dita di una mano contro le dita della seconda mano e guardo nel vuoto. E qui vorrei dare una risposta che eviti il rischio marchetta, che non parli di quello che vado facendo da quattro anni, ma è difficile. Ci provo.
–b1) il fine del videogioco è in genere l’entertainment. Il divertimento, l’intrattenimento. La storia narrata (quando c’è) serve per agganciare tra di loro elementi di simulazione di ambiente, anche creativa, o risoluzione di eventi interattivi. Il videogioco non è la forma narrativa del futuro, è nello stesso tempo molto di più e molto di meno. Molto di più perché può essere una sofisticata offerta di ambienti di interazione (vedi Minecraft), molto meno perché alcuni elementi retorici ed espressivi sono esclusi per natura (la noia).
— b2) evidentemente parlare di videogiochi e di narrativa fa più carino che parlare di letteratura elettronica. Non mi spiego altrimenti come il naturale habitat della narrativa e dell’informazione nel digitale venga accuratamente evitato da ogni discorso critico che non sia di settore.
c) Cambia la percezione del romanzo nelle nuove forme digitali? Non so in quale parte del mio cervello, non so nemmeno se abbia a che fare con il digitale o con il multitasking, ma sicuramente l’accesso a narrazioni/informazioni non lineari e granulali, abbia oggi degli scalini di accesso molto meno ripidi di un tempo. Videogiochi, anche, ma sotto al ponte sono passate le avanguardie, sono passati i librogame, le iF e i MUD, è passata wikipedia, e molto molto altro. C’è un vocabolario che in certe fasce delle popolazione è ormai d’uso. Non si tratta di fasce più intelligenti imho, ma di persone che hanno assorbito una serie di strumenti retorici d’uso estremamente contemporanei, che poco poco hanno a che fare con l’oggetto libro.
[Il commento è stato scritto al volo. Eventuali refusi sono indice della genuinità del prodotto]
L’Italia è una repubblica fondata sui refusi
A me pare che confondi divertimento con intrattenimento. Intanto intrattenere è l’elemento fondamentale di qualsiasi opera rivolta agli altri, senza il quale non ci sarebbe alcuna fruizione, né positiva né negativa. Poi è da una parte riduttivo a da un’altra sbagliato affermare che il fine sia il divertimento. L’elemento narrativo può o meno essere proprio di un videogioco, dipende dal videogioco. Un gioco sportivo ne avrà poco, un survival-horror può avercene come un qualsiasi romanzo. Un videogioco ti può far divertire, annoiare, commuovere, emozionare, incazzare, eccitare, impegnare, disperare, spaventare, riflettere, eccetera, proprio come una qualsiasi opera d’arte di altro genere. Ciò che lo rende un po’ differente per ora, mi pare invece il senso di vicinanza con la voce dell’autore che si prova leggendo, quel senso di intimità con un’altra persona dalla quale si sono ricevute delle parole. Ma non è un limite intrinseco.
Ho capito il tuo punto di vista. Mi pare che il termine ‘intrattenere’, in questo contesto, sia abbastanza grigio. Se lo vogliamo intendere come “destinare una parte del mio tempo a fare qualcosa”, allora sì, il prodotto libro, anche saggistico, è un prodotto da intrattenimento. Certamente un certo genere di romanzo ha in sé lo scopo di accompagnare piacevolmente il tempo della lettura. Non so quanto questo paradigma sia applicabile alla letteratura tutta.
Sulla natura del videogioco sono meno convinto. Imho un videogioco, per essere tale, deve prima di tutto impegnare, certamente, ma videogioco che perda la sua parte ludica, diventa qualcosa di diverso, anche per definizione. Se giochi a qualcosa senza che questo qualcosa sia “divertente” in nessuna delle sue parti, probabilmente non stai giocando.
un consiglio ad h, che vedo particolarmente brillante in questo frangente:
un saggio intitolato:
a) Il videogioco come capolavoro letterario
b)Il videogioco come arte del capolavoro
c) Come guarire il cancro, con i videogiochi
d)Videogiocare meglio che vivere
e)Videogiochi e patrimonio architettonico mondiale: 2014, l’anno del sorpasso
f)La democrazia cognitiva minacciata da chi non videogioca
Secondo me si vendono, anche se non correggi i refusi.
Diaologo (breve) di un inglese e di Lara Croft
inglese: As Jameson says, the connection between ideology and literature is born by divine mechanical and… fucking boobs!
Lara Croft: bangbangbnabgnabgbabgnabgbabgnangbabgnabgbangbangbangbangbangbang!!!
Ci sono alcuni refusi nei colpi di pistola…
mica faccio commenti anticostituzionali!
cmq ho sparato a caso, buffo che i primi e gli ultimi siano venuti bene. Vabbè basta cazzeggio, fra qualche giorno m’arriva Jameson, prestito interbibliotecario. Lo leggo, prendo appunti e poi tra qualche tempo ti mando il mio piccolo manifesto “un joypad si aggira per Nazione Indiana” Smack!!
@ Venerandi
Ultima mano di poker/ti sei già giocato mezzo stipendio/se perdi pure questa oltre all’altro mezzo rischi anche di tuo/il gioco continua…
Passo
Non ho capito il riferimento al poker, ma forse è il post prandium. Ne approfitto però per un corollario necessario: non intendevo dire che il videogioco non sia una forma d’arte o di comunicazione al di là del gioco, ma che esista un distinguo tra il videogioco in quanto tale, come sua natura storica, e forme di espressione che usano il videogioco per dire cose. Per fare qualche esempio concreto, penso che molte opere di molleindustria o – di tutt’altro genere – Today I Die, siano opere di narrativa digitale che portano il videogioco ad un livello altro rispetto a quello mainstream di genere. Così, e rientriamo nel campo della letteratura, l’interactive fiction affianca opere di genere a vere e proprie opere narrative interattive dove il “gioco” è un elemento tra altri pari.
a fabrizio,
per quanto mi riguarda, dei giochi in sé, e delle loro caratteristiche narrative, sono moderatemente interessato, invece mi piacerebbe comprendere come un videogioco, a quali condizioni, può essere considerato non una semplice forma di narrazione – quello lo capisco anch’io – ma una forma “letteraria” di narrazione. Immagino, infatti, che in tal caso abbia senso esplicitare parallelismi e analogie tra le caratteristiche letterarie di un testo narrativo e quelle di un videogioco “narrativo”…
Spero di essermi espresso in modo chiaro…
ad Andrea:
la prima risposta, la più naturale è: letteratura elettronica. Il videogioco e, ampliando la visione, la gestione digitale di contenuti narrativi e non, sta dando vita a opere letterarie, espressive, artistiche che sono progettate in digitale e che non hanno niente di affine al libro. Non si tratta di un movimento legato agli ebook ma con radici che coincidono per buona parte con lo sviluppo stesso dell’informatica.
Per risponderti sul punto, ovvero sulla letterarietà del videogioco, vado in tre battute.
a) la prima è quella più facile, ovvero quella che condivide con il letterario il principale fattore espressivo, ovvero la parola. Per motivi tecnico/pragmatici i primi videogiochi (ma anche i secondi) si sono appoggiati moltissimo sulla parola scritta, arrivando poi nei loro sviluppi letterari a livelli di complessità espressiva e narrativa davvero inimmaginabili. Dalle avventure testuali agli ambienti di simulazione sociale come i MU* e poi proseguendo in lavori che lentamente si svincolavano dal “genere” videogioco per assumere una propria autonomia espressiva, come le interactive fiction e hypertext fiction. Esistono in rete esempi contemporanei di letteratura elettronica che possono tranquillamente essere messi accanto a Infinite Jest, quanto a ricchezza strutturale e letteraria. In Italia il lavoro che sto portando avanti con la collana polistorie lavora esattamente in questo campo: mostrare le eccellenze della letteratura elettronica, ludica e non.
b) Che cosa rende un videogioco un’opera letteraria? Prima di tutto il fatto che i creatori dell’opera la programmino pensando di fare un’opera letteraria e non un videogioco. Come dicevo prima, l’interattività diventa un elemento tra pari, all’interno di un ambiente il cui fine non è l’intrattenimento, inteso nel senso primitivo di cui sopra. Da un certo punto di vista, anzi, la letteratura elettronica è meno “rilassante” rispetto alla classica, proprio perché richiede al lettore/giocatore l’interazione attiva propria del videogioco.
c) E se non ci sono parole? La treccani mi insegna: “Letteratura: In origine, l’arte di leggere e scrivere; poi, la conoscenza di ciò che è stato affidato alla scrittura, quindi in genere cultura, dottrina. Oggi s’intende comunem. per letteratura l’insieme delle opere affidate alla scrittura, che si propongano fini estetici, o, pur non proponendoseli, li raggiungano comunque; e con sign. più astratto, l’attività intellettuale volta allo studio o all’analisi di tali opere”. Come può un opera che non ha scrittura essere opera letteraria? Qui evidentemente si applica un’estensione semantica andando a coprire altri media rispetto a quelli basati sulla scrittura; coprendoli insomma con l’odore nobile della letteratura. Un videogioco diventa opera letteraria quando dalla letteratura vada a cogliere gli aspetti peculiari che rendono una narrazione >> letteratura. Cosa distingue un romanzo di genere da un opera di letteratura? La treccani dice il “fine estetico”. Personalmente: credo che una cartina di tornasole di letterarietà sia quella che rileva dove si utilizzi un mezzo espressivo per esprimere/mostrare qualcosa che trascende la cosa detta e il mezzo utilizzato. Dove questo avviene, che sia romanzo o videogioco, si attua uno scarto di cui non è onesto non tener conto.
Grazie davvero Fabrizio: il tuo commento vale in chiarezza, almeno per me, l’intero post qui sopra. In ogni caso, ho copiato e incollato e mi sembra un primo punto di partenza: lezione 1 per profani.
Da qui, due prime osservazioni. Io credo che ci sia un grande fraintendimento sulla questione della “complessità delle strutture narrative”. Ma su questo dovrei rimandare ad analisi più approfondite. Rimanendo, però, nell’ambito strettamente letterario, la complessità dei piani narrativi, il numero dei personaggio, non sono di per sé indizio di “buona letteratura”, di letteratura cioè in grado di penetrare la reale complessità del mondo. William Gaddis, che è un stato uno dei maggiori scrittori statunitensi del secondo novecente, padre spirituale anche per l’eternamente citato Foster Wallace, ha scritto un romanzo straordinario come “Carpentiere Gotico”, utilizzando quattro personaggi e una quasi totale unità di luogo. Quindi qui ci sarebbe un primo punto su cui far lavorare la critica.
Il secondo punto riguarda la necessità di ridefinire la letteratura alla luce di creazioni come quelle di cui tu parli. Ogni nuovo genere e ogni nuova forma letteraria, che s’introduce nel campo di tensioni della letteratura, esige una ridefinizione globale del campo. Mi sembra questo un secondo compito della critica. E’ inevitabile che la cosa prenda del tempo. Ma bisogna anche essere consapevoli che una cosa è la comprensibile promozione di un nuovo genere e di una nuova forma di “scrittura”, l’altra è la comprensione delle sue potenzialità, non solo estetiche, ma conoscitive. Se è letteratura, è una forma di comunicazione densa, un ordigno che rilascia significati nel tempo, e quindi esige tempo per essere compresa in tutta la sua portata semantica…
Il problema è arduo, perché emerge subito fin dalle definizioni più generali e apparentemente innocue come quelle che tu citi e che parlano di “fine estetico”, che è un po’ ovviamente una formula magica.
Ciò detto il problema mi sembra quello di far comunicare meglio questi mondi, in parte sovrapposti in parte no.
Se hai su questi temi dei link da mettere, anche relativi al tuo lavoro editoriale, questa mi sembra una buona occasione.
Per quel che riguarda l’electronic literature, penso siano ancora utili le due collection fatte qualche anno fa dalla ELO:
http://collection.eliterature.org
Sono molto eterogenee, alcune cose imho hanno più a che fare con la visual poetry, ma ci sono anche alcuni esempi davvero interessanti (The Unknow per dirne uno).
Sul versante più ludico penso sia molto interessante Today I Die:
http://www.ludomancy.com/games/today.php?lang=it
…dove il punto di partenza della breve storia interattiva è quello del videogioco, non prettamente testuale, ma che delle parole sente l’esigenza.
In Italia sono da tenere sott’occhio i lavori di molleindustria. Sia i lavori più socialmente virali sia quelli imho a più ampio respiro, come Every Day The Same Dream:
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
A livello di interactive fiction “classica” un giro di Boa è senz’altro Flamel di Cordella, una avventura testuale in cui la parte narrativa ha maggiore indipendenza rispetto alle strutture tipicamente puzzle del gioco (pur non abbandonandole):
http://www.avventuretestuali.com/avventure/flamel/
Sul lavoro di quintadicopertina non posso non citare la collana delle polistorie. Tra i titoli penso siano interessanti per quello che abbiamo detto fino ad ora “Verrà Harry Potter e avrà i tuoi occhi” di Antonio Koch, e “Cuore à la coque” di Mauro Mazzetti. Il secondo soprattutto è un vero e proprio hyper-testo letterario:
http://www.quintadicopertina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=279:verra-hp-e-avra-i-tuoi-occhi&catid=44:polistorie&Itemid=63
http://www.quintadicopertina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136:cuore-a-la-coque&catid=55:cuore-a-la-coque&Itemid=79
Sul versante saggistica, in Italia c’è poco o nulla. Da quando siamo partiti nel 2010 le uniche recensioni e analisi dei nostri testi sono arrivate da appassionati o dalla “critica non ufficiale”. Tra questi è da citare il lavoro di Cinato su Parolata:
http://www.parolata.it/Letterarie/Iperromanzo.htm
Se mi rammarico della scarsa attenzione della critica a queste forme di narrativa, non posso dire lo stesso per quel che riguarda l’ambito universitario. Ho avuto la fortuna di leggere diverse storie delle letteratura elettronica in Italia, dove talvolta i nostri testi sono stati oggetto, sia di tesi di laurea sia di analisi di dottorato, che in alcuni casi sono arrivati alla pubblicazione in saggio. Tra questi, molto lucida l’analisi di Bianca Gai al già citato “Verrà Harry Potter e avrà i tuoi occhi”, che è possibile leggere in Open Access:
http://www.academia.edu/6326169/Ritorno_a_Babele_esercizi_di_globalizzazione_ed._by_Torino_Neos_edizioni_2013_Open_Access_allowed_pages_
Un altra bella analisi a “Cuore à la coque” è in fase di pubblicazione, ma per motivi scaramantici aspetto di vederne la versione ufficiale.
Altro materiale giace nelle università italiane.
un’altra
grazie fabrizio, sei stato generoso in indicazioni
Una bellissima coda di discussione questa con Fabrizio, meriterebbe di essere ampliata in altri spazi.
[…] Queste considerazioni sono un copia e incolla di alcuni messaggi che ho scritto all’interno di un recente thread su Nazione Indiana. Potete leggere tutta la discussione sul sito di NI. […]