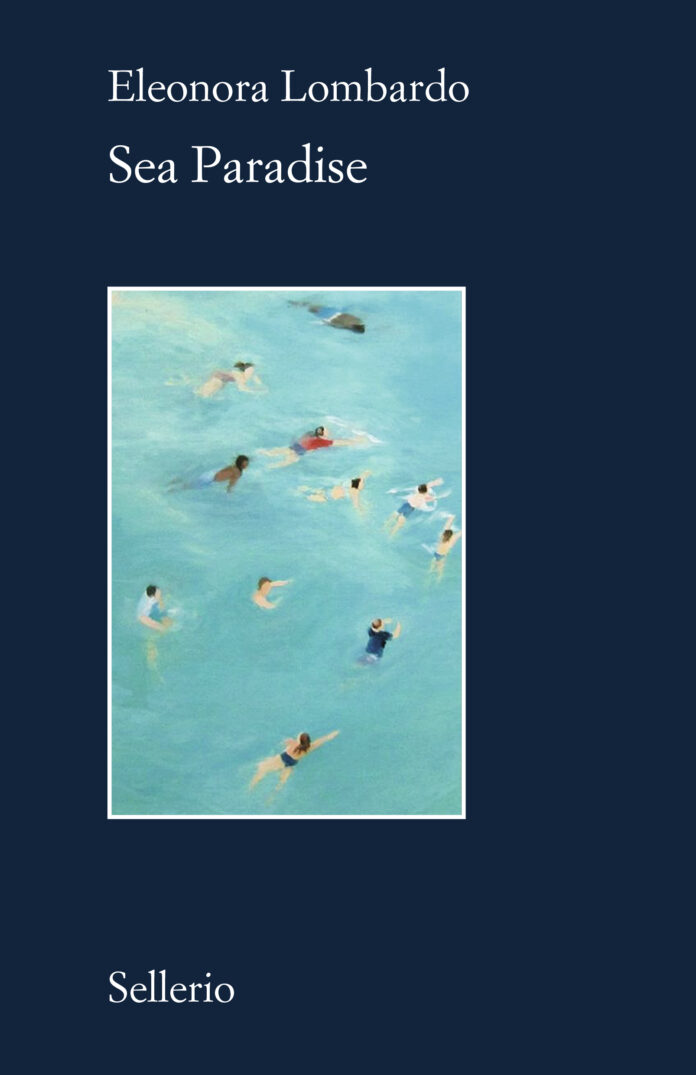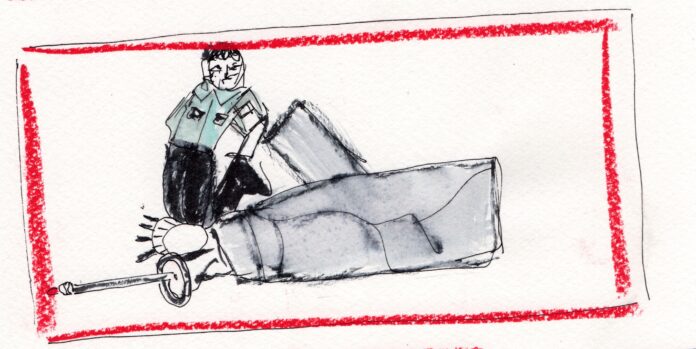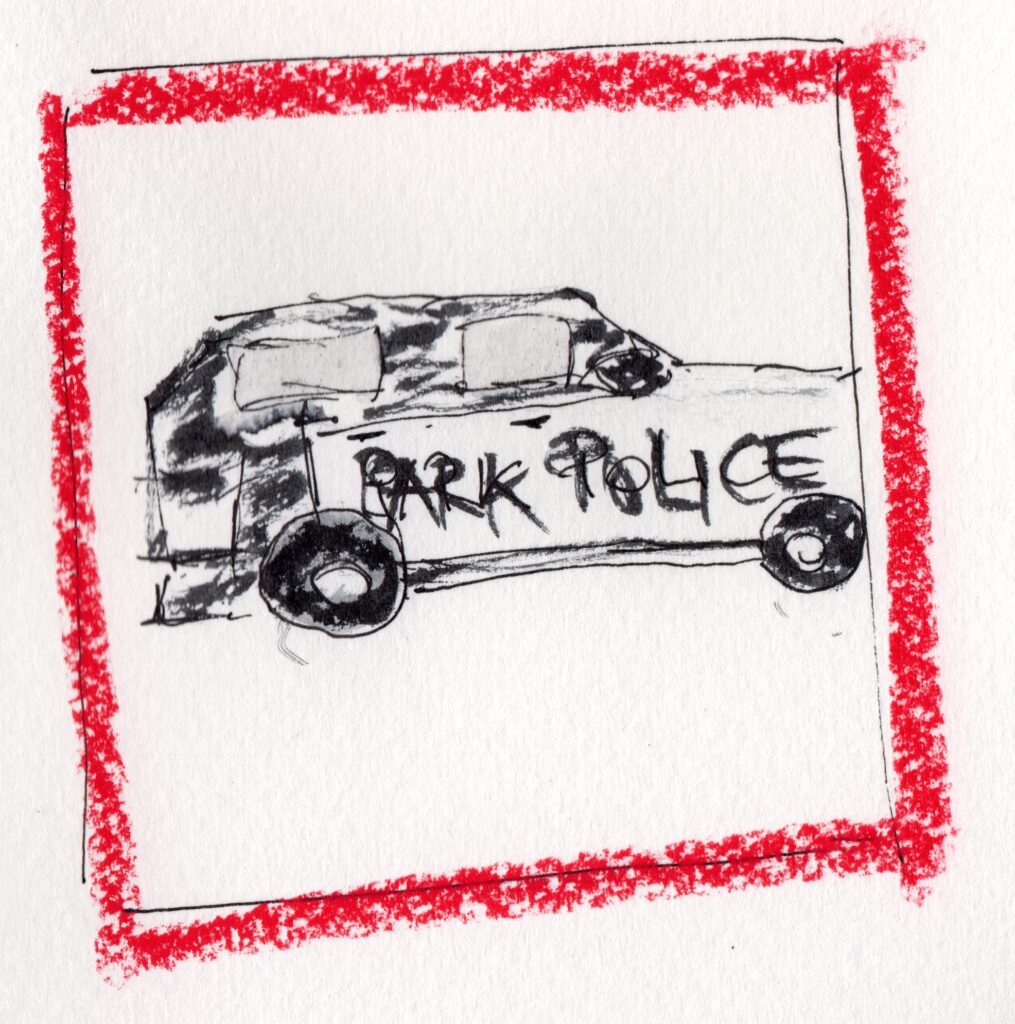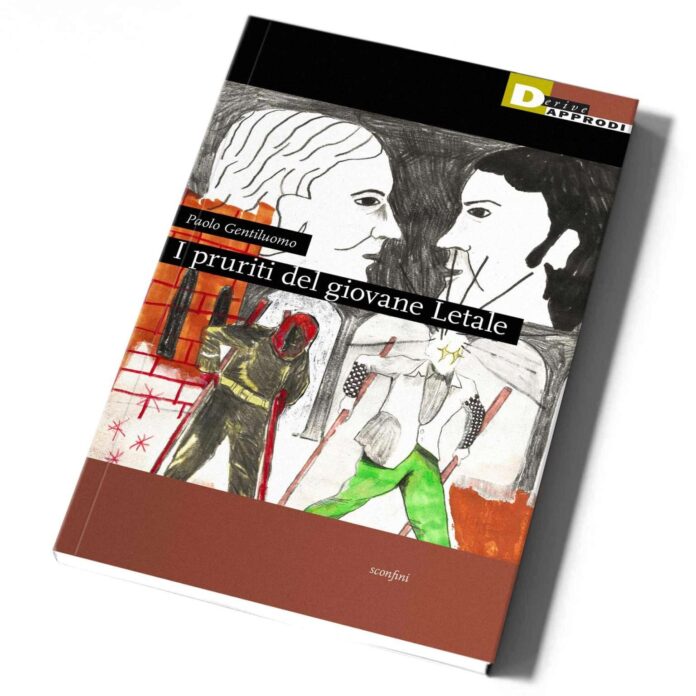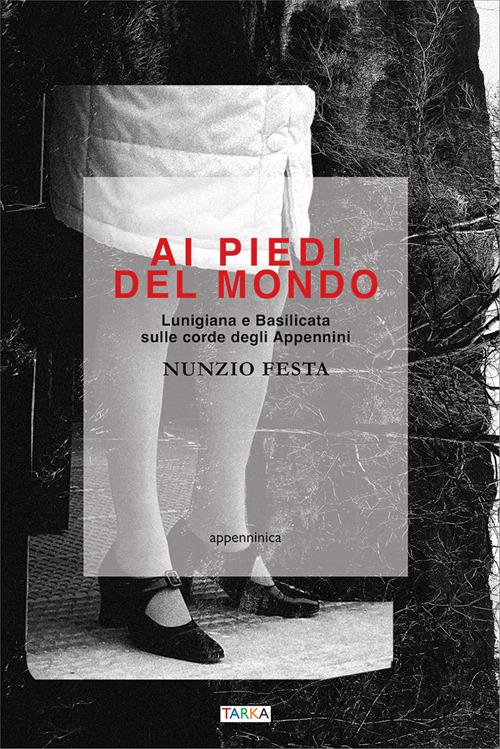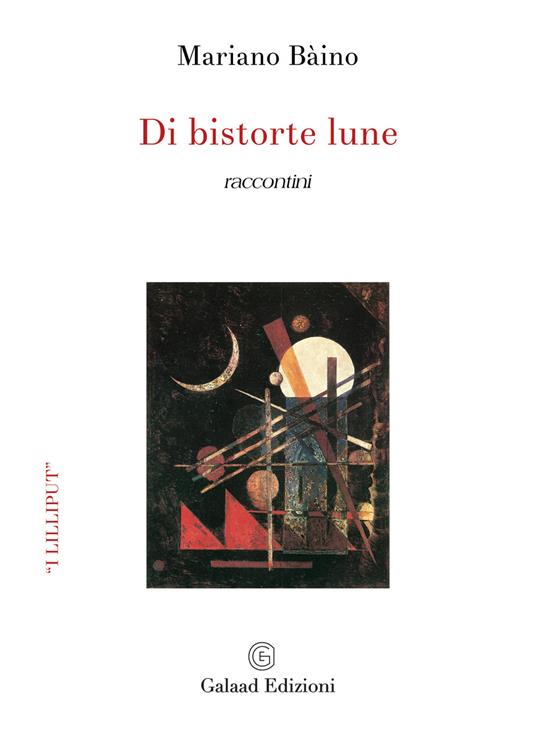di Matteo Cristiano

Al tempo stesso, dare voce alla propria rabbia non può escludere il ricorso potenziale a mezzi violenti: arrabbiarsi per l’oppressione subita implica la rivendicazione della propria dignità. Una dignità che non consente più di accettare pacificamente quanto si è incassato fino a quel momento.
Franco Palazzi, Politica della rabbia
Poco prima della stampa, questo libro avrebbe dovuto portare il titolo di Topi bianchi. Si è optato, all’ultimo, per il titolo che leggete, Figli vostri. Titolo che credo sia effettivamente calzante, riuscito. L’inversione dell’aggettivo possessivo riesce a trasmettere un che di assertivo, perentorio. Io, dopo aver finito il libro, me lo immagino pronunciato a denti stretti alzando la voce. Come se fosse un’affermazione fendente, un rinfacciare una verità scomoda.
Anche topi bianchi aveva il suo perché, poteva essere altrettanto rappresentativo. Compare nel testo all’altezza di un quarto del libro circa, a pagina 58: Rita, un personaggio appena entrato in scena, racconta questa storia:
Rita allora ci racconta che quattro coppie di topi furono rinchiuse in questo paradiso senza pericoli, si moltiplicarono fino a superare i duemila esemplari ma alla fine si estinsero.
“Come è successo?” chiedo.
“I topi più anziani iniziarono a divorare i figli, ecco come è successo” con l’indice ben teso tocca il legno del tavolo. “Gerarchia” un colpo. “Prevaricazione” un altro colpo. “Cannibalismo” un altro ancora».
Gerarchia, prevaricazione, cannibalismo. Ma anche: destrutturazione dei ruoli, incapacità di redistribuire le funzioni sociali. Sono i risultati dei celebri esperimenti di John Bumpass Calhoun svolti tra gli anni ’60 e gli anni ’70 proprio su una colonia di topi. L’obiettivo dell’esperimento era comprendere i comportamenti della popolazione in un ambiente dove gli ostacoli alla sopravvivenza fossero pressoché azzerati (nessun predatore, impedimenti spaziali abbattuti, risorse primarie illimitate).
Many were unable to carry pregnancy to full term or to survive delivery of their litters if they did. An even greater number, after successfully giving birth, fell short in their maternal functions. Among the males the behavior disturbances ranged from sexual deviation to cannibalism and from frenetic overactivity to a pathological withdrawal from which individuals would emerge to eat, drink and move about only when other members of the community were asleep. The social organization of the animals showed equal disruption. Each of the experimental populations divided itself into several groups, in each of which the sex ratios were drastically modified.[1]
In alcuni momenti e spazi particolari della gabbia, la mortalità infantile raggiunse il 96%. Anche in una condizione di illimitatezza di risorse una forma sociale può collassare proprio sulla base dell’ordinamento prestabilito.
Figli vostri però è più calzante perché lo sento molto in risonanza con alcune frasi di Martina Micciché dal suo libro Femminismo di periferia (Sonda, 2024):
Ci danno un nome per potersi dimenticare di noi. Per renderci trasparenti. E noi siamo nelle strade, nelle piazze, nelle case, negli uffici, nelle fabbriche, nelle maglie del mondo sommerso, a ritagliarci uno spazio. A ricordare chi siamo. Che siamo qui. Tangibili, come l’asfalto della città.
Se nel caso del libro di Miccichè il nome di cui si discute è quello della periferia, credo che il nome con cui il centro di potere possa etichettare la storia di Figli vostri possa essere fallit*. Sì, questo romanzo inscena la vita di personaggi che potremmo definire falliti, tutti e tutte. Il primo fattore di rifrazione dell’atmosfera narrativa è il lessico: dalle prime pagine del libro si registrano forme verbali e aggettivi e immagini incentrate sul decadimento. Del corpo, del tempo, dello spirito, della vita, degli spazi. Attraverso il filtro del protagonista, significativamente chiamato Uno, il singolo, la videocamera della lettura ci proietta ambienti sporchi, grigi: «La vecchia testiera sbatte […] il primo piede che appoggio, muove una mattonella che balla. […] I segni di muffa nelle intercapedini dei muri non vanno via neanche strofinando con tutta la forza che ho. Tutto è vecchio e necessita di essere sostituito, l’intonaco del soffitto si scolla con il caldo e il frigo perde» (p. 18). L’ambientazione della storia non è specifica, non è una città localizzata, così come non sono specificate le coordinate temporali. In verità, questo è l’aspetto a mio avviso più limitato della storia: i cronotopi sono leggermente smagliati nonostante siano necessari per il tipo di narrazione. Ma il sacrificio degli appigli narrativi spaziotemporali è compensato dalla focalizzazione interna del narratore: è il mondo di Uno che deve essere rappresentato, perché Uno guarda il mondo con gli occhi del fallito, senza illusioni.
Conviene forse specificare un poco questa categoria: per come lo intendo, l* fallit* sono quegli individui che, secondo le logiche di crescita, di autoaffermazione, di self-made, non agiscono e non raggiungono gli obiettivi minimi di guadagno di capitale sociale (tutto in logica occidentale, chiaramente). Non è una persona che ci ha provato e non ce l’ha fatta, è una persona che è implicitamente impossibilitata a provarci. Non si scia a partire dal basso.
Uno ha perso il padre a undici anni, e anche il padre era questo fallito: «È morto per un tumore pleurico, causato da inquinanti, dopo svariato tempo trascorso in ospedale» (p. 229). Uno ha anche vissuto la morte di uno dei suoi migliori amici, Palmo, morto in un incidente d’auto a diciannove anni. Tutto scorre, ma senza misticismo filosofico: tutto scorre e ce lo si ritrova dietro le spalle senza avere la facoltà di trattenerlo, tutto scivola dalle mani e si dilegua. Ciò che rimane è il nulla, se non l’attesa dell’azione successiva, questo meccanicismo dell’esistenza insensata. Questa atmosfera ha una contestualizzazione, dei puntelli: Uno è laureato in filosofia, ha «letto Feuerbach e Nietzsche, Schopenhauer e Bergson» e pare che di questa filosofia sia rimasta solo la pars destruens, avendo spogliato ogni cosa del suo possibile significato. Ad appesantire ulteriormente il senso di inesorabile perdita e di nullità c’è anche una figura, la prima figura allucinatoria, che è quella di Cioran. Tra i pensatori del Novecento Cioran è sicuramente quello dal nichilismo più radicale e senza speranza, e come tale si presenta a Uno affiancandolo nella sua vita quotidiana, nel viaggio sull’autobus o a casa sua. Cioran è la voce della disperazione cosciente, del compiacimento del senso di morte: si presenta come una figura mefistotelica, accompagnata di solito da una sensazione olfattiva «di stantio, di spazi chiusi» (p. 22), un po’ come il Conoscente di Umberto Fiori, una figura diabolica che conosce l’interiorità del personaggio e ne sobilla l’afflizione, la disperazione: la frase che Cioran ripete a Uno nelle prime pagine è perché continui ad alzarti? Una volta che si svelano le quinte e i cinici meccanismi scenici vengono alla luce, vedendo «le persone che girano già assenti» (p.18), sapendo che «Ti ritrovi a fluttuare nel niente e non sai niente di prima e dopo» (p. 71), cosa spinge ad alzarsi dal letto, ad esistere?
È probabilmente questa la domanda centrale del libro, il quesito da cui poi si svolge la narrazione, una narrazione sospesa tra noir e poliziesco: Uno, che lavora in una redazione di un giornale locale, viene introdotto ad un gruppo pseudo terrorista da Franco, suo collega. Anche Franco, come tutta la banda, ha compreso l’insensatezza dei giorni che passano e delle esistenze rubate, ma sa che la disperazione non è una forma attiva di esistenza. Franco sa anche che per definire degli individui come falliti, c’è bisogno di un centro di potere che nomini, che detti le leggi: c’è quel 99% di popolazione mondiale che vive materialmente e virtualmente sottomessa a quell’1% che detiene il monopolio della ricchezza, e quindi della possibilità. Queste persone non possono fallire perché si sono trovate, involontariamente come tutt*, a vivere nelle condizioni della possibilità. Le loro scelte, i loro investimenti, i loro interessi sono quelli che definiscono la vita di tutte le altre persone del mondo, facendole fallire in partenza, definendo la loro umiliazione d’esistere. Nel primo capitolo, queste persone si trovano con le pistole puntate alle tempie, sopra una dose di GPL altamente esplosivo che metterà la parola fine alla loro condizione di privilegio. Il gruppo in cui Uno viene incluso, sempre per inerzia, ha questo obiettivo: «un’equa rottura dell’illusione, una distribuzione di dolore uguale per ognuno di noi» (p. 137). Il che può sembrare banale, infantile, perché la cultura italiana vive di rimozione delle forme politiche di violenza, per partito preso. Dobbiamo a Franco Palazzi, in Politica della rabbia, una nuova forma di problematizzazione di un sentimento di solito rimosso. Un sentimento che, nella popolazione di fallit*, è stato addomesticato proprio per rendere naturali (la giustificazione più neoliberale del mondo) le forme di subalternità, di subordinazione. Non voglio spoilerare troppo di un libro che si muove per svolte narrative, quello che posso dire con certezza però è che Figli vostri mi pare riesca a sussumere in sé molte delle sensazioni condivise da buona parte delle persone nate dalla fine degli anni ’80: i miti sono caduti, la speranza di un boom di benessere non sussiste perché l’unico benessere di cui necessitiamo è quello psicosociale, abbiamo perduto la capacità di aggrapparci alle narrazioni perché non ci possiamo mai navigare dentro con serenità, consapevolezza e fiducia. Viviamo nella costante sensazione che tutto stia crollando e debba essere costruito da zero, nuovamente. Siamo in tant* ad immaginarci l’esplosione di Wall Street, di Eni, della NATO, degli Stati come li conosciamo, bisognerebbe solo prenderne coscienza. E la creazione artistica, la letteratura (e non specificamente la poesia lirica, come pensava Adorno), è sempre sintomatica, riesce a rendere manifesta con la forza del significante una condizione nascosta. Mi viene in mente, a questo proposito, quello che racconta Kaoutar Harchi, scrittrice e sociologa francese, nella conversazione con Joseph Andras nel volume Littérature et révolution (Éditions Divergences, 2024), «[…] dans la cadre de ma formation sociologique, j’ai été formée dans cette croyance que les choses sont cachées» (p. 36-37), riportando subito la riflessione nell’alveo dell’analisi marxista dei fatti creativi in Lucien Goldmann e in Pierre Bourdieu. Questo, si badi, sempre per chi intende la letteratura come prodotto complesso di reti significanti legate al contesto, alla Storia, e non per chi vede il fatto letterario come essenza del genio creativo.
È un libro da rapportare, a mio parere, a tutta l’animazione dal basso che sta scuotendo Università e piazze italiane e non italiane: la condizione esistenziale di noi fallit* ha riconosciuto la miseria, la noia, l’insensatezza, la subordinazione, ma abbiamo anche scoperto che al contrario di quello che poteva pensare la Thatcher, c’è una soluzione, e la soluzione è lo smantellamento dello status quo, la sovversione dei rapporti di forza. Lo si vede dal Movimento tende in piazza, dalle mobilitazioni contro i CPR, dalle occupazioni abitative, dall’impegno che tutti i giorni ragazze e ragazzi macinano per visibilizzare un genocidio svolto sotto il vessillo della democrazia; la verità è che è l’1% ad essere fallito, il resto lotta per vivere un’esistenza degna. Concludo con dei versi a me cari di Jessy Simonini, poeta, studioso e attivista vicino alle posizioni espresse sopra:
Mi spinge avanti un amore preciso
per chi non ha armi contro il dolore
odio con tutta la forza che ho
per il male che a loro è stato inflitto
[…]
preferiamo scrivere
nuovi e lucidi versi di guerra
lancia in resta nella nebbia
scegliamo un altro campo di battaglia
per difendere il mondo qui giù
mossi dalla rabbia
innestata ovunque
e dall’amore immenso per tutti loro:
i disprezzati dal capitale il cuore
di ogni rivoluzione.[2]
[1] Calhoun, J. B. (1970), Population density and social pathology, «California Medicine», 113, (5), p. 54.
[2] Jessy Simonini, Campi di battaglia, Sensibili alle foglie, 2021, pp. 21-22.


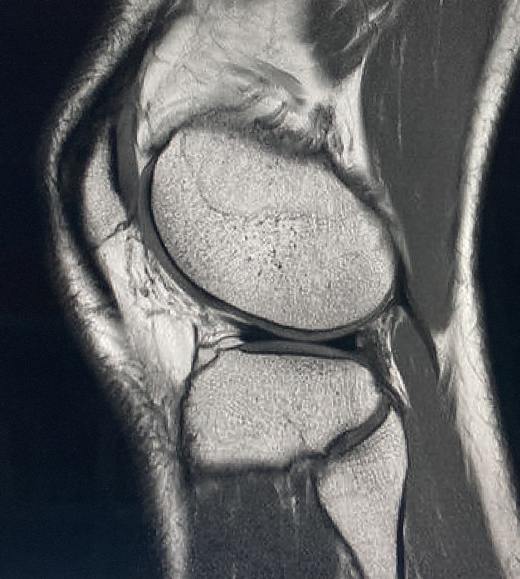

 di
di 

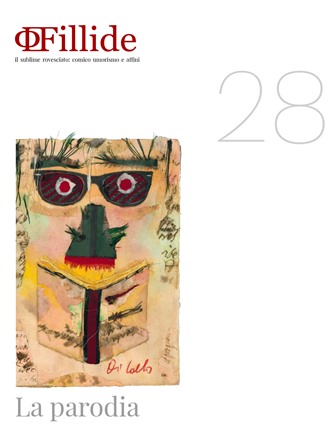








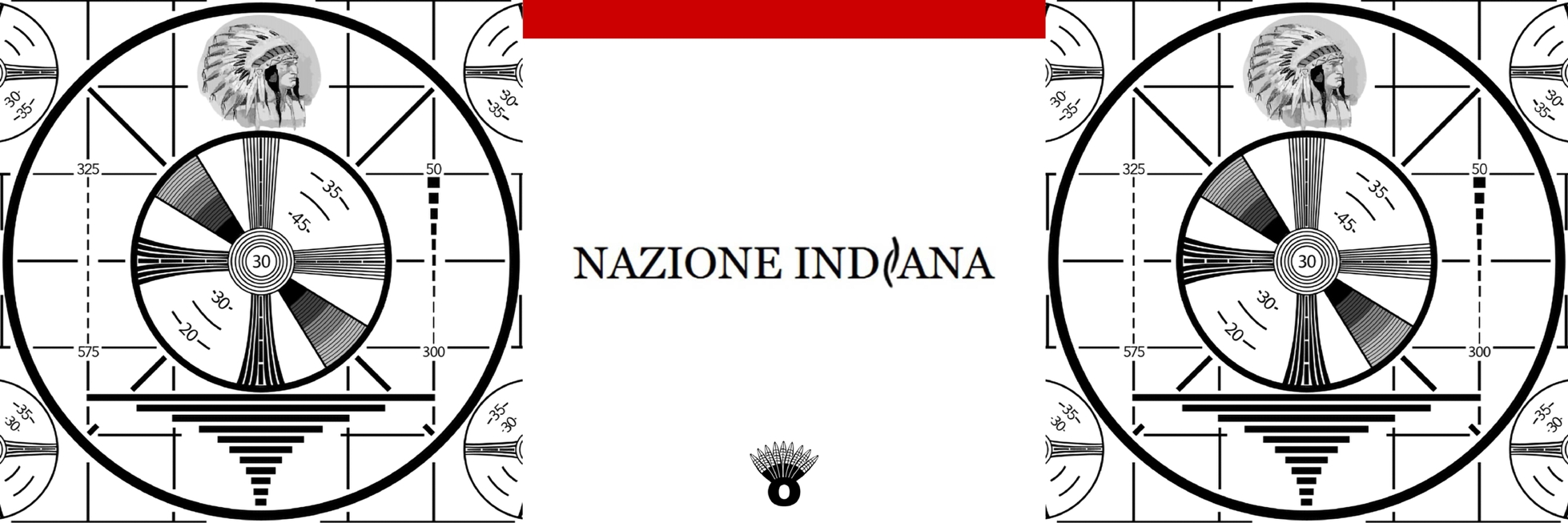

 Il workshop dell’idealista indiperdente
Il workshop dell’idealista indiperdente Si trovava lì grazie al piccolo impianto hi-fi della Pioneer e al primo disco che quel vecchio e da decenni rottamato giradischi aveva fatto girare: Cocker Happy era il titolo, uscito nel 1971. Un album ascoltato fino allo sfinimento, che avrebbe dato la stura ad un percorso capace di portarlo assai lontano da quelle note iniziali, sempre alla ricerca di suoni diversi e poco diffusi. Da quasi cinquant’anni navigava a vista immerso nella musica senza esserne pienamente consapevole, continuando a ricordare gli oltre trent’anni conducendo programmi nelle vecchie radio in FM, come dj durante l’invasione della Nuova Onda e lo tsunami elettronico dei primi ‘90 e da quasi quarant’anni sulle pagine di una storica rivista musicale specializzata in musica indipendente, sempre avesse ancora un senso chiamarla tale. Un percorso di vita votato al lato nascosto del suono che tuttora continuava a fluire dai suoi auricolari, musica ai più ignota, per lo più sconosciuta e recondita elettroacustica il cui ascolto poteva appartenere solo a irriducibili idealisti indiperdenti.
Si trovava lì grazie al piccolo impianto hi-fi della Pioneer e al primo disco che quel vecchio e da decenni rottamato giradischi aveva fatto girare: Cocker Happy era il titolo, uscito nel 1971. Un album ascoltato fino allo sfinimento, che avrebbe dato la stura ad un percorso capace di portarlo assai lontano da quelle note iniziali, sempre alla ricerca di suoni diversi e poco diffusi. Da quasi cinquant’anni navigava a vista immerso nella musica senza esserne pienamente consapevole, continuando a ricordare gli oltre trent’anni conducendo programmi nelle vecchie radio in FM, come dj durante l’invasione della Nuova Onda e lo tsunami elettronico dei primi ‘90 e da quasi quarant’anni sulle pagine di una storica rivista musicale specializzata in musica indipendente, sempre avesse ancora un senso chiamarla tale. Un percorso di vita votato al lato nascosto del suono che tuttora continuava a fluire dai suoi auricolari, musica ai più ignota, per lo più sconosciuta e recondita elettroacustica il cui ascolto poteva appartenere solo a irriducibili idealisti indiperdenti.
 Il workshop si era concluso. Mentre stavano allestendo per il dj set di fine corso intensivo, si sdraiò sulla poltrona del salottino adiacente al bar e iniziò a valutare il suo operato. Cosa era riuscito a trasmettere a quei ragazzi, cosa era riuscito ad aggiungere alla loro passione? Il dubbio era la sua scimmia da sempre, accovacciato sulle sue spalle, continuamente gli sussurrava che non era abbastanza, doveva esporsi di più, mollando gli indugi e lasciandosi andare. Valutò con calma la cosa e giunse alla conclusione che quanto aveva inconsciamente accumulato dentro di sé in anni di scrittura dedicata al suono, in questi due giorni era in parte riuscito a trasmetterlo a quei ragazzi. Poteva riassumerlo in poche parole: conoscenza, competenza, modestia, rispetto, sincerità, sensibilità, immaginazione, forza d’animo e passione che sempre doveva giungere dal profondo. Sentiva l’esigenza di lasciare delle chiavi per poter loro permettere di avvicinarsi alla porta della scrittura: certo un’incrollabile passione, ma anche la ricerca di un proprio stile espressivo, attraverso le parole che evocano, le emozioni che parlano, i fili invisibili che collegano terre lontane, parole e suoni. Ognuno doveva trovare la propria chiave e sapere che era la sua, ed era unica, riconoscibile e riconosciuta.
Il workshop si era concluso. Mentre stavano allestendo per il dj set di fine corso intensivo, si sdraiò sulla poltrona del salottino adiacente al bar e iniziò a valutare il suo operato. Cosa era riuscito a trasmettere a quei ragazzi, cosa era riuscito ad aggiungere alla loro passione? Il dubbio era la sua scimmia da sempre, accovacciato sulle sue spalle, continuamente gli sussurrava che non era abbastanza, doveva esporsi di più, mollando gli indugi e lasciandosi andare. Valutò con calma la cosa e giunse alla conclusione che quanto aveva inconsciamente accumulato dentro di sé in anni di scrittura dedicata al suono, in questi due giorni era in parte riuscito a trasmetterlo a quei ragazzi. Poteva riassumerlo in poche parole: conoscenza, competenza, modestia, rispetto, sincerità, sensibilità, immaginazione, forza d’animo e passione che sempre doveva giungere dal profondo. Sentiva l’esigenza di lasciare delle chiavi per poter loro permettere di avvicinarsi alla porta della scrittura: certo un’incrollabile passione, ma anche la ricerca di un proprio stile espressivo, attraverso le parole che evocano, le emozioni che parlano, i fili invisibili che collegano terre lontane, parole e suoni. Ognuno doveva trovare la propria chiave e sapere che era la sua, ed era unica, riconoscibile e riconosciuta.
 di Laura Mancini
di Laura Mancini