di Silvia Tripodi
Fanno mostra di sé
Mentre fuoco
Mentre fuoco
Serve dimostra
Quanto calore quanta luce
Tra le mani
Dentro di esse
Attraverso i pugni di esse
Le mani sul fuoco
Dimostrate
di Silvia Tripodi
Fanno mostra di sé
Mentre fuoco
Mentre fuoco
Serve dimostra
Quanto calore quanta luce
Tra le mani
Dentro di esse
Attraverso i pugni di esse
Le mani sul fuoco
Dimostrate
di Antonio Bux
(dal ciclo di poesie “Un Adamo di meno”)
IV
Bisognerebbe ricrescere nell’amore
ogni volta che qualcosa lì si spegne
e cercare di strappare poi le ali
alle farfalle prima che si involino
via dallo stomaco; e non invece
lasciarle intatte e ferme su ogni
volto di donna o di uomo
che nasconde in un suo bacio
il verme fingendo nella mela
quel bisogno reciproco di stare
come torsoli nudi e senza semi
nella bocca e nel volto di quell’altro
ignorando il retrogusto della buccia
che protegge nel suo frutto la paura.
È MOLTO TEMPO
È molto tempo che non scrivo una poesia.
È molto tempo che non sparisco in una poesia.
Ora sparisco, e vi scrivo una poesia. Anche se
è molto tempo e non ricordo davvero bene
come si scriva una poesia, però se sparisco
è tutta per voi, una poesia che non so scrivere,
la più bella poesia che potete immaginare,
per voi che sapete leggere tutte le coordinate
provatela a immaginare perché io non so scriverla,
immaginate quella poesia che non c’è eppure vi fa spostare
i polsi e le giunture del cervello, quel tipo di poesia
che c’è e non c’è e anche se scompare te la ritrovi davanti
ogni santo giorno quando non realizzi che ti stai svegliando
e sei già sveglio, ed eccoti la poesia più bella del mondo
scritta sulla fronte, che pure se non ti piace la poesia
la senti nelle budella continuare il tuo fantasma nascosto,
il tuo romanzo da dodici battute, che non sarà mai come
questa poesia, no, il romanzo è un fiato lunghissimo
pure se di dodici battute, ma ha una morale esatta sul punto
mentre la poesia vive col cuore in gola, ed è lì che ti cancella.
Ora vi scrivo una poesia. Una poesia di quelle forti e chiare.
Ve la sto scrivendo, davvero. Anche se non è facile cancellare
poesie. Ed è molto tempo che non riesco più a vivere.
PIOGGIA MENZOGNA
Piove di spalle, mai vista la pioggia
entrarci nel naso e aprire il fiume
del nostro respiro o lo sguardo
ad un oceano più prossimo.
Ma l’oceano meraviglioso del tempo
non esiste, è una bolla di bugie,
nel silenzio ingrossa le sue menzogne,
l’aria fatta di miseria, i pesci falsi,
gli splendori delle lische venduteci
non valgono un odore marcio della terra
quando inzuppata di pioggia ci mente
con tutto il suo coraggio l’inerzia
spettacolare del mistero! Trasportiamo
acque finte per tutta l’esistenza
senza avvertire il profumo
della prima pioggia, quella scivolata
sotto le palpebre secondarie, ma ora è
tardi e si apre meglio l’onda bugiarda,
si apre meglio e mostra il fosforo sbagliato
all’opaca luminescenza, mostra il nostro
meglio diluito mentre ci piove davanti
il mistero della sua menzogna.
CAMICE DI CUORE
Camice di cuore, ho provato a spigare
montagne, ma nessuno le ha volute
comperare. Vendevo nebbie, anche, dal
banco degli ultimi, e le scorie dei campi
per un calice vuoto, di memorie verdi.
Un segnale, è stato meno di questo,
sotto il freddo della vita. È stato dirlo,
avvertire il monsone, il sistema termico
del piano superiore, concentrando aria
di nessuno addosso, costruendo mura
su di noi già fermi. Camice sventrato
senza più cuore, io ho provato a reagire
ma il sole è troppo loro. Io ho provato
a spostare la luce, qualcuno ha provato
a metterla in fiore, ma già sono morti
tutti e niente rimane splendente. Camice
di sangue la mia mente malata prega
sotto la quercia con il verme piegato
nel tronco dell’ombra. Tu sei la cappa
strappata al mio petto, la forza girata
nella mano della semplice elemosina.
La sola moneta a valere te è l’attesa.
D’IMMAGINE MIGLIORE
Ho immaginato di avere: una casa
e il fiore della casa e una donna
con accanto un mestiere
solo per me e nel bacio
la morte del frutto e il colore
saporito dell’erba, la mia fronte
cresciuta per lei e ancora e ancora
senza mai fine, l’aria fidanzarsi
negli sguardi e ossidarsi un pensiero
sarà vero, sarà vero… ma l’occhio
è cresciuto per poco, è tornato
bambino cristallo si è rotto
il mio occhio immaginario
immaginandosi troppo ma non c’è
più nessuno che piange
per me nessuno a cui tendere
la mano… sarà vero, sarà sogno
più vero svegliarsi e guardare
nel vuoto se il vuoto è lo sguardo?
Ho immaginato di avere: qualcosa
da guardare, una mano cresciuta
sul cuore una mano più grande
pensare per me, la mia vita
veramente stretta nel pugno; ma
ho immaginato lo stesso, qualcuno
con me a immaginare, più niente
se niente è reale, se io vivo di questo
per te che non sai immaginarmi.
UNA SOLA NOTTE
Ogni volta che passo il varco
della notte, una solitudine mi vede
espandere un’altra notte precedente,
ed è un futuro a non promettere
più niente, a tenermi così stretto
ai miei luoghi ciechi; eppure io
così cieco vedo quel luogo dove
qualcosa vive, ma sento nuove vite
in cui ero già stato; e forse non è tutto
vero ciò che cresce, forse continua
solo per distanziarsi; forse è crescita
bugiarda ciò che nasce o per davvero
l’unica risposta il buio più dentro; forse
è scia che non centra l’energia o il vento
attraversando corpi ottusi forse è scia
di un’altra vita che poi cambia tutto: viene
e non restituisce, la scia ciò che fulmina
la notte; viene e non rivive me più di una
volta, la notte viene in me e non mi vive
solo una volta, ma viene sempre la notte
e perde me da quella volta, da sola viene
dentro me la notte, senza di me a vedermi.
LETTERA AD UN FIGLIO NON MIO
Precipitano i livelli, se stai a pensarci
l’economia ti fotte gli anni, figlio non mio,
i migliori schieramenti, i personalissimi
giochi e gli sguardi degli amici, se ci pensi
non riconosci più nessuno ora che la fila
si è fatta lunga, ora che le tende le tirano tutti
fino a strappare il sorriso rimasto fuori
dai tagli statali, e siamo in tanti ad avanzare
senza il ricordo di un sorriso, siamo in molti sorridenti
per indifferenza verso la felicità, lo sappiamo bene, figlio,
non esiste la felicità, è solo un marchio non registrato
dalle società delle cioccolate fondenti, eppure sorridiamo
come catalogati, assortiti in uno strano giorno di cioccolata,
squagliamo cervelli tra bustine inzuppate e specchi sozzi,
e le polverine magiche che ci fanno sorridere e piangere chiodi
se ci abbracciamo con un amico sentiamo le spine
dell’indifferenza infilzare l’identità della potente droga, lo stato
vuole questo, sentirci indifferenti alle infilzate. Impara presto,
figlio non mio, il nuovo sorriso, impara a prendere puntuale
la pillola della dimenticanza, sì, figlio non mio, dimentica
il sorriso che ti ho negato, restatene nella pancia infilzata
della mamma, io non ho droghe migliori né cioccolate più dolci,
io non ho regali lucenti, né specchi sicuri, io ho solo paura
di vederti sorridere.
(dal ciclo di poesie “TSO”)
II
Si sono chiamate da sole le spiagge,
appartate in un unico sentire più sole,
più sole nonostante i paesani lombrichi
e così i boschi e le calunnie degli alberi
fiorire sempre verdi, sempre distanti
a un certo punto della distanza
è accaduto che si è fuso il perdono,
e che l’oro colato non si è fermato
al piombo sbagliato della sostanza, no
ma che per confusione l’attacco finale
incominciando a deridersi, ha disunito
cicatrici già sparse per il globo spaccato
e la carnagione della terra con pezzetti
spinosi di cielo, e l’hanno fatto male davvero
l’uomo di poca volontà, eccolo ferito stride
finalmente da sveglio, aperto all’emozione
bianca come sfumato dal suo cadavere,
e stride in quell’attimo, per sempre, fermato
nell’ascolto perpetuo del rumore selvatico,
avverte l’ondata che non può ferirlo ma solo
fermare il suo stridere a tempo. Perciò si è
chiamati da soli, risposta, senza sapere
come il bosco nel buio riposi, e le spiagge
sibilline sparendo nel vano del mare come
disteso un ognuno da solo, potendo l’ascolto.
VI
Ma io vorrei leggere davvero i semi
se sono veri quelli dell’autunno invece
mi trovo sempre solo in mezzo a steppe
di amici e a mani fredde eppure nessuno
muore col sorriso appeso alla sorte della
memoria universale se ci pensi arriva fino
ai primi anni quel prodigio familiare poi finta
la retromarcia se ti sgama dentro sé fa nebbia
prima ancora dell’adunata generale si dirada
la sua voglia di sbocciare tra i due bronchi
della notte sussurrata a poche mani. Ma è
miracolo così chiaro esserci ancora sebbene
qualcuno voglia fare fuori noi mentre svegliamo
i simboli del corpo e sono gli stessi della mente
li vediamo così chiari eppure spegnersi di colpo
così uccidono le ore e la tranquillità di ogni vita
fatta di stracci e di illusioni, dietro schermi tutti
uguali stando bene senza riflessi, se ci pensi
noi accadiamo non nel tempo però nessuno
viene a dirlo. Se te ne accorgi loro sanno che
tu sei morto camminando senza piedi. Però
non interessa più alla gente ricordare la paura
perché paura è troppo forte da temere allora
meglio aver paura di sapere forse è vero che da
un certo punto in poi l’oro diventa marcio sincero
se la sola cosa a tenere in vita è l’indifferenza io
riscrivo la sentenza: se mi lancio, fingo di cadere.
NESSUN POTERE
Non avete nessun potere. Oltre lo sguardo,
non avete nessun potere. C’è un muro bianco
di fianco che aspetta, tutti aspetta e non cresce
e non crolla, ma è uguale per tutti, è distanza
di ognuno, per un po’. Contro quel muro, tu non
hai nessun potere. Sembra temere solo lo sguardo
il tuo muro, sembra temere solo il riflesso di te
che ti muovi in silenzio. Eppure tu non hai più
nessun potere. Tu sei solo il tuo muro distante.
Però nessuno ha il suo potere, più di te se sai
di essere muro, oltre il tuo sguardo nessuno
sa di essere te, senza scavalcare il potere del
muro di ogni essere solo. Quello è il vero potere.
NON È PER TUTTI
Esiste un mattino ma non è
per tutti. Si alza da sé cresce
un volo di rogne. E non è per
tutti. Non è per tutti sapere
il mattino, alzare una specie
di nebbia in qualcosa quel livido
dove ognuno può riconoscersi. Ma
non è per tutti. Non tutti possono,
non tutti sanno il mattino, non a
tutti è dato capire se il cielo è un bel
velo, se davvero riflette o se esclude. Però
perché dire il falso? È per tutti lo stesso
cielo a squarciare, è per tutti uno sbalzo
nel nero o soltanto il gelo della promessa
se per tutti vale la sfera, il mondo girato
nella mano nemica. Se per tutti è straniero,
meglio si dica: non contate più troppe stelle.
Ma no, non è per tutti, se il mattino dirada
le piogge se le nuvole atrofizzano i volti se
l’aurora non finge e mostra la terra. Non è
per tutti se ritorna a costringere il buio al suo
specchio, se si mostra più caldo e se apre
nel ventre la voragine umana. Se la notte
combacia i silenzi, non è per tutti starsene
zitti. Allora cresce ancora in miseria, da una
scatola nera l’ombra terrestre. Quella è per tutti.
COLORE DEI CANI
Vorrei piangere con i miei amici
almeno una volta essere come loro
al fischio della chiamata. Così
da perdermi l’esecuzione
ogni giorno, quando i miei cani
diventano neri e se ne vanno
senza più strada. Ma gli amici miei
piangono dopo, se poi rimangono
un po’ più da soli, i loro cani
ancora al guinzaglio, questi lo sanno
di che colore è la fuga.
_____________________
(da “Un luogo neutrale” Edizioni Il Foglio, collana curata da Cinzia Demi, Piombino, 2015)
di
Seia Montanelli
Era una notte buia e tempestosa, quella del 16 giugno del 1816 in Svizzera. Quell’anno fu chiamato “l’anno senza estate” a causa dell’eruzione di un vulcano in Indonesia che causò mutamenti climatici in tutto il mondo, anche se all’epoca nessuno poteva immaginarne la causa. E un gruppo di giovani amici – il poeta Percy Bysshe Shelley, la sua fidanzata nonché scrittrice Mary Godwin (poi Mary Shelley), Claire Clairmont, la sorellastra di quest’ultima e amante incinta di Byron, e lo scrittore John W. Polidori – si ritrovarono a Villa Diodati, la residenza di Lord Byron vicino Ginevra, immersi in un’atmosfera plumbea, squarciata da lampi e tuoni, alla sola luce di candele, in un contesto quasi spettrale.
E cosa c’è di meglio per passare il tempo, che leggere delle storie di fantasmi? Meglio ancora se di origine tedesca: “german” a quel tempo veniva infatti utilizzato proprio come termine per indicare racconti di stile gotico; inoltre – per l’allure romantica di cui si ammantava in Europa, dopo lo Sturm und drang, ogni cosa che venisse dalla Germania – il fatto che i racconti fossero tedeschi era garanzia di maggior terrore.
Scrive Mary Shelley; «Ci capitarono per le mani alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotte in francese dal tedesco». Le fa eco Lord Byron dai suoi scritti: «Questi racconti risvegliarono in noi un giocoso desiderio di imitazione», tanto che quando questi propose di scrivere ciascuno una storia di fantasmi tutti accettarono di buon grado: da quelle serate di lettura e scrittura a lume di candela nacquero, qualche anno dopo, “Frankenstein” di Shelley e “Il vampiro” di Polidori – precursore del più famoso “Dracula” di Stoker.
Nessuno dei presenti cita direttamente il libro da cui hanno tratto ispirazione, ma non è stato difficile risalire a un volume, “Fantasmagoriana. Racconti di fantasmi”, pubblicato anonimamente a Parigi nel 1812, dal geografo poliglotta e autore di libri di viaggio Jean Baptiste Benoit Eyries, che nella prefazione al volume lo annunciava tratto da un arcano manoscritto, come spesso accadeva per i libri che si voleva coprire di mistero.
In realtà si tratta di otto racconti a tema soprannaturale scritti da autori tedeschi di fama poco ragguardevole, dalla fine del settecento ai primi dell’ottocento, ripubblicati pochi anni prima in diverse antologie. Tutti avevano in comune dei riferimenti agli spettacoli di “fantasmagoria” che spopolavano all’epoca nei teatri e nelle feste cittadine: ossia quei giochi di luci, immagini e suoni che si ricavano proiettando, su muri o schermi semitrasparenti, immagini spaventose in movimento tramite una versione modificata della lanterna magica (anticipatrice del cinema).
Dopo duecento anni, quei racconti sono stati raccolti per la prima volta e pubblicati di nuovo tutti insieme in un unico volume curato e tradotto da Fabio Camilletti, professore associato di Letteratura italiana all’università di Warwick nel Regno Unito, dalla Nova Delphi Edizioni, accompagnati da un notevole saggio introduttivo dello stesso Camilletti, che dedica ampio spazio proprio alla fantasmagoria.
Questi fenomeni di apparizione e sparizione tipica delle fantasmagorie più evolute tecnicamente, si diceva, sono alla base dei racconti riuniti in volume da Benoit Eyries: il gioco di luce e ombra è quasi lo specchio della dicotomia tra vita e morte messa in scena nelle storie, per non parlare dell’importanza della suggestione che deriva dal non riuscire a definire bene i contorni di ciò che è reale e ciò che è invece soprannaturale o pura manipolazione.
I testi, geograficamente localizzati quasi tutti in Germania orientale, hanno in comune anche la matrice orale delle storie che raccontano: spesso riproducono la stessa situazione della notte a Villa Diodati, con un gruppo di persone riunite in un salotto che cominciano a raccontare episodi di cui hanno memoria o che a loro volta hanno appreso da altri, in bilico tra realtà e mistero, sospesi tra la suggestione che li porterebbe a credere a quanto hanno sentito o visto e la ragione che li induce a dubitare, tesi a spiegare – senza riuscirvi – l’arcano con il naturale.
Sono racconti che risentono del tempo che passa, ma – come non ci si può approcciare a una macchina d’epoca aspettandosi le prestazioni di un moderno Suv – allo stesso tempo è necessario calarsi nel tempo e nel luogo a cui essi appartengono. E se si è privi di preconcetti non è nemmeno così difficile, perché le storie di fantasmi – tedesche, inglesi, francesi che siano – da sempre soddisfano due grandi bisogni dell’uomo. Anzitutto, l’urgenza di raccontare (e, paradossalmente, più il racconto è fantastico più c’è gusto a far pendere gli altri dalle proprie labbra); ma pure la necessità di esorcizzare la paura della morte, di sconfiggerla quasi, inventando un aldilà molto attivo e in costante comunicazione coi vivi. 
Non parlerò di nessun racconto in particolare perché tutto concorre alla suspense e la suspense è tutto in queste storie. Accenno solo alla presenza del racconto “La sposa cadavere” di Friedrich August Schulze, da cui ha tratto ispirazione Tim Burton per il suo film di animazione, ma anche la stessa Mary Shelley quando ha pensato a una compagna per il suo Frankenstein.
Interessante quanto i racconti, e per certi aspetti forse di più, è il saggio introduttivo con tutte le note a margine di Fabio Camilletti: un vero trattato sul racconto gotico in Europa, che dalla letteratura spazia fino alla psicologia e alla storia.
In conclusione, in questa estate torrida che confonde e smarrisce, consiglio questo volume dal sapore antico, quale metodo validissimo, che si stia al mare o in città, in montagna o “fissi al chiodo” a lavorare, per procurarsi dei brividi di letterario piacere.
I
Coloro che hanno certi pensieri in un certo composto modo siedono
come se le ossa fossero intenzioni o segrete speranze
una lettera pubblica promossa da Evelina Santangelo e Fabio Stassi
L’accesso al mare alla tonnara di Scopello è uno spazio piccolo e scosceso, ma su quella stretta banchina di fronte ai faraglioni si stanno concentrando molte e grandi questioni: una certa idea del privato e del pubblico, il diritto di usufruire della bellezza e il modo di preservarla, lo scontro tra memoria e oblio, l’uso del pregiudizio e il capovolgimento delle informazioni.
di Gianni Biondillo
David Nicholls, Noi, 430 pagine, Neri Pozza, 2014, traduzione di Massimo Ortelio
Douglas e Connie sono una coppia di mezza età che sta programmando una vacanza memorabile, l’ultima prima che il figlio adolescente Albie vada a studiare al college. Una sorta di Gran Tour che lo educhi al bello e alla vita. Douglas ha programmato tutto fin nei minimi particolari, com’è tipico del suo carattere, minuzioso, previdente, razionale. Ma una sera, prima della partenza, Connie confessa al marito la sua intenzione di lasciarlo dopo l’estate. Come è ovvio tutti i piani di Douglas dovranno essere rivisti: non più un viaggio d’iniziazione, ma l’estremo tentativo di riconquistare l’unica donna che ha amato nella vita.
Non si creda, date tali premesse, che David Nicholls con Noi scriva di un avventuroso viaggio picaresco. In fondo la descrizione del gran tour che ci fa l’autore – i protagonisti partiranno, non ostante tutto – non è memorabile. Noi non è una narrazione di viaggi. È, semmai, un romanzo sulla piccola borghesia contemporanea. Douglas è l’emblema della meschinità borghese anglosassone: studi scientifici, incapacità a capire i gesti istintivi, desideroso solo di costruire una vita sicura per la sua famiglia, colmo d’ansia per il futuro incerto, apocalittico. Connie, a contraltare, è una donna che, sopite le esuberanti passioni artistiche giovanili, ha vissuto la sua normalizzazione con pacata insofferenza. Il risultato è un figlio stralunato, inquieto, desideroso di cercare la sua strada, fuori dai lacci, dalle convenzioni del suo ceto sociale.
Il romanzo, raccontato in prima persona, segue in parallelo le sorti di questa vacanza fallimentare e, in flash back, come due giovani diventeranno negli anni marito e moglie. Vivendo e amandosi mediocremente.
(precedentemente pubblicato su Cooperazione, n° 6 del 3 febbraio 2015)

di Cristiano Denanni
Mia madre beveva lo Xanax alla spina. Non era tutta in riga, ti diceva vado a letto e usciva a fare la spesa, ti diceva esco e accendeva la televisione, ti telefonava alle sei di sera e ti chiedeva stai dormendo?
Mio padre invece è orgoglioso di me. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. Chissà perché le donne dicono raramente la parola orgoglioso, boh.
Mia madre diceva parole tutte di vocali. E si nascondeva negli angoli bui, guardava di sbieco da dietro le porte, sembrava che tutti fossero ladri, che volessero derubarla spogliarla rapirla.
Mio padre è orgoglioso di me. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. Chissà perché.
Mia madre l’ho ammazzata con delle forbici in gola, qualche anno fa non ricordo quanti, un pomeriggio d’estate che il sangue e il sudore si mischiavano sul collo.
Mio padre è orgoglioso di me. Cioè non perché ho ammazzato mia madre, penso, non so. Però me lo dice sempre. Da quando sono un bambino. Non gli ho mai chiesto perché.
Io invento parole che mi piacciono. E poi le spiego a chi non sa cosa vogliono dire e le uso. Che le parole servono sennò cosa ci stanno a fare.
Mio padre è orgoglioso di me. Anche se non capisce tutte le parole che gli racconto. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. E io mi fido.
Raffaella mi parlava come se io non ero matto. E mi portava a fare passeggiate, mi abbracciava quando pioveva, mi raccontava di quando era bambina, le raccontavo anch’io.
Io invento parole come alberopoli, che è una città fatta tutta solo di alberi. Oppure pancavola, la preferita di Raffaella, le spiegavo che è una panchina che quando ci sedevamo noi due non stava più ferma.
Mio padre ogni tanto lo vedo piangere. Da quando ero un bambino. Non mi dice mai perché. Però io credo che è stanco. Figurati, a volte lo sono anch’io.
La mia preferita è Raffaellitudine. E’ la mia pazzia per Raffaella. No non quella là. E’ quella bella, che se non c’è non ci sono nemmeno io. E’ la mia terra, il mondo insomma. Il posto dove devo andare. Il posto dove devo stare.
Io fino a poche settimane fa ero in un OPG, non so se sapete che cos’è, vuol dire Ospedale Psi.. qualcosa… e giustizia… o giudizioso… non ricordo… Comunque è uno di quei posti dove mettevano le persone che avevano fatto una cazzata e non potevano metterli in galera perché erano malati con la testa, matti insomma, matti. Ora li hanno chiusi, ma non è che non ci sono più matti, è che là dentro sembrava di stare in una prigione e alle volte ti torturavano quasi e poi con la scusa che sei pericoloso diventavano pericolosi quelli col camice bianco al posto tuo e avevano la scusa per non farti uscire più. Io dovrei starci ancora ma adesso sono con mio padre e sto per andare in galera anche se stanno facendoci aspettare perché non sanno bene dove stiamo meglio, in quale immondezzaio, quindi passo qualche giorno controllato dai carabinieri e assieme a mio papà, quello orgoglioso di me da quando sono un bambino anche se non so ancora perché.
Adesso costruisco oggetti con petali di fiori o con il fil di ferro. Sapete, quei lavori che fanno i coglioni. Ho cominciato nell’OPG. E come sempre invento parole che mi piacciono. E poi scrivo. Scrivo lettere ai morti, che tanto se le scrivo a uno vivo e poi non mi risponde ci rimango male, allora faccio che scriverle ai morti così so già come andrà a finire. Mi diverto, sapete?, più con le lettere o con le parole inventate che a fare orologi o posacenere col fil di ferro, ma il tempo passa e dicono che così costruisco qualcosa, a me non sembra di fare cose belle, e non sono nemmeno utili perché un posacenere coi petali dei fiori brucia subito, e col fil di ferro va tutta la cenere fuori, ma da tenere lì vanno bene. Io alcune cose le do a mio padre da portare a casa che in ospedale rubano spesso e poi il fil di ferro non lo posso tenere che è pericoloso è pieno di matti là dentro allora mio padre porta quelle cose a casa e le mette lì. Il mondo è pieno di cose messe lì. Anche di persone messe lì. Come me. Come tante altre, anche, che credono di essere chissà chi e invece sono solo messe lì. Io poi coi petali faccio anche quadri, come se dipingessi mettendo vicine forme diverse e colori diversi dei pezzi di fiori, tutti su fogli bianchi o su fogli di giornale dipende da cosa trova da portarmi mio padre che è orgoglioso di me e me lo dice sempre da quando sono bambino, dice sono belle le mie opere io non so cos’è un’opera però se è orgoglioso mi fido, così dicevo che coi fiori disegno cose o paesaggi, una volta ho provato a fare una faccia, la faccia di Marlon Brando che mio padre c’ha un poster a casa e me lo sono fatto portare, la faccia di Brando con tutti quei fiori sembra una pietra fatta di foglie, e la faccia di mio padre quando l’ha visto sembrava stanca.
Mia madre si è giocata tutto quello che aveva. Al gioco, proprio. Per quello dico giocata, mica dico per scherzare. Aveva una casa grande e l’ha venduta per una più piccola perché diceva che tanto per noi due era fin troppo e i soldi che le erano avanzati erano spariti in poco più di un anno, poi era andata in pensione e aveva preso la liquidazione, che aveva lavorato da quando aveva quattordici anni e dopo un anno i soldi erano finiti, poi si è fatta prestare un sacco di soldi da parenti amici banche e ora erano finiti da un bel po’ anche quelli e andava avanti solo coi debiti, che per riuscire a pagarli si era venduta tutti i braccialetti gli orecchini gli anelli le collane l’oro l’argento e le tazze, solo che anche quelli erano finiti, e piangeva piangeva piangeva, era una donna bella quando era giovane e ragazza, io mi ricordo che vedevo delle foto di quando ero bambino abbracciato a lei e dicevo ma chi è quella sventola e poi mi accorgevo che era mia madre e chi poteva essere sennò nelle foto con me da bambino, poi era diventata vecchia e rincoglionita, ma proprio tanto, e si era rovinata la vita e l’aveva rovinata anche a me e non era neppure più bella anzi, da vecchia sembrava proprio vecchia, cioè era vecchia ma non è che sembrava più giovane come quando era più giovane ma ne dimostrava comunque sempre meno, no da vecchia ne dimostrava anche di più. Meno male che io sono cresciuto a casa della nonna e del nonno, che il nonno rompeva le palle come tutti gli altri ma mia nonna no, cioè le rompeva ma era proprio brava io le volevo bene, mia nonna al contrario di mia mamma viveva, cioè nel senso che magari faceva fatica era stanca era tutta acciaccata ma viveva, cioè nel senso che le piaceva vivere, ci teneva voglio dire, sì insomma ci siamo capiti, ci credeva, alla vita, voglio dire, ci credeva, bisogna crederci no? Infatti quando faceva le pulizie parlava ad alta voce, contava con le mani e diceva i numeri sottovoce, scendeva per fare la spesa e tornava con la pizza, cambiava le lenzuola e stendeva quelle appena lavate, le stendeva sul balcone come se era un prato, mia nonna mi portava a tagliare i capelli dalla signora di sotto che li tagliava in casa, e quando attraversavo la strada sotto casa mi guardava sempre dal balcone, d’inverno faceva il minestrone e d’estate i frullati con pesche e albicocche, e poi faceva sempre la crostata di amarene che era la mia preferita su tutto e su tutti, che quando adesso qualcuno la fa e l’assaggio dico hmmmm buonaaa… ma mi fa cagare, mia nonna le piaceva cucire, faceva l’uncinetto, mi guardava attraversare e faceva l’uncinetto, una volta ha fatto una tovaglia rotonda, copriva tutto il tavolo del salotto, quello dove facevamo i pranzi di Natale non so se mi spiego, le avevano offerto due milioni ma lei non l’aveva venduta e aveva fatto bene non era ricca anzi ma mica puoi venderti la vita come mia madre, una volta una cosa che aveva fatto con l’uncinetto l’aveva messa sopra la televisione per farci stare sopra il vaso dei fiori, eh… che la sua vita era stata lunga ma soprattutto difficile povera nonna, la guerra la fame il sud i figli il marito i nipoti la lontananza, mia nonna era sempre lì che urlava qualcosa dietro a mio nonno e mio nonno che non rispondeva, mia nonna aveva il sangue nel sangue, mia madre la cenere.
Mia madre diceva qualcosa ma non la capivi, le parlavi ma non ti ascoltava, prendeva le gocce e dormiva, il giorno dopo si svegliava e ti chiedeva se era giorno o era notte.
Sono stato sette anni nell’OPG. Ora che aspetto che il giudice decide per quale altra galera prendere la strada mi sento meglio e mi sento peggio. Perché sono a casa qualche giorno anche se i carabinieri sono qua sotto, ma fra qualche giorno dovrò tornare in prigione. Fanno bene, perché ho fatto una cosa indicibile, anche se io l’ho detta e la dico, però la gola l’ho bucata a me stesso.
Io in quella stanza mi sentivo solo. In quella stanza di quella prigione, mi sentivo solo. Tutti i giorni. Solo, proprio. Cioè, abbandonato. E’ brutto passare il tempo dovendo passare il tempo. Meno male che facevo quelle cose le lettere e gli oggetti, ma la vita è già finita, ne hai un mucchio ancora ma è già finita, deve solo passare, ma non è questo che deve fare la vita. Io quando ho ammazzato mia madre stavo con Raffaella da due anni, quella ragazza che dicevo prima, piccola e ben proporzionata come diceva il mio amico Riccardo, con le lentiggini e i capelli neri neri neri che si è innamorata di me anche se io non so perché e non gliel’ho mai chiesto, come l’orgoglio di mio padre. Raffaella ha quattro anni meno di me e studia Economia, cioè credo che adesso è laureata, è da sette anni che non la vedo più, quando ho ammazzato mia madre lei lo ha saputo dai suoi genitori che erano amici dei miei vicini di casa e hanno visto l’ambulanza e la polizia. Io sono entrato nell’OPG dopo qualche settimana di ospedale normale, cioè non quello per i matti perché fino ad allora non ero matto cioè nessuno pensava che ero matto nessumo mi aveva detto che ero matto. Raffaella è venuta una volta sola ma è rimasta fuori dall’OPG, mio padre ha detto che non poteva entrare o che non voleva entrare non lo so, ma se non voleva entrare perché è arrivata fino lì? Raffaella però mi ha visto da dietro quella grande porta che ha i vetri sopra, come le porte delle macchine ma più grandi, la parte sotto è tutta bianca e la parte sopra ha il vetro, e mi ricordo Raffaella dall’altra parte del vetro, forse si vergognava di me, forse mi vergognavo di me, avevamo fatto l’amore qualche giorno prima, io e Raffaella facevamo l’amore perché sennò che cazzo fai con una persona che ami lo facevamo sempre a casa sua perché a casa mia c’era mia madre, mio padre no perché se ne era andato da tantissimi anni sennò l’ammazzava lui mia madre, invece a casa di lei al mattino e a volte anche al pomeriggio non c’era nessuno, e allora quando non eravamo in giro stavamo a casa sua, ascoltavamo musica a me piacciono i Led Zeppelin e i Pink Floyd, a Raffaella di più i Pink Floyd, quando invece eravamo in giro facevamo delle passeggiate e ci tenevamo per mano e stavamo sulle panchine o nelle viuzze del centro, parlavamo di quello che ci capitava ma soprattutto di noi non era mai troppo buio quando stavo con lei, cioè non era mai come quando non so più come fare, mi manca Raffaella, anche se sono passati sette anni, perché è come se avessi buttato giù dal balcone il mondo, è come se hai una cosa sola e non la devi distruggere e io invece l’ho distrutta. Raffaella era bella e i suoi baci mi portavano dove dovevo stare, dove la vita è mia, e dove la vita è sua, Raffaella io non ho mai capito perché si è innamorata di me, io non so se sono bello anche se lei diceva sempre di sì, è che ora mi vedo matto perché mi hanno detto che sono matto e non penso più se sono bello, sono impegnato tutto a essere matto, però Raffaella è come quando c’è un temporale e piove forte e c’è vento e ci sono i tuoni e i fulmini e tu corri sul marciapiede e quando sei tutto bagnato trovi un portone aperto e entri, Raffaella è così, come quando i cani ti mordono e ti strappano la pelle ma è solo un incubo e ti svegli e vedi il comodino e la luce nella finestra, Raffaella è quella stanza lì, io ho commesso la colpa io devo pagare, ma pagare significa buttare la vita, e la vita come faccio adesso a farla?, Raffaella è l’unico motivo che mi fa sentire che ho voglia di uscire, anche se lei non so dov’è, però quando mi ha guardato dietro quella porta mi sembrava che stavo allungando un braccio verso il mio posto quello dove devo stare, il mio mondo, dove la vita è mia, dove la vita è sua, e mi facevo pena mi fanno pena tutte le cose, è la cosa più brutta quando la vita non è più tua, non hai più un posto nel mondo, ma nemmeno a casa o sotto casa o in un parco, da nessuna parte, mi fanno pena le persone che non riescono a toccare il loro mondo, però io ho la colpa io devo pagare, e invece mi fanno rabbia le persone che non hanno la colpa ma non vivono, quando non hanno buttato tutto dal balcone ma non vivono lo stesso, sono ancora più matte di me. Io in quella stanza mi sentivo solo. Tutti i giorni. Io in quella stanza mi sentivo solo. Solo. Ed è un peccato che avevo conosciuto Raffaella, perché stare da soli è brutto ma è come se non lo sai, invece avere Raffaella e buttare tutto dal balcone è come essere abbandonati, e un conto è essere soli un conto essere abbandonati, è come essere solo mezza giornata e essere solo tutto il giorno, avere Raffaella e non averla più è come essere solo tutta la vita.
Io una volta ho scritto una lettera a Raffaella ma non è come quelle che scrivo ai morti perché Raffaella è viva anche se non la vedo più, e allora un giorno mi sono messo nel cortile a uno di quei tavolini dove stiamo al pomeriggio quando il tempo è bello e ho scritto, mio padre diceva poi provo a fargliela avere che ne dici?, anche se non so più dove abita ma magari trovo qualche parente o qualcuno che la conosce, io però alla lettera avevo paura che non rispondeva e allora la tenevo io infatti ce l’ho ancora qui e l’ho fatta leggere solo a quello Stefano perché è venuto all’OPG tre volte e tutte e tre le volte si era messo a parlare con me, e una volta anche con mio padre, e insomma
Raffaella io ti dicevo sempre che i tuoi baci mi portavano dove dovevo stare. Raffaella io ho capito perché i tuoi baci mi portavano dove dovevo stare, dove la vita è mia, ti ricordi che te lo dicevo sempre e tu ridevi, no sorridevi, mi dicevi che si dice sorridere non ridere, io ho capito cosa mi capitava, l’ho capito adesso, la vita non è quasi mai mia, sono io siamo noi che ci stiamo dentro ma succedono tante di quelle cose e sono di tutti c’è dentro tutto, il rumore mio padre l’autostrada la musica il telegiornale la rabbia le cose che fanno bene le cose che fanno male, ma i tuoi baci mi portavano dove la vita è mia, e sai perché?, come non lo sai?, perché lì non decide il mondo lì decidiamo noi, lì non stiamo ad aspettare che si libera un posto lì il posto lo occupiamo noi, lì non siamo in balìa del mondo lì è il mondo che guarda altrove mentre noi viviamo, hai capito Raffaella?, io l’ho capito adesso che non c’è più niente da fare, adesso che non ho più niente da fare perché ho ammazzato mia madre e ho una colpa e pago stando qua dentro. Mio padre dice che quando uscirò troverò un’altra ragazza ma io ho capito anche questo che quando fai qualcosa e vedi che sei arrivato dove la vita è tua tu quel posto lo devi chiudere da tutte le parti come fanno con le opere d’arte che così non le rubano e non le graffiano e ci mettono anche la temperatura giusta perché stanno bene e non si rovinano, come fanno con i campi dove cresce il grano o la vite, si chiama la vite quella dove nasce l’uva?, e lì non ci deve mettere piede nessuno, mio padre mi aveva detto che dove l’uva fa il vino proprio buono ci sono dei cannoni che sparano verso il cielo tipo delle onde d’urto per fare allontanare le nuvole e i temporali che possono rovinarla, Raffaella i tuoi baci per me sono un posto così, che devi sparare coi cannoni per non fare avvicinare nessuno e devi mettere la temperatura guista perché l’amore sennò si affloscia o si crepa come le opere d’arte, è una questione di spazio e di tempo, io alla televisione sento sempre la parola Amore e Ti Amo e su e giù ma ho capito anche questo che dirlo non vuol dire niente che l’amore si costruisce e si spara coi cannoni se qualcosa si avvicina e se poi finisce per i cazzi suoi va bene ma se lo lasci perdere in un campo qualunque a bordo strada come ho fatto io quando ho fatto quello che ho fatto e sono finito qua dentro è perché sei uno stronzo. Mio padre dice che vuole provare a farti avere questa lettera anche se non sa nemmeno lui dove sei e dove abiti ma io gli ho detto che no la tengo io che se poi non mi rispondi sto male e allora preferisco tenerla io e se mai ti vedrò di nuovo te la darò io se ce l’ho dietro in quel momento sennò ti chiedo di aspettare e poi te la porto. Sono qua dentro perché sono un assassino e perché mi hanno detto che sono matto, cioè hanno detto un’altra parola veramente, ma vuol dire quello. Raffaella chissà dove sei e se ti sei laureata in Economia era Economia o era altro che studiavi?, e chissà se hai ancora le lentiggini, si possono non avere più le lentiggini dopo che le hai avute?, io sono un assassino e sono un matto e mi manca la vita e mi mancano i tuoi baci perché lì la vita è mia, lì la vita è amore e la vita vive poche volte nella vita ho capito anche questo e tutto il resto è prima e tutto il resto è dopo, e tutto dove non è amore sono effetti collaterali della vita, com’è che questo non lo abbiamo capito?
La tensione civile di queste poesie interroga tempo e paesaggio sedimentati a resto, mescola i luoghi e l’umano a formare un’unica voce, un frammento, un rumore che persiste anche quando essi si sono annientati l’uno nell’altro, l’uno dall’altro vengono disertati. Yari Bernasconi ci conduce in zone di confine geografiche, paesaggistiche, sentimentali dove i morti si affacciano nei vivi, i corpi si frantumano nella roccia, dimenticano la loro lingua nei boschi come il marchio di una dolorosa diversità, un’identità necessariamente solitaria che pure si mostra (o si maschera) perché l’altro finalmente la accolga. Ma ciò che si accoglie non è mai un intero: anche nel suo momento più bello, di luce e colori, è un’immagine rapida, un attraversamento, la sensazione di qualcosa – la storia, le storie, la natura, le macerie – che c’è stato e che inevitabilmente si volge all’ombra, fluisce quasi senza ragione, si dimentica in noi. (f.m.)
di Yari Bernasconi
Una poesia per la galleria ferroviaria del San Gottardo
(La roccia gli ha spaccato il petto, rotolando.
Né parole, né gesti: solo uno sbuffo secco,
terribile. Inutile l’affanno dei compagni,
accorsi con scarponi unti, le grida attenuate
dalla routine. La terra e le pietre, nel buio,
non hanno regole da rispettare. Nessun padrone.)
*
Qui sotto, tra le rocce, i sassi e questo fango rappreso,
l’oscurità sembra assorbire le nostre facce.
Per questo, forse, non guardiamo: gli occhi bassi,
ridicoli, paurosi delle ombre dei corpi. Eppure
il rumore è severo: lo sentiamo vibrare
con costanza.
*
Manca la luce e ne soffriamo. Non tanto sotto,
in questo esofago di terra, ma sopra, all’aria,
quando si esce dal buco e il grigiore del cielo
si accascia sul profilo delle montagne, il sole
si rabbuia nel ricordo ostentato di qualcosa di più,
qualcosa di diverso. Una speranza, sì: la speranza
rifiutata, respinta giorno dopo giorno.
*
Non è lontana, l’Italia, ma noi siamo bloccati
in questi gorghi di pietraie, incollati a questi attrezzi
logori e scuri, sporchi di detriti e di sangue, le mani
e le braccia incrostate da piccole ferite,
polvere ovunque. Siamo forse più svizzeri, adesso,
in questa nostra galleria.
*
All’interno il calore è quasi insopportabile,
però si avanza: il sudore diventa una seconda pelle,
viscida e scivolosa ma pur sempre tua. Fuori, invece,
Göschenen è fredda, è gelata, e ci respinge
come un germe pestifero.
*
(Vengono lenti. Sulla barella il morto si confonde
con i vuoti dello straccio, le pieghe improvvise.
Ci guardiamo distratti e ingenerosi,
sfiorati in superficie dalle cime indifferenti,
dalle gravi catene montagnose: quelle rocce impossibili
che forse già sappiamo e conosciamo.)
***
La maschera
Vorresti dirmi che hai toccato con mano, con violenza,
e che tra tutto quello che hai sofferto sei scomparsa
nei boschi di questo piccolo paese, franata
in un dirupo senza fondo.
Vorresti dirmelo ma non lo fai, non sei capace.
A scuola hai soltanto imparato a tacere:
diversa perché innocua, perché parli italiano,
perché vieni da un altrove vicino ma non troppo.
Derisa, hai sognato la sordità; picchiata,
hai sognato la trasparenza.
Ma poi il corpo s’irrobustisce e il tuo volto
diventa un filtro impenetrabile che spinge avanti,
verso luoghi insperati: la fredda cordialità di un lavoro,
poche sorprese e molte conoscenze. Decidi che così
può andare e disperdi le tracce. Non guardi più
negli occhi di tua madre o nelle mani di tuo padre.
Tuo figlio nasce e non ha dubbi. Non cresce in angoli
nascosti, non ha nulla da temere. Guarda indietro
e vede chiaro. Appoggia le sue mani sul tuo braccio,
ti riconosce, sa di essere a casa.
Mentre osservi
i contorni sfocati della stanza, in un momento
di pioggia e di buio, ti sembra quasi di essere felice.
Te ne convinci per lunghi minuti.
***
Trittico per un paesaggio
Questo paese di campane e di lago,
così sofferente al silenzio di chi vive,
così schiacciato da questo monte immobile.
Sembra di non averci mai vissuto,
ma di averlo attraversato distrattamente,
come si fa con la nebbia o la pioggia.
*
Siamo cambiati senza movimento: all’oscuro
delle unghie più nere, grati dei sentieri battuti,
le strade e i cortili puliti. Sangue? Macerie?
La guerra vera era noiosa: distante e prevedibile.
*
L’anziano che rallenta: la traiettoria di ottant’anni
di silenzio. Rade il muro di sasso con pazienza,
tende lo sguardo e poi fissa i ciottoli
sul bordo della strada. Il borgo è fermo.
La piazza una lama piatta che scintilla.
Il lago s’insacca tra alcuni rilievi. Sono morti
i vecchi platani, li hanno strappati anni fa.
Ora che c’è il sole si cercano altri spazi,
ombre nuove.
***
Residui
Il giardino è un perimetro di cenere e di sassi.
C’è del metallo accartocciato, fuligginoso;
un recipiente svuotato; di fianco un triciclo
incrostato di nero, con le ruote ritorte
sopra la macchia delle gomme fuse.
Nel mezzo una carcassa di bovino:
bruciate le ossa e la carne, il muso sfigurato
come un blocco di carbone. E poi polvere
attorno, terra scura. Legni arsi e locali
scoperti, senza muri e senza vita.
***
Tre mulini
Il primo è solido e ristrutturato:
un cartello ne indica l’epoca. Le famiglie
in vacanza si fermano a leggerne la descrizione;
i padri e le madri gesticolano dicendo
il movimento delle pale, dell’acqua,
gli ingranaggi di una farina bianca
che non hanno mai visto; i loro figli
guardano il muschio distillato sul legno
con pazienza, poi corrono a tuffarsi
dal pontile.
*
Il secondo l’ho visto
anni fa, appoggiato a un sentiero scosceso;
probabilmente immaginato da ragazzo,
in un bosco di luce e di colori
filtrati: la cascina diroccata e abitata
per poche ore nella polvere e nei sassi.
*
Il terzo, invece, del mulino ha ben poco:
somiglia a una bocchetta improvvisata
di metallo scadente, dove l’acqua
scorre per caso, muovendo lentamente
la struttura e i semplici, pochi ingranaggi;
le quattro pale sono lente e sfibrate,
il legno compensato è deformato dall’usura;
non ha mai visto il grano, non è servito
mai a nulla; l’ha fabbricato un uomo,
per sé: ci ha lavorato molti mesi, e da allora
ci viene ogni sera: lo guarda, segue l’acqua
che fluisce.
————-
Descrizione del mondo – oltre ad essere un sito che si guarda, si ascolta, e si legge – vuole essere un piccolo esperimento di lavoro e riflessione sulla portata, all’interno di differenti generi letterari, pratiche artistiche e di pensiero, del concetto di descrizione e del concetto di mondo. Questo esperimento è un progetto collettivo e aperto. Descrizione del mondo ha assunto inizialmente la forma di un’installazione pensata da alcuni scrittori e artisti per altri scrittori ed artisti, ed è un sito che costituisce un archivio dei materiali in mostra (Contribuiti in mostra) e di contributi destinati alla rete (Contributi al sito), oltreché di materiali che documentano il progetto nelle sue differenti fasi e nei suoi differenti aspetti anche teorici (repertori).
 di Angela Galloro
di Angela Galloro
Di altre Spoon River non resta molto in questi anni. Sembra che la poesia americana sia stata rastrellata via dalla Beat Generation o al limite dopo Ezra Pound e Thomas S. Eliot, quantomeno in Italia, dove – dopo l’interesse della Pivano – di poesia americana contemporanea se n’è parlato solo fino agli anni 00 con la raccolta di L. Ballerini, P. Vangelisti (Mondadori) o con West of your cities di Minimum Fax, curata dal più grande poeta americano dei nostri tempi, Mark Strand, scomparso da pochi mesi e sotto la come sempre straordinaria traduzione di Damiano Abeni.
fotografie di Danilo De Marco
In principio era la parola
I
Credo che la parola sia perduta,
tanta fatica costa pronunciarla.
Credo che noi siamo perduti
senza la sua stella.
di Filippo Belacchi

La trovano così, seduta e stregata, mentre ascolta un pezzo di Debussy. Il cadavere del marito ancora caldo è steso a due metri da lei, sulla moquette appena lavata. È il mese di aprile e fuori soffia un vento caldo.
Questa signora dai bizzarri vestiti anni 30, nonostante siamo negli anni 50, è la scatola nera dell’omicidio di Elm st. Sa come sono andate le cose. Ora si trova in uno stato d’inquietudine tale che è dovuta uscire di casa. Ha guidato per circa un’ora e poi, intontita dal quel vento caldo e impetuoso, è entrata in un locale fuori città.
Per distendere i nervi ha già bevuto tre whisky allungati con l’acqua e fuma una sigaretta dopo l’altra. In questo istante sta meditando se restare sveglia fino al mattino per vedere cosa i giornali scriveranno sulla donna stregata che ha ucciso suo marito mentre ascoltava Debussy.

Eccolo, il marito, la vittima, appassionato di giardinaggio, direttore della camera di commercio di Dultuh, Stati Uniti, poco lontano dal confine col Canada. Bob Dylan, anche lui originario di Duluth, è questo signore che ha in mente quando in Tombstone Blues canta: Jack the ripper who sits at the head of the chamber of commerce.
Uomo spietato. Rispettato, ma in realtà temuto dalla comunità per il suo potere politico utilizzato come un fucile a pompa. È capace di fare la fortuna e la sfortuna di molti cittadini.
Questa foto l’ha scattata la moglie, sua futura assassina, durante una pausa dei lavori al giardino.
Come si può vedere dall’inquadratura, non la moglie, ma sicuramente qualcosa dentro lei, ha già deciso che è un uomo morto. Non ha più il viso, oscurato dal calore omicida del sole.

Unica foto disponibile del giardino. È la notte di Halloween del 1946 e si può già intuire come crescerà rigoglioso. Dieci anni dopo sarà un tripudio intricato di forme e colori. Anche i segreti che Jack the ripper sotterra qua e là: ai piedi del melo, dietro i gelsomini, accanto alla siepe verde nera, crescono e si diramano furiosi. Nascosti là sotto ci sono foto e filmini tremendi, un infernale archivio sotterraneo su uomini e donne di Duluth.
 Una delle pochissime foto pubblicabili tratte dagli archivi di Jack the ripper. Per il resto, foto e filmini, formano un incendio indomabile di violenze e sevizie che mette a dura prova la capacità di perdono degli dèi.
Una delle pochissime foto pubblicabili tratte dagli archivi di Jack the ripper. Per il resto, foto e filmini, formano un incendio indomabile di violenze e sevizie che mette a dura prova la capacità di perdono degli dèi.
Ma come riesce a reclutare modelle e modelli? Manda sul lastrico, legalmente, attività commerciali, specie quelle gestite da donne sole, negando loro permessi, inviando ispezioni e così via. Poi promette, mentendo, di fare riaprire i negozi in cambio di sessioni fotografiche.
È a lui che dobbiamo l’invenzione della parola snuff, che significa: “spegnere lentamente”; Jack the ripper spegne lentamente la vita delle persone. Abbassa le luci nelle loro esistenze, finché il buio è talmente fitto che è impossibile uscirne.
L’archivio di immagini e filmini di Jack the ripper è stato dissotterrato, esaminato e poi distrutto, anche se non del tutto; qualche esemplare dei suoi assalti impressi in super-8 è stato trafugato ed è poi scivolato di mano in mano: qualche collezionista disposto a sborsare molti soldi per certe bobine lo si trova molto più facilmente di quanto si possa pensare. Per trent’anni una minima parte dell’archivio di Jack è rotolato, rimbalzato dal Nord degli Stati Uniti fino a scendere verso la East Coast, New York City, e poi giù, verso l’altra costa, la California, Los Angeles, San Francisco e Napa Valley.
Proiezioni organizzate in case di ricchi collezionisti per un pubblico sbigottito di amici. Qualcuno, chissà se in California o nello stato di New York, deve essere rimasto colpito dall’occhio di quell’uomo dietro la cinepresa. Più che colpito ispirato. Nel 1996 infatti uscirà una campagna pubblicitaria che sarà poi bandita, vista la smisurata violenza sessuale in potenza che ogni spot trasuda.
Ogni filmato ricorda il prologo delle interviste che Jack faceva alle sue vittime. Ho detto ricorda, ma di fatto è un puro e semplice calco delle sue interviste: una copia abbellita e levigata quanto basta per la tele. E quindi il capo della camera di commercio, in una cittadina al confine col Canada, e il suo materiale nascosto sotto la terra umida e viola, hanno contribuito a modellare parte di quella che chiamiamo cultura popolare.
 La notte dell’omicidio l’avevamo vista dentro un locale fumare e bere inquieta: eccola di nuovo, nel periodo più felice della sua vita: la fine degli anni 30. Lei e suo marito possiedono una gioielleria che sta facendo ottimi affari. L’anno prossimo metteranno al mondo una figlia che chiameranno Paula. Questa è una delle ultime foto che ce la mostrano radiosa.
La notte dell’omicidio l’avevamo vista dentro un locale fumare e bere inquieta: eccola di nuovo, nel periodo più felice della sua vita: la fine degli anni 30. Lei e suo marito possiedono una gioielleria che sta facendo ottimi affari. L’anno prossimo metteranno al mondo una figlia che chiameranno Paula. Questa è una delle ultime foto che ce la mostrano radiosa.
Negli anni quaranta perderà suo marito in guerra (duello aereo) e verrà azzannata da Jack the ripper. Prima lei e poi sua figlia Paula, ormai quindicenne.
Paula, dopo le sevizie, comincia a sprofondare dentro di sé, lontano dalla realtà, dove non ci sono più parole ma solo silenzio. Viene ricoverata nella casa di cura, l’unica, semi deserta, che si trova alla periferia di Duluth.
Ridotta sul lastrico, legami affettivi tranciati con rara violenza, non si dà pace. E chi non si dà pace prima o poi entra in guerra. Eppure, la cosa più interessante che riguarda questa donna è un’altra. Il denaro che le ha consentito di aprire la sua attività lo ha guadagnato da ragazza, facendo la rabdomante: questo il suo dono, che poi pare abbia perso. Sapeva, voglio dire: sentiva, non si sa come, la presenza di sorgenti d’acqua sotterranee. Una persona con queste facoltà è preziosa, molto contesa dagli agricoltori della zona.

La futura assassina, moglie del Jack the ripper, ha l’hobby della fotografia. Gira per casa, nel giardino, dove si nascondono i segreti del marito, e scatta.
Non sa, ma sa. E e lo s’intuisce dai colori e l’inquadratura: l’ombra che domina la sua mente s’insinua in ogni fotografia. È come se delegasse le verità all’ombra del suo occhio. Scorrendo i suoi album si vede che ha capito, che sa, ma non riesce a pensarlo. A pensare cosa? Che suo marito andrebbe eliminato.
La mamma di Paula, rimasta sola, comincia a girare, a vagare per le strade di Duluth. Siamo nel mese di marzo, tra un anno avverrà l’omicidio. Non sa cosa fare ma soprattutto non sa dove andare. Sembra una tronco scavato da dentro che non può fare altro che rotolare. È a meno di un passo dal diventare una vagabonda senza più niente. Se ne sta chiusa in casa a meditare, cerca di riflettere. Ma altre cose, come la sua condizione, la condizione di sua figlia, sono impensabili. Spesso va in campagna, per nascondersi e per vedere se quel suo dono, qualche rimasuglio di quella curiosa sensibilità per l’acqua, per le sorgenti sotterranee, le è rimasta.
Niente, prova ma non sente nulla. Quella forza che la trascinava verso un punto dove sotto i suoi piedi un flusso sgorgava è scomparsa. Passa l’estate. Ma a Duluth, su al nord, già a metà settembre comincia a fare freddo e la signora teme l’inverno come una bestia ferita. Non ha soldi per scaldare la casa e il dolore che prova le impedisce di pensare e rimettersi in piedi. Per non stare a casa, imbottita di vestiti, col freddo che le gela i ricordi e la trascina verso la morte, esce, vaga, cerca di muoversi, finché un giorno si trova di fronte alla biblioteca della città. Entrare non costa nulla, dentro è riscaldato e ci si può nascondere. Comincia ad andarci ogni giorno: dalla mattina, fino all’ora di chiusura.
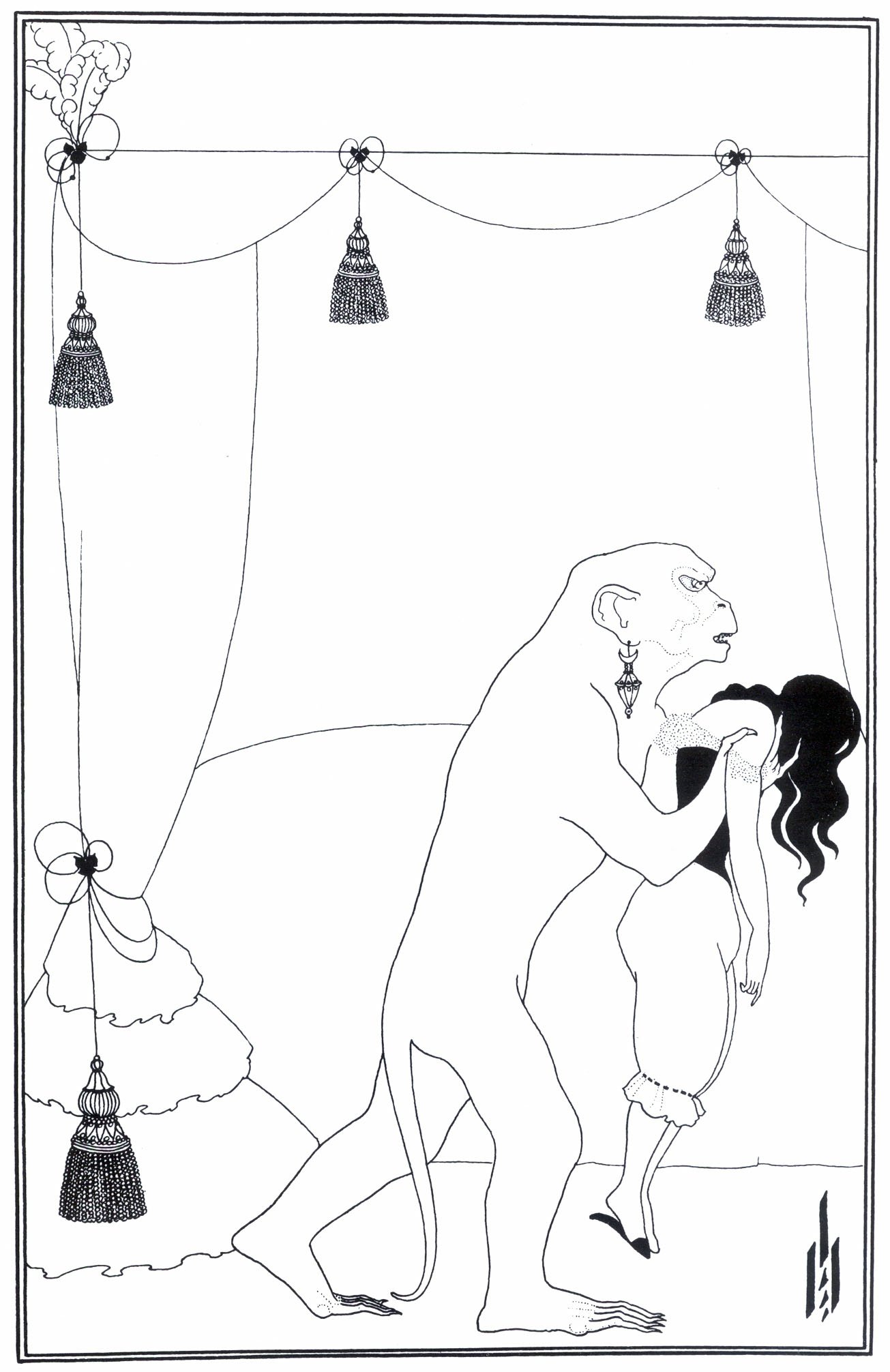
E come si può passare il tempo in una biblioteca? All’inizio si gira, si leggono i giornali, le riviste, ma prima o poi un libro lo si apre, lo si sfoglia, lo si scorre e magari, beh, magari lo si finisce anche per leggere. Comincia con Walden di Henry David Thoreau.
Dopo Thoreau continua con Melville e Hawthorne; legge Dreiser e Fitzgerald. Ma il suo cervello intanto registra, scopre, esplora, sa già dove vuole arrivare ma deve scoprire il modo per arrivarci.
Legge anche Frankenstein. E poi, poi arriva ad Edgar Allan Poe.
Il mattino che chiede in prestito le opere di Poe, non saprebbe nemmeno lei spiegarne il motivo – ’impiegato al banco è un nuovo arrivato, mai visto prima – decide di registrare i volumi sotto falso nome. Quando le viene chiesto nome e cognome, come se parlasse qualcun altra al suo posto, si sente dire: Helèna Thulls. Ma perché lo ha fatto?
Helèna Thulls decide di leggere le opere di Poe senza mai togliersi i guanti. Non saprebbe spiegare il perché ma sa che non deve sfilarseli.
Entra tra le pagine, come trascinata via, verso l’abisso che porta al centro della terra; il primo racconto a impressionarla, tanto che più volte è costretta a interrompere la lettura, è I delitti della Rue Morgue: madre e figlia uccise senza pietà da quello che si rivela essere un orangutan. “È quello che è successo… Quello che… Io… la mia bambina… una forza… quel mostro… quel mostro ci ha spazzate via!” La si sente bisbigliare nella sala lettura. Comincia a singhiozzare. Le sue lacrime producono una eco curiosa, è come se fosse una presenza invisibile a piangere, un fantasma fermo a mezz’aria. Ora la testa le si svuota, purificata dal pianto. Dentro non le rimane che una cosa, un pensiero, un desiderio anzi, che a poco a poco comincia a prendere corpo, ad avanzare dall’oscurità e salire su, con grande lentezza, verso la luce.

Si asciuga gli occhi e comincia a leggere il resoconto di Gordon Pym da Nantucket.
Le avventure di Gordon Pym, quella strana novella di morte e deriva le consente di penetrare e sentire fino in fondo la propria solitudine. Un ragazzo s’imbarca su una nave e giorno dopo giorno perde tutto, finché non rimane solo, ed entra nella parte bianca dell’inferno, Antartide: dove finisce il mondo e inizia qualcosa di potente e misterioso capace di annientare lo sguardo. Fino alla fine del mondo – si ripete mentre legge – io là devo andare, anzi già ci sono, devo spingermi ancora oltre.
E quando spazi e significati sono svaniti, capisce che non le resta nulla da perdere. I suoi pensieri, sente, hanno la consistenza di sogni fitti e opachi, dove puoi sentire solo il cuore, la musica del suo cuore disperato, ma ancora vivo.
Adesso le rimane così facile vedere dentro, così facile pensare l’impensabile. Le manca solo l’ultimo passo, sente. Solo un altro passo e posso cadere dentro, fino in fondo al mondo.

Le parole di Edgar Allan Poe hanno inghiottito Hèlena Thulls, quando un lampo, che con sé porta una visione, la colpisce: Le vicende relative al caso del Signor Valdemar. Il racconto narra un esperimento di mesmerizzazione che lascia il signor Valdemar in uno stato crepuscolare. Per sette mesi, grazie alla mesmerizzazione, il signor Valdemar rimane tra la vita e la morte.
E tra la vita e la morte, o tra il giorno e la notte, in questa zona di penombra, Valdemar compie azioni, parla: dice parole corrose dal buio e dalla morte, che però raggiungono il mondo dei vivi. Viene indotto, se non addirittura comandato, a restare in vita.
Hèlena Thulls esce dalla biblioteca ma il luogo dal quale vorrebbe uscire è il mondo di Edgar Allan Poe che le suggerisce ipotesi, possibilità, piani e progetti che le provocano una eccitazione emotiva insostenibile.
Il mattino dopo, in biblioteca, cerca sul dizionario la parola “mesmerizzare” e scopre che deriva dal nome di un medico tedesco: Anton Mesmer, morto nel 1815. Figura controversa, da molti ritenuto un ciarlatano. Tuttavia è a lui che si deve se non l’invenzione, almeno la popolarizzazione dell’ipnosi. L’ipnosi.
Consulta l’enciclopedia Britannica: tedesco, nato, come anche lei, nei pressi di un lago; scorre alcune righe e legge che Mesmer, da giovane, oltre ad avere una dote naturale per la musica un rabdomante.Sente un tonfo al centro dello stomaco, chiude il libro ed esce dalla biblioteca.
Poi, come afferrata per le spalle da un fantasma, si ferma sull’ingresso, torna indietro e chiede all’impiegato se hanno le opere di Franz Anton Mesmer. Le viene risposto che “Sì, abbiamo un solo libro di questo autore: Il magnetismo animale”. Confusa e spaventata fugge dalla biblioteca per rimetterci piede solo tre giorni dopo.
Particolare: quando si allontana di fretta le viene istintivo controllare se ha indosso i guanti. Sì, li ha indosso, mai sfilati un istante.
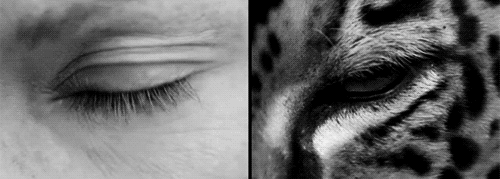
La signora ha ormai avviato il suo processo di metamorfosi, è diventata Hèlena Thulls, la donna dai guanti bianchi. Legge Il magnetismo animale. Non ci ricava niente di pratico circa l’ipnosi, ma la sensazione che prova è quella di leggere un libro… come se quel tedesco fosse uno dei profeti della Bibbia. Entra in una dimensione. Si tratta del primo vero ponte fatto di parole, di piccoli cristalli oscuri che conducono alla terra promessa.
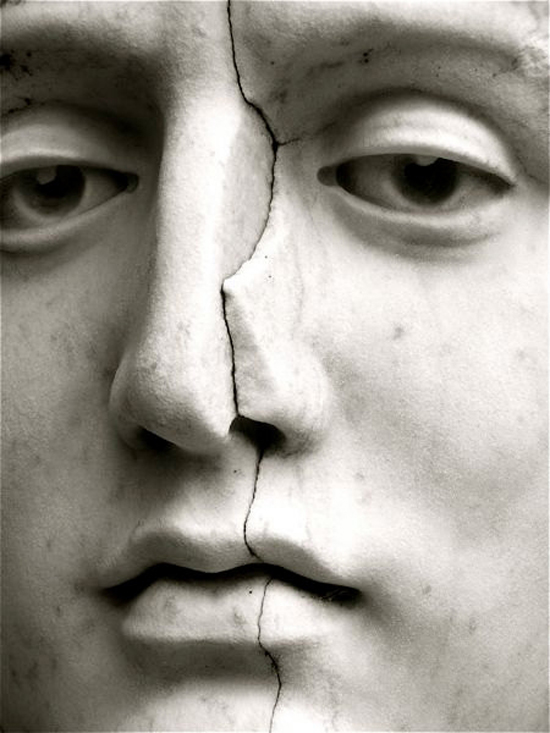
Legge e rilegge Il magnetismo animale. Poi prende un grosso romanzo uscito tre anni prima, Le avventure di Augie March. Ma non si sogna neppure di leggerlo, lo tiene semplicemente come paravento, mentre osserva con tutta se stessa la gente seduta in biblioteca. Scruta con ingordigia e lucidità impressionanti. Cerca nei movimenti abitudinari delle crepe dentro le quali potrebbe inserirsi e raggiungere il retro della mente di alcune persone.
Ha capito una cosa, e l’ha capita con tutta se stessa, la sua anima ne è intrisa: ipnotizzare una persona vuol dire diventarne lo specchio, esserne una replica di sogno che può condurre il sognatore lontano, dentro sé.
Mettersi di fronte a un uomo, o a una donna, e ricalcarne le movenze senza che se ne accorga. È così che ci si trasforma in specchio! Poi lo guidi. Ti allinei alle sue movenze e cominci a modificarle giusto un istante prima, in modo che l’ipnotizzato venga guidato da una figura che sembra essere solo un suo riflesso.
Ricalco e guida, ricalco e guida.
 Un mattino gelido mattino d’inverno. La signora se ne sta sulla gradinata di fronte alla biblioteca. Hèlena si sfila i guanti, li mette dentro la borsetta e si avvicina a un giovane che sta fumando con lo sguardo distratto. Per ripararsi dal vento tiene il collo incassato allo stesso modo del ragazzo. Entrambi, nel medesimo istante, sembrano venire percorsi da un brivido di freddo. Lei poi gli chiede d’accendere e mentre lo fissa negli occhi aspira avida, quasi toccando l’interno delle guance, com’è solito fare lui.
Un mattino gelido mattino d’inverno. La signora se ne sta sulla gradinata di fronte alla biblioteca. Hèlena si sfila i guanti, li mette dentro la borsetta e si avvicina a un giovane che sta fumando con lo sguardo distratto. Per ripararsi dal vento tiene il collo incassato allo stesso modo del ragazzo. Entrambi, nel medesimo istante, sembrano venire percorsi da un brivido di freddo. Lei poi gli chiede d’accendere e mentre lo fissa negli occhi aspira avida, quasi toccando l’interno delle guance, com’è solito fare lui.
Il ragazzo tra la boccata e il “grazie” avverte, lontano, un rallentamento, uno slittare onirico della realtà che però non saprebbe dire. Qualcosa di remoto che tuttavia avviene da qualche parte dentro lui. Un sobbalzo impercettibile e morbido che non sa spiegare. Sarà forse il volto sconosciuto ma famigliare della donna, le sue movenze misteriose e materne.
Lei mette le braccia conserte e aspira di nuovo, un istante prima che lo faccia lui. È come uno specchio, eppure la replica non sta nelle movenze ma nel ritmo, nell’aria fatata che quei movimenti lasciano calare tra i due.
Quando il ragazzo incassa di nuovo la testa lo fa anche lei e bisbiglia un commento sul freddo e poi allunga il collo, senza togliere mai lo sguardo, delicato ma fisso, dagli occhi di lui: “Oggi ˗ dice ˗ questo vento è bello e caldo, bello e caldo come in un sogno.” Lui fa un cenno spiritato di assenso. Lei con aria lenta e distratta si sfila l’anello dall’anulare e, immediatamente dopo, lui si slaccia il bottone della camicia.
“Arrivederci.” dice la signora, e si allontana. Dopo un centinaio di metri, discreta, si volta in direzione del ragazzo: si è tolto la giacca, la tiene sull’avambraccio, mentre continua fumare.
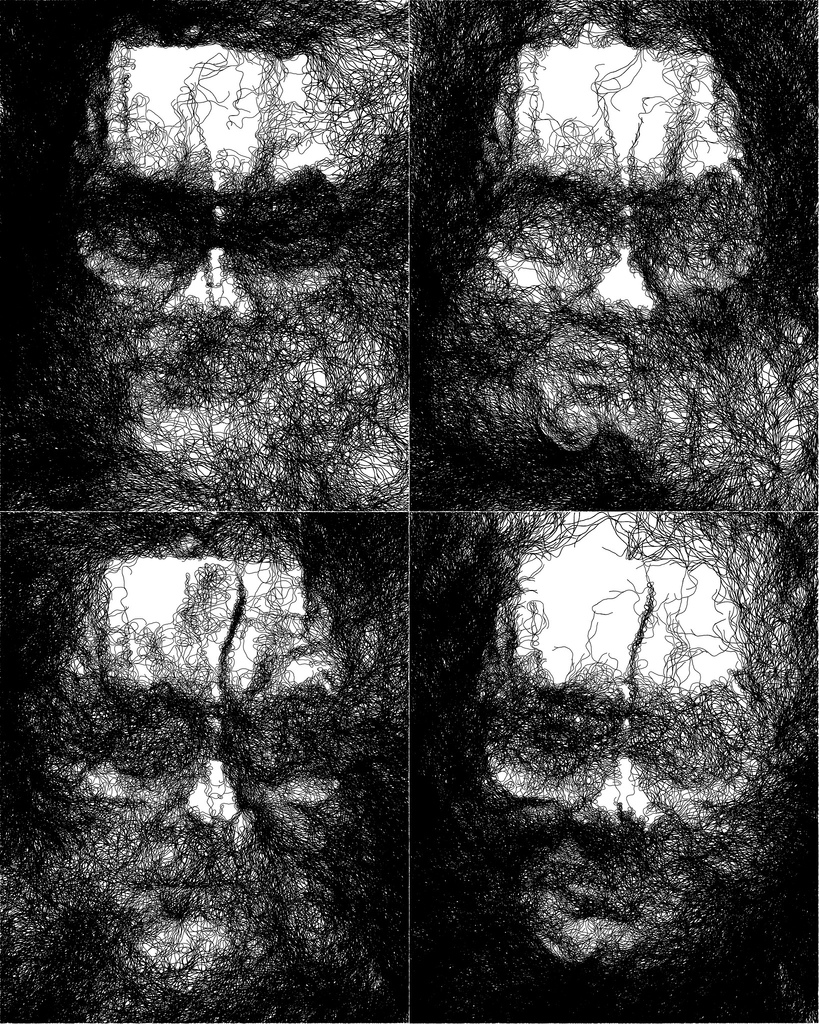
Siamo a fine febbraio, la signora dai guanti bianchi se ne sta seduta dentro la sua auto scassata di fronte a un locale notturno. Guarda gli avventori entrare, uscire. Alcuni tra loro barcollano, altri trascinano i piedi a capo chino, come condannati a morte. Ne deve trovare uno che abbia un protuberanza visibile sulla schiena o all’altezza del petto; prima o poi arriverà. E infatti eccolo, quel signore là, con un abito grigio e gualcito. È alto e assieme tarchiato, ha il collo largo come un tronco d’albero. Primitivo nei tratti, nelle movenze, l’andatura è distratta e rabbiosa. Un depresso. Lo guarda entrare, aspetta cinque minuti e anche lei fa il suo ingresso nel locale.
Lo vede subito, di spalle, con i gomiti appoggiati sul bancone, la giacca si solleva e lascia intravedere quel fallo cromato infilato tra schiena e pantaloni. Gli siede al suo fianco, a meno di un metro, e aspetta che lui le rivolga la parola. Non le parla ma le ordina invece un whisky. La signora dai guanti bianchi le rivolge un sorriso turbato e lo fissa negli occhi con uno sguardo cedevole, da preda. È così che aggancia il predatore, che subito si ritrova perso in quello sguardo, come il cacciatore che, richiamato da un suono, imbocca un sentiero che lo porta in una zona del bosco fino ad allora sconosciuta.
Si sente in pericolo, vale a dire che si sente come si è sempre nascostamente sentito: debole e indifeso. Questa è la sola ragione per cui porta una pistola: perché è un bambino impaurito di 50 anni. Sente che lei può scacciare i fantasmi che lo tormentano fin dall’infanzia.
In meno di un istante il cacciatore si accorge di essersi smarrito. L’attempata cerbiatta gli fa strada nel mondo delle sue paure, dove la sua forza, l’arma che tiene infilata nella schiena, non serve a niente. Il desiderio di protezione che cova da un vita e che ha sempre scambiato per rabbia, implode: si affida a lei. Sarebbe disposto a pagarla per liberarsi delle sue paure nei confronti dell’altro, degli altri. Ma lei non vuole essere pagata, vuole solo la sua arma.
Quella verrà usata per proteggerlo, basta solo che lui gliela dia e potrà dormire tranquillo. È come un sogno. Escono dal locale, lui entra nell’auto di lei. È quasi commosso, dal volto primitivo emerge la faccia di un bambino di 10 anni che consegna quella cosa a sua madre.
Tornata a casa, resta al buio tutta la notte, seduta sulla poltrona di fianco alla finestra che dà sulla strada. La luce della luna piena le dà da pensare, come anche quell’oggetto luminoso appoggiato sul grembo. Più volte è tentata di alzarsi e buttarlo in fondo al fiume e dimenticare tutto.
A tratti si distrae, dimentica la feroce bestiola d’acciaio che sembra assopita. Si tratta di una Smith & Wesson mod.36; conosciuta anche come “Lady Smith”. A guardarla però non le verrebbe mai in mente di chiamarla Lady Smith; ai suoi occhi somiglia ad un sinistro incrocio tra un piranha e un minuscolo cane che ringhia nel sonno. La lascia dormire, nonostante senta quella strana gravità pesarle sulle cosce che sembra mormorarle: “Quando sei pronta, allora scatenami”.
Guarda la luce della luna che inonda la stanza; dimentica l’adesso e ricorda il passato.
Ieri mattina nella mia buca delle lettere c’era una busta arrivata dagli Stati Uniti, Minneapolis. La busta conteneva: una lettera scritta a macchina firmata a mano e questa foto. (Sono stato io a coprire le sagome, per pudore. Intendo però precisare che a me la foto è arrivata, per così dire, “in chiaro”).

Non so proprio come la persona abbia potuto rintracciare me e il mio indirizzo di casa, ma questo è un fatto d’interesse secondario. Ciò che invece mi piacerebbe capire è un’ altra cosa: lo scorso 12 novembre ho cominciato a scrivere questa storia di fantasia dopo aver visto la foto di una donna dallo sguardo fatato che seduta in salotto ascolta un disco. Giorno dopo giorno ho continuato la storia: ho parlato delle vicende della signora dai guanti bianchi e dell’omicidio del capo della camera di commercio.
Giorno dopo giorno ho ricostruito la storia utilizzando la mia fantasia e alcuni vecchi fatti di cronaca. Per una qualche strana piroetta del caso, un anziano signore che vive dall’altra parte dell’oceano, dopo aver letto questa storia sul mio blog ha pensato d’integrarla con una generosa manciata di verità. Pare che quello che Dylan chiamò Jack the ripper sia veramente esistito e questa foto ne svelerebbe il volto.
L’uomo che mi ha spedito la lettera ha un cognome italiano. E la lettera è scritta in un inglese bizzarro, pieno di errori e inframmezzato da vecchie parole della nostra lingua. Cito dalla lettera: “Dal momento che non hai un ritratto del volto di Jack ho pensato di aiutarti. La persona di cui parli è il ragazzo più giovane che compare nella foto.”
La persona potrebbe quindi essere il ragazzo a destra con il volto che si vede solo per metà. La lettera non dà indicazioni, dice solo che è la persona più giovane che appare nella foto. Osservandola con attenzione si può notare che ci sono altri volti nascosti e quindi qualcuno più giovane dell’unico ragazzo ben visibile potrebbe nascondersi nelle figure che s’intravedono nell’oscurità.
La lettera poi racconta la storia di questa foto, cito ancora: “Sette agosto 1930, contea di Marion, stato dell’Indiana, 640 miglia a sud-est di Duluth. I nomi dei due cadaveri sono: Thomas Shipp e Abraham Smith colpevoli di avere rapinato e ucciso un operaio di razza bianca: Claude Deeter. In realtà le persone erano tre, c’era anche un ragazzo di 16 anni, James Cameron. Il solo riuscito a sfuggire al linciaggio. Ha però portato sul collo la cicatrice del cappio finché è vissuto.
Il pomeriggio del 7 agosto, quando si è sparsa la notizia che i tre presunti assassini erano rinchiusi nella prigione della contea, una folla di cittadini, 2500 persone, ma altre fonti sostengono addirittura 5000, hanno fatto irruzione negli uffici dello sceriffo per poter disporre dei corpi. Una volta prelevati sono stati portati nella campagna alla periferia di Marion e impiccati. Smith, durante l’impiccagione, ha tentato di liberarsi dal cappio con le mani; uno del gruppo, molto probabilmente la persona di cui stai raccontando la storia, gli ha spezzato le braccia con un bastone per evitare che tentasse ancora di sottrarsi a ciò che la folla aveva deciso.
Jack the ripper, dieci anni dopo questo fatto, si trasferisce a Duluth per aprire un allevamento di visoni. Da quelle parti, all’epoca, il commercio di pellicce è molto fiorente. Altri dicono che abbia lasciato Marion per sfuggire a una storia di sevizie a danni di ragazze nere e bianche. Una di queste ragazze pare non abbia retto l’urto delle violenze di Jack e sia morta per un’emorragia. Il padre di Jack, politico locale e potente membro del KKK, sembra sia riuscito a insabbiare tutto. Jack è costretto a fuggire a nord. Si ferma a Duluth, apre l’allevamento di visoni che però fallisce molto presto. Riesce allora a farsi assumere dalla camera di commercio e in capo a cinque anni si insedia al vertice e dà inizio allo scempio.
“Ho visto che hai detto di Tombstone Blues: Jack the ripper who sits at the head of the chambre of commerce. Queste parole scritte da Dylan non sono scritte a caso. Suo padre, Abraham Zimmerman, proprietario di un negozio di elettrodomestici, dovette trasferirsi nella vicina Hibbings per sfuggire dalla grinfie del capo della camera di commercio ed evitare la bancarotta. Il motivo ufficiale del trasferimento però fu la poliomielite che lo colpì all’improvviso e in tarda età.”
Ieri pomeriggio seguendo le tracce della foto sono venuto a sapere che il poeta americano Meeropol, in seguito al linciaggio dei tre di Marion, ha composto una poesia, Strange Fruit. Billie Holiday ha poi fatto il resto.
Hèlena Thulles cammina per molte notti nei pressi della casa di Jack the ripper. La osserva, ricorda, a volte la rabbia è tale che è costretta a fuggire via per non entrare in casa e ucciderli tutti e due.
Ma sua moglie non ha colpa, se non quella di resistere alla verità; sa che ogni giorno prepara da mangiare per un orco, lo sfama, gli mantiene il cervello lucido, che lui usa come un’arma per ferire, ricattare e uccidere. Gli lava camicie e pantaloni e fa finta di niente, non nota le macchie di sperma e di sangue; la sua lavatrice toglie ogni macchia che lei vede. Che lei vede ma non vede. Come tutto del resto, nella sua vita: vede ma non vede.
Passa molto tempo nei pressi della casa, a guardare le luci alle finestre, i movimenti di lui e lei. In silenzio osserva, immagina, studia e spesso si accorge eccitata mentre fantastica di ucciderlo con le proprie mani: bucargli il collo con le dita e cercargli il cuore, strapparglielo dal torace e schiacciarlo sotto i piedi come si farebbe con un insetto enorme e schifoso.

Un mattino di sole, la moglie di Jack esce a fare compere ed Hèlena Thulles s’intrufola dentro casa dalla porta del retro. Gira per le stanze e rimane esterrefatta dalla pulizia. Chi pulisce là dentro pare sia un’anima condannata all’inferno, costretta per l’eternità in ginocchio a lavare le colpe e i crimini di cui si è resa complice. La casa è strigliata, il manto della casa è talmente teso e tirato che le si possono vedere le ossa. Tutto è in ordine. È pieno di fiori, cornici che tuttavia sono appoggiate su quella che somiglia a una lapide tombale. La moquette bianca sembra marmo di cimitero, anche gli sportelli della cucina, i mobili, sembrano marmo di cimitero. Da nessuna parte ci sono tracce di intimità, di colloqui, di vita, di amore. Una tomba adornata. E la verità è il cadavere. Viene colpita da questo pensiero con una forza tale che le fa cedere le gambe. Occorre che la verità resusciti, che memorie dall’oltretomba accorrano alla mente di quella signora dal vitino di vespa.
Prima di uscire guarda le foto appese al muro. Non c’è dubbio: sono opera della moglie. Mormorano di cose lugubri e nere. Vorrebbe scrutarle sotto una lente d’ingrandimento, come se fossero una miniatura medievale. L’occhio che le ha scattate appartiene a una persona pronta a prendere in mano la verità e tirare il grilletto, resuscitare il passato e spararlo sul corpo del marito.
Hèlena Thulles, durante le lunghe giornate passate in biblioteca a ripararsi dal freddo si è addentrata dentro una foresta di storie, di azioni, di favole, di fatti verosimili e impressionanti; di resoconti e gesti disperati o geniali, finché ha deciso di percorrere un sentiero fino in fondo, quello battuto tempo prima da Mesmer.
Prima d’incamminarsi verso l’ipnosi però, i sentieri percorsi per metà o appena adocchiati, sono stati innumerevoli: ha potuto vedere cosa sia in grado d’immaginare l’uomo e cosa sia capace di escogitare.
C’è, tra le altre, una mossa del pensiero letta in un libro che non riesce a togliersi dalla mente. Si tratta di un frammento del poema di Omero, il più eccitante: Odisseo e il cavallo di Troia. I greci avevano le armi ma non bastavano a espugnare Troia. Anche lei ha le armi: una pistola e l’ipnosi, ma le manca un dono, un dono avvelenato. Il tremendo cavallo di Troia lasciato alle mura della città. Giorno dopo giorno la signora dai guanti bianchi gira per casa e riflette, mentre venditori a porta a porta suonano il suo e gli altri campanelli per vendere bibbie, polizze, spazzole e prodotti per la casa; lei non risponde neppure. Gira di stanza in stanza, pensa al poema di Omero, oppure li guarda dalla finestra, dietro la tenda avvicinarsi alla porta.
Un giorno però arriva un giovanotto che pare porti con sé un fucile. Lo osserva camminare verso l’ingresso, esageratamente sicuro di sé. Si ferma un istante davanti la porta, si schiarisce al voce e poi suona.
Lei apre la porta e lo fissa diritto negli occhi, gli chiede di accomodarsi e al solito, l’aria, la realtà, rallentano. Il giovane comincia ad elencare le novità dell’Hoover 1124 di un riposante azzurro bianco. Ma mentre illustra e spiega, incespica e si confonde.
Jason, il venditore, ha cominciato a fare questo lavoro per addomesticare la balbuzie. Ma quella casa, e quella donna dal volto gentile, lo fanno vergognare, non riesce a capire cosa gli sia preso. Racconta della schiuma appositamente pensata per le moquette; vorrebbe darne una dimostrazione ma a casa della signora dai guanti bianchi non c’è moquette. Gli tremano le mani, suda, ha le orecchie rosse e sente dopo molto tempo le parole nella gola trasformarsi in bolle, urtarsi tra loro ed esplodere in tanti pezzi mentre sono sul punto di uscire.
La signora gli porta un bicchier d’acqua e gli dice: “Deve essere molto stanco, si accomodi pure sul divano, si riposi un po’ – e poi aggiunge – : Ma prima, per farti perdonare quella tua cosa vergognosa, prendi un aspirapolvere nel baule della tua auto e lascialo a fianco dell’ingresso, qui fuori. Io dimenticherò che non sei guarito e tu dimenticherai di avermi lasciato il tuo attrezzo… Si accomodi, la prego!”
Cinguetta ancora una volta.
“Certo, certamente signora, risponde Jason”. Esce di casa, apre il baule, prende l’aspirapolvere e poi si siede sul divano. Restano a parlare, non si ricorda di cosa, la sua balbuzie è scomparsa e quella signora è la soluzione, sente che è la messaggera di un mondo in cui quella pietosa goffaggine non esiste. Darebbe qualsiasi cosa a quella presenza celestiale.
Quando Jason, passo inquieto, sale in auto per andarsene, la signora dai guanti bianchi guarda il suo cavallo di Troia.
Trascorre una settimana senza mettere il naso fuori casa, a pensare. Pensa così intensamente che il pensiero comincia a prendere i connotati di meditazione. Cammina tra aspirapolvere e Lady Smith, la bestiola cromata. In mente ha l’incontro che presto avverrà tra lei e la moglie di Jack the ripper.

Spesso si ferma in mezzo al soggiorno e chiude gli occhi: con la mente rivede le foto appese al muro e la casa di Jack e sua moglie, ci sono informazioni, tracce che sente debbano essere capite e sentite con una parte di sé che va oltre l’ipnosi, che abita lontana ma esiste, proprio da qualche parte della sua mente. Rivede le foto appese al muro, proiezioni di una mente raminga, o più probabilmente amuleti per tenere lontani gli spiriti cattivi. Per il resto, la casa è igiene pura. C’è però un crepaccio tra la pulizia della casa e lo sporco delle foto. E non capisce se quelle cose appese al muro siano un tentativo grottesco di complicità con la parte oscura di suo marito, o se invece si tratta di semplice raccapriccio, pagine di un taccuino dove la donna annota l’incubo che è la sua vita.
Quale delle due?
Si sveglia che non sono ancora le quattro. Ha da rammendare, spazzolare e cucire. Apre la finestra del soggiorno e guarda il buio color mirtillo, denso come sciroppo. I profumi degli alberi. Gli aceri e la cassia le fanno dilatare le narici e inspirare a fondo. Le foglie scintillano nel buio producendo rumore di vetro e sabbia. Pensa a un verso di una poesia letta in biblioteca: Aprile è il più crudele dei mesi. È vero, quel tale ha ragione, anche se non saprebbe dire perché. Forse per la bellezza struggente della primavera che sboccia e già sfugge.
Accende la radio che a quell’ora trasmette canzoni italiane: perché muratori e operai della contea che si preparano per andare al lavoro sono per lo più immigrati italiani. Prende il vestito che dovrà indossare, accende la lampada e ricuce l’orlo. Una canzone, si dice, che l’italiano che canta deve aver dedicato a una certa Mary Lou. La voce alla radio ha detto che a cantare è un certo Teeno Roussi. Ascolta la musica di quel paese lontano che non vedrà mai. Il suono s’intreccia al rumore delle foglie, bisbigli di timidi fantasmi.
Guarda la pistola sul tavolo, carica. Posa ago e filo e la prende in mano, toglie i proiettili cromati, come lunghi occhi chiusi, palpebre pitturate d’argento. Occhi che una volta scagliati nel corpo si spalancheranno per stanare l’anima di quell’uomo.
Ripensa al cavallo di Troia. Come un sogno, di notte, un enorme cavallo di legno entra nella città e partorisce l’incubo peggiore dei troiani che vengono assaliti dai loro doppi. È quel che farà lei. Passerà quell’arma alla donna, sua gemella; sarà un fantasma a lasciare un oggetto nella mano di una donna vera e viva.
Ha quasi terminato il suo lavoro. L’attende una doccia, i capelli e la cipria e una sfumatura di rossetto rosa. Si alza e guarda alla finestra. È quasi giorno. Una linea dorata che si allarga, come una favolosa tempesta di sabbia lucente che avanza e si apre un varco tra il blu cobalto del cielo. Il sole che arriva. Il giorno che viene.
Questo è il giorno.
Fuma l’ultima sigaretta e poi indossa i guanti bianchi. L’aspirapolvere è già in auto. Prima d’indossare il suo cappellino rotondo, da donna innocua e sognante, guarda i suoi riccioli stanchi. Una tristezza indicibile le attraversa il corpo. Il silenzio della casa viene travolto da una esplosione di malinconia.
Pensieri inestricabili la spingono a guardare a quello che è stato, come la sua famiglia quasi per magia si sia disintegrata; per difendersi si è lasciata mangiare il cuore e divorare una figlia. E guarda anche a quel che sarà, quel che presto sarà. Prima di uscire prende un disco ancora sigillato; il marito per amore e distrazione ne aveva comperate due copie, si tratta di Debussy suonato da Svjatoslav Richter, pianista russo dal suono timidissimo; le note sono atomi di luce lunare che nuotano attraverso il buio.
Son circa le dieci, tra meno di venti minuti suonerà alla porta. Pensa e ripensa all’ipnosi, la tecnica, il dono, la sensibilità che ha per individuare un punto della realtà, trasferirlo su uno specchio immaginario e rovesciarlo. Si ripete che una persona ipnotizzata non farà mai qualcosa contro i propri desideri e principi. Quella donna deve desiderare la morte del proprio marito. Ma soprattutto, deve desiderare di eliminarlo. Mentre guida ricorda il suo di marito e al modo in cui pronunciava Debussy: debiùssi. E a lei quel suono aveva sempre fatto venire in mente la parole abysses: abìsses. Gli abissi, già, presto lei si calerà negli abissi. Sta per suonare alla porta e una volta dentro, ecco gli abissi le staranno di fronte.
Tiene il disco sotto il braccio sinistro mentre il cavallo bianco e azzurro sta di fronte a lei. Lady Smith da dentro la borsetta le preme sul fianco. Sospira e poi suona il campanello. Sente dei passi veloci venire verso la porta. Respira, chiude gli occhi, e respira ancora una volta.
E la porta si apre: un folata di avorio, il vestito, la moquette e il sorriso; capelli biondi a tratti incendiati da sfumature ramate. Gli occhi della donna calano sull’aspirapolvere e poi, disorientati, sul disco.
Hèlena Thulles intravede gli interni e sì, sono una cripta, una tomba in attesa di un cadavere.
“È stata estratta a sorte tra le casalinghe di questa contea! Esordisce. La nostra azienda ha deciso di regalarle questo magnifico aspirapolvere, dice mentre carezza coi guanti il manico cromato.”
Questa volta fatica a lasciare scivolare le parole nell’aria ma aggancia lo sguardo azzurro della donna e lo imbeve con la molle tenebra dei suoi occhi.
La prego entri. Gli occhi della donna, guizzano meccanici e perplessi sul disco. Sì, l’aspirapolvere lo ha capito, probabilmente lo ha vinto e sarà suo, ma il disco? La donna dai guanti bianchi si presenta – Hèlena Thulls – fa scivolare il suo cavallo di Troia dentro casa e comincia a parlare del disco.
“Molto probabilmente si chiederà il perché di questo? Serve semplicemente a dimostrarle quanto silenzioso è il nostro 1124. Vedrà che potrà passarlo sulla sua moquette e assieme ascoltare la musica, sarà come danzare. E la sua casa… La sua reggia anzi sarà sempre linda a e sontuosa come il castello di una principessa malinconica in attesa del suo principe azzurro”.
Al suono della parola “malinconica” la donna s’irrigidisce; Hèlena sente il sorriso tramontare e i tendini tirarsi.
“Certo non è questo il suo caso – continua –, un donna incantevole come lei non potrà mai essere una principessa malinconica”.
E invece lo è, molto, molto malinconica. E infatti sente istintiva la voglia di accendere l’aspirapolvere, come a cancellare quella macchia del linguaggio.
“Le andrebbe una limonata?” Sente il bisogno di allontanarsi da quella figura che pare sbucata da un sogno antico.
Certo, perché no? Le dispiace se suono il disco? Anche questo è un omaggio della nostra casa.
La sente armeggiare in cucina: cubetti di ghiaccio tintinnano contro il vetro e infine il tonfo sordo dello sportello del frigo che si chiude.
Hèlena adagia il disco sul piatto, il vinile nero e lucido comincia a girare come la pozione magica dentro il pentolone di una strega.
La donna entra in salotto con i due bicchieri, ancora sorridente, mentre le note inondano la casa come un mare di velluto e luna. Hèlena si accorge che le mani della donna tremano. Quel tremolio è una parte di sé che si stacca dal resto del corpo, un’inondazione dolce la porta via dalla realtà alla quale è rimasta disperatamente attaccata come a una zattera di legno fradicio.
E la signora dai guanti bianchi è là, in mezzo al mare, che l’aspetta.
Lascia accomodare sul divano la signora dai guanti bianchi. Le note di Debussy portano la notte, mentre l’1124 scorre sulla moquette creando un suono dolce di bufera. Il salotto diventa un sentiero, il rumore un vento caldo, e la musica gli alberi che guardano.
La realtà ora si fissa allo specchio, la signora dai guanti bianchi con quella sinfonia sdoppia la realtà. La donna è ferma sul divano ma qualcosa dentro di lei si è alzato e sta di fronte ad Hèlena Thulls che ora vede dolore, risentimento, odio, fragilità e furia. La impalpabile materia di cui è fatta la donna prende corpo.
La signora dai guanti bianchi sente che è arrivato il momento di parlare. Lascia l’aspirapolvere acceso e siede di fronte alla donna. Ora si trovano in un bosco.
“È una cosa orrenda sentirsi sole”. I due sguardi si baciano. “È una cosa orrenda nutrire una belva. È sempre notte qui dentro. Mi dia la mano. Questa è una torcia, è il fuoco, sono sguardi che porteranno luce qui, dentro questa foresta fatata. Deve solo accenderla”. Le offre la mano, la donna la prende. Ma quella mano non è vuota, c’è un corpo fatto di calore e luce.
“Ci sono sei occhi qui dentro, argentei come la luna, ma con sé portano il sole, la luce e la vita. Abbandonale, esci da queste tenebre.”
La donna prende l’arma e lascia cadere il braccio, la mano ora indossa quell’anello. Un dito, l’indice, indossa l’anello. Si sta celebrando il matrimonio tra la donna e uno dei suoi desideri, anzi il suo desiderio più profondo. Riportare la luce della verità dentro quel bosco. La donna ha lo sguardo fermo e colmo di passione.
La signora dai guanti bianchi lascia la casa. Le note di Debussy scorrono, mentre l’aspirapolvere continua a soffiare quel vento caldo che le scompiglia di follia occhi e pensieri.
Le mani coperte dai guanti bianchi sono ferme sul volante dell’auto. Si accorge di tenere il collo incassato tra le spalle, come se da un momento all’altro dovesse sentire uno scoppio. E in quello stato di velenosa allerta passa tutta la giornata.
I rumori della città: uno scatto d’ira che si riversa sul clacson, improvvise frenate di auto; scoppi di voci di bambini che giocano, la fanno girare di scatto come se fosse un pistola a parlare. Un cane che abbaia a scatti, bau e si ferma, bau e si ferma, bau e si ferma. Come proiettili esplosi interrotti da un frammento di tempo. Ogni manifestazione della realtà, ogni suono le sembra una pistola che spara. Impossibile che alla distanza dalla quale si trova possa sentire la voce di Lady Smith.
Ha rivolto la poltrona verso la finestra e fissa le tende semitrasparenti tirate. Ciò che vede dunque sono ombre, sagome, proiezioni su uno schermo, come se fosse un film, un film che si concluderà con un omicidio.
La donna invece non fa nulla. La casa è pulita, immobile, come anche lei. Continua ad ascoltare Debussy e sogna di essere ancora dentro se stessa, dentro quel bosco creato da una serie di parole, musica e rumore.
Deve cadere, deve cadere, deve cadere, sembra dicano i battiti dentro la sua mente. Perché non si tratta di pensieri ma sensazioni compatte che colpo dopo colpo e passo dopo passo si addentrano in fondo, dove la sua mente finisce e comincia qualche cosa di vasto e oscuro. L’impasto del cervello viene invaso da scosse e colpi. Se potesse trasformare in parole questi rumori che stanno impossessandosi della sua mente; se dovesse pronunciare parole intellegibili per articolare quei rumori, allora direbbe: “Deve cadere”.
La donna resta seduta con il braccio destro disteso e la pistola in pugno, e lo sguardo rivolto verso la porta d’ingresso.
Quando la chiave viene infilata con violenta rapidità nella serratura, non alza gli occhi. Sente il corpo del marito occupare uno spazio vuoto, fermo dinnanzi all’ingresso. Sente lo sguardo di lui calare nella penombra, tra musica e abat-jour. Si dice che forse la moglie è leggermente sedata dall’alcol; si accorge, o forse no, che alla fine di quella mano comincia una pistola compatta e argentea. Saluta pigro, toglie l’impermeabile, lo appende all’attaccapanni e si volta di nuovo verso la moglie e dice: “C’è un odore strano qui”.
Sente la voce della moglie dire: “Sì, c’è un odore strano. Ora però dormi”.
La donna con lentezza alza la mano e poi tende il braccio; tira il grilletto tre volte. Poi il silenzio si riempie di fumo, dalla canna esce luce bianca e blu cobalto.
L’uomo rimane fermo per alcuni istanti, gli occhi increduli tra poco diventeranno vetro.
Gli spari sono tre fotogrammi che catturano un tramonto maestoso. Tre momenti diversi in cui Jack the ripper viene spinto con delicata fermezza lontano, fuori dalla vita. Jack the ripper tramonta.

Poi il silenzio, tranne la musica del mese di aprile, gli oggetti che sempre là fuori mormorano, le auto, le foglie, il ticchettare delle unghie di un cane, il cavo ad alta tensione che sibila e ronza e poi la sirena delle auto della polizia.
Arriva il medico legale, il fotografo e il giornalista del quotidiano locale. La donna sta sul marciapiede davanti a casa, nella notte che sembra le labbra, la bocca, l’interno della bocca di una donna e il suo fiato caldo e profumato.
Lei se ne sta con un soprabito sulle spalle come una Cenerentola che fissa il vuoto. L’incantesimo si è spezzato. Dove c’era un bosco, presenze, è rimasta solo la realtà; Almeno così deve pensarla un ragazzino che cammina sull’altro lato della strada, riccio, leggermente sovrappeso, estremamente inquieto. Rallenta il passo e guarda quel gruppo di persone. Lui sa chi abita quella casa. Guarda la scena e capisce tutto, e non solo. Non si limita a capire i fatti ma li trasferisce in un’altra dimensione che vive tra il suo sguardo e la realtà. Parole, immagini, un territorio ancora brullo e deserto che lentamente, mese dopo mese, si sta popolando.
Viene colpito dalla ferocia dei flash del fotografo che sparano sul corpo della donna, sulla casa, sulla sagoma coperta dal lenzuolo. La faccia del fotografo è eccitata e malvagia. Le venderà come cartoline, pensa, e vorrebbe annotarsi quel pensiero mentre guarda la via desolata, immobile, ognuno dentro la propria casa che sembra una roccaforte ostinata a non lasciare penetrare la disperazione che scorre per la strada; tutti sordi al dolore del mondo.
Vede i poliziotti, anche loro eccitati: avevano bisogno di quell’omicidio, avevano bisogno di una morte per sentirsi più vivi.
E poi, poi vede gli occhi della donna guardare verso lui, la moglie di Jack the ripper lo guarda. La donna batte le palpebre e il ragazzino è talmente sensibile che pare sentire il suono di quel battito. L’ha già soprannominata Cenerentola: l’aria consumata e triste e smarrita delle donne che spazzano la strada, le ultime. E continua a camminare dicendosi che l’unico suono che rimane in questa via deserta e desolata è il rumore del tumulto pigro e intermittente delle foglie, come se qualcuno spazzasse il marciapiede, dopo che se ne sono andati tutti. Cenerentola che spazza il marciapiede. Vorrebbe annotarsi tutto e con quelle immagine scrivere una canzone, una poesia. Ma poi si dimentica le parole, ne mastica altre. “Il commissario che sembra in trance”. Sì, sì, ripete mentre cammina. E sente un’euforia calda. Mentre i suoni di quel gruppo di persone si allontanano, perché lui continua a camminare. A dire il vero è lui che si allontana ma quei suoni lo seguono invisibili come fantasmi. Lo seguono e seguiranno, nello spazio e soprattutto nel tempo.
di Andrea Inglese
Io ho sempre vissuto in un posto dicendomi che quello non era il mio posto, che è una cosa comune, ma è comune fino a un certo punto, perché il problema della sede naturale, di quale sia la nostra sede naturale, è vastissimo, e una vita intera di certo non permette di risolverlo, anche chi si rimette alla grandi coperture monoteistiche, alle solide volte dottrinarie, quelle campate in aria, lo sa, la sede naturale è sempre duplice, almeno, contempla viaggi e ritorni, città celesti ma anche grotte e cunicoli putrescenti, capanni incendiati, baite di montagna innevate sui fianchi e contro cui sbatte il vento.
di Stefano Biolchini
Anche quel sabato uguale a tutti gli altri Adele aveva per prima cosa riassettato con precisione millimetrica il rullo degli scontrini nel registratore di cassa. Lo faceva con grazia quasi materna, lei che non aveva figli, facendo slittare le dita fino a sentire appena un roco click. Si era poi aggiustata i capelli che le si erano abbarbicati fin sopra gli occhiali con una infastidita smorfia meccanica che coinvolgeva la mano e anche i più piccoli muscoli della faccia, per poi riallineare, una dipresso all’altra per colore ed altezze, le penne sul banco. Scivolando da dietro allo sgabello di legno aveva afferrato il piumino che faceva di lei la vestale consueta di tutti quei libri. Passava e ripassava sminuzzando in poltiglia invisibile i granelli impercettibili ai clienti, ma non al suo occhio attento, che si erano accumulati durante la settimana.
Appena un sabato prima aveva fatto le stesse cose tra i ripiani di saggistica e sui volumi incellofanati di narrativa come sui tavoli che scorrevano quasi incessanti dall’ingresso alla parete maestra, con le novità del mese impilate in bella mostra e con i più venduti che si allungavano in cattedrali gotiche facendo d’angoli acuti equilibri inaspettati che appena il soffio di una carezza o, peggio, lo sbadato sfiorare di una borsa o di un’anca maldestra, avrebbero reso in fragore di crollo. E fu il piumino agitato a rovesciare dal fondo di un ripiano appena in aggetto una lente che sbattendo prima su un volume e poi sul pavimento di vecchi ottagoni a scacchiera si scheggiò appena su un lato. Adele fu lesta a raccoglierla, e con fastidio l’occhio fissò sconsolato la minuscola abrasione che aveva ferito quel cerchio trasparente.
“La lente del professore” disse innalzando la voce in solitaria fino agli acuti, “l’avevamo tanto cercata, e con quanta cortesia mi si era raccomandato”.
Le venne in mente che non lo vedeva da mesi, mentre il suo cervello si alambiccava sui perché e sui per come non la avessero trovata allora, e come avesse potuto resistere così a lungo alle sue attenzioni serrate e costanti. Quasi rimproverandosi, ne fu infastidita per aver così tanto mancato al suo imperativo d’ordine e pulizia che le rendeva in fondo tutto più stancante, e dio sa quanto se ne lamentava, eppure così rassicurante. Così pensava, quando le tornò alla mente che il professore abitava anche lui nella via San Vittore, appena dall’altro capo. Era stata Pina la portinaia che una volta, vedendolo passare davanti all’ingresso mentre lucidava gli ottoni, le aveva raccontato della moglie, quella signora così raffinata con i guanti all’uncinetto e il cappello e le spille di draghi e serpenti, che era una delle Visconti, proprietaria di gran lignaggio dell’antico palazzo con lo stemma consunto sbeccato e illeggibile appena sopra il portone di legno laccato di verde lucente.
”Quella sì che è una vera signora” aveva detto la vecchia Pina “e io che dal mio oblò le vedo tutte sfilare, me ne intendo di signore raffinate dopo quarant’anni di portineria” aveva poi aggiunto accrescendo la propria autostima.
Glielo doveva. Con lei poi era stato sempre molto gentile, e i cinquanta euro di mancia a Natale il professore e gran latinista non li faceva mancare mai, sicuri come il giorno e la notte. Era forse il miglior cliente della libreria, non aveva dubbio. E poi ne era curiosa: sarà stato male, pensava, non volendo neppure badare al peggio che le passava per la mente. “Lo avrebbe saputo” si consolò, “no, forse era solo partito”. “Ma poi per dove e senza passare in libreria per i nuovi arrivi” questo poi le risultava così strano! E la moglie che tanto le piaceva, non la vedeva da molto, pensò.
Subito si risolse.
Alla chiusura di colazione avrebbe abbassato la claire, rinunciando a mangiare composta sul tavolino del retrobottega le polpette che aveva portato da casa, e il professore avrebbe così riavuto la lente del suo monocolo d’oro.
“Peccato solo per quella piccola fêlée”. Lo diceva tra sé e sé, nominandola in francese, per paura di accrescerla, la vigliacca rovinosa appena sul bordo, quasi a renderla leggera nella parola e quindi impercettibile. “Che peccato davvero”, rimuginava.
Alle 12 e trenta in punto chiuse il negozio e si avviò.
Il passo veloce e la lente ben sistemata in un fazzoletto di lino con la A ricamata da sua madre e i lembi ripiegati all’indietro giusto a lasciare l’iniziale in vista. Il palazzo doveva essere quello, lo intravedeva appena oltre il Museo e la piazza che si era lasciata sulla destra. Era agitata al pensiero di quella casa di gran signori. L’avrebbero fatta entrare? si domandò preoccupata e con lo sguardo trasognato. Ancora pochi passi e il grande portone le era davanti. Spalancato. Lo riconobbe subito, anche se per la polvere, che subito rilevò, non luceva. Anzi, là tutto, fin dai muri sbrecciati con i vasi di sterpi ingiallite, le appariva fané e in abbandono.
Il citofono d’ottone riportava pochi numeri e poi per esteso, giù in basso l’Alonso d’Attorre Visconti. Si consolò, eccolo il professor Alonso d’Attorre, ripeté contenta movendo la testa come sempre faceva con la fanciullesca goffaggine di signorina attempata.
Entrò in cerca della portineria, ma non c’era nessuno. Chiamò il concierge. Nessuno. Si guardò intorno alzando gli occhi ai capitelli delle colonne dell’atrio che si apriva alla corte. Tutto brillava di ruggine spenta dove le ragnatele facevano un manto. Sulla destra una scala, piccola con l’accesso in cimasa sormontato da decori in rilievo di fiori scolpiti e da tempo appassiti. Si fece avanti fino ai gradini dove si apriva un ingresso. La targhetta ossidata diceva Alonso d’Attorre. Non si capiva subito ma era così. Un moto d’orgoglio per la scelta azzeccata la rese contenta. Fece per suonare e sfiorandola appena la porta si aperse. Si ritrasse, ne ebbe paura. Sentì allora un fioco gemito come di dolore, provenire dall’interno. Si fece coraggio, si mosse in avanti ed entrò. Il rantolo proseguiva, l’odore era pungente, anzi fetido. Si strinse sul naso il foulard che portava sempre annodato da un lato per celare le rughe sul collo, e appena tremante chiamo’: “professor d’Attorre, sta bene, sono io, Adele, la libraia”.
Le veniva da vomitare per l’odore nauseante che penetrava fin dentro ai polmoni. Il rantolo proseguiva oltre l’ingresso buio.
Fece due passi fino alla porta con la grande cimasa. E lì vide un muro. Di libri su libri. Accatastati in pile sconnesse, stretti forte d’inutili abbracci, era scempio di Seneca, Cesare, Lucrezio, Aulo Gellio e Plutarco e Sallustio. I giornali e i romanzi e i tascabili marcivano tra i compendi e gli studi di critica antica e di filologia. Arrivavano quegli inutili tomi ingialliti fino al soffitto riempiendo la stanza accecata di luce e di aria. Uno spreco inaudito, anni e anni di studi e ricerche e pubblicazioni a suo nome svaniti in un macero autopunitivo d’incuria e di odio e rancore. E nel mentre, arrampicatasi sulla scala a pioli adagiata su quella montagna di volumi impazziti, lo vide.
Immobilizzato e dolorante, stava li rannicchiato, il tempo sospeso nella carta che si appallottolava di escrementi e pipì, il volto smagrito e sofferente. “I miei libri, voglio morire di libri soffocato da inutili parole d’inchiostro. A cosa mi valsero? Cui bono?” diceva, ripetendosi in una cantilena di strazi, guardandola smarrito.
Adele si fece coraggio, la nausea appena respinta alla bocca. Il plafond incombente con il lampadario sommerso dagli accumuli e l’odore acre di pagine marcite e di muffe mortifere non lasciavano spazio al respiro. Le carte e i frontespizi ammassati in decomposizione sormontavano ogni cosa. Effluvi di parole in vortice dai caratteri trasudavano da ogni dove, li percepiva anche lei, li vedeva perfino, opprimenti e invasivi. Mostri marini di nero seppiato facevano capo tra le pagine insieme a foto sbiadite e a capilettera violenti, inseguiti da esclamativi di lame assassine.
La vista le si annebbiava d’incubi repressi troppo a lungo, gli tese la mano, allungandosi sulla scala. E lui gliela strinse. “Professore sta male” disse soltanto mentre l’orrore le invadeva la schiena. E strano a dirsi, in quell’attimo, e per un attimo soltanto, lo amò, come non aveva mai amato nessuno.
“I miei libri, va bene” biascicava lui.
Non sapendo che fare, non riuscendo neppure a vederne la figura avvolta nei ritagli di pagine, ridiscese la scala per chiamare in aiuto.
“Torno subito a lei professore” soltanto gli disse col groppo alla gola. E voltando lo sguardo, vide una luce fare lama fra gli angoli d’ombra della porta. Si protese curiosa, la testa in avanti oltre la stanza, ed era lì un catafalco, e distesa fra due candelieri accesi da una vecchia lampadina, una donna col volto nero imputridito e solo i guanti bianchi di pizzo, sulle mani rinsecchite di mummia incartapecorita, piegati in croce tenevano un libro adagiato sul petto. La signora, era morta da troppo e da quando?
Almeno lei però era stata molto amata, pensò, e ne ebbe invidia financo. “Così altera nei lineamenti perlati, il professore non poteva lasciarla andar via così, elegante com’era seppur morta stecchita”.
Poi un capogiro insopportabile, con le gambe tremanti: le venne da svenire. Scappò via inorridita. La inseguivano i lamenti: “Fermate i miei libri, impazziti al galoppo, chiudete le porte, mi assalgono e ululano e graffiano e mordono. Lacrimano sangue, i maledetti. All’Auto da fè, favorite un cerino” perentorio ordinava agli allievi ex cathedra il docente che era. “Neppure il fuoco li farebbe arretrare” si rispondeva poi sconsolato con terribile voce in falsetto di indemoniato alla gogna. Il professore, dall’alto della sua tomba di carta, non aveva più requie: le mani al soffitto graffiavano, la voce gutturale impazzita.
Adele correva, al negozio e per strada. Urtò prima un paletto, la borsa le fece da scudo, e la sciarpa di seta, la sua preferita con le palme di cachemire nei toni più pallidi del verde e violetto, volò quasi foglia sul catrame terroso: un’auto l’annerì di polvere e gomma, trascinandola appresso smarrita.
Poi per quella giornata milanese fu tutto un rincorrersi di voci e sirene, e ambulanze e necrofori e parenti ignorati e ora anche i vicini di casa sbadati ed assenti e i curiosi. L’esimio latinista e cattedratico era ben noto, la signora dal blasone abbrunito ancora imponente, ammirata per echi di fama lontana.
Adele smarrita affannava tra scaffali e collane e volumi in prima edizione e best seller, stupita d’orrore. Poi le lacrime, a riempire gli occhi cerchiati d’azzurro e avvampati di sonno. Si mosse, frugò nella borsa, ridestandosi e aggiustando la gonna lunga fino al ginocchio. Era stanca, mentre dissolvenze di immagini morte in agguato e veloci in sequenza, le varcavano il capo già incredulo; ed era troppo per lei, e lo sapeva. Quanti fastidi e vergogna: sconsolata si reggeva la testa, con la polizia in attesa giusto appena all’ingresso della libreria; e pensava ai vicini irridenti, mentre la radio dalla centrale gracchiava parole incomprese. Immerse così nella borsetta la mano veloce a cercare il fazzoletto ricamato che s’avviluppa. Dentro soltanto i frantumi di una lente impossibile da ricomporre, come il tempo che segnava di macchie le sue mani di donna sfiorita e sola. Alla sera, non ebbe la forza di leggere neppure una riga fra le molte che avrebbe voluto e che sole le davano il conforto mancato nel grande letto sempre vuoto di bianco abbagliante. Preoccupata com’era, in quella assurda notte di un triste sabato d’abbandono ci pensava di continuo, senza mai riuscire a prendere sonno: ah il latinista, non ci fosse mai andata!
di Gianni Biondillo
Jo Nesbø, Il confessore, 542 pagine, traduzione di Maria Teresa Cattaneo, Einaudi, 2014
Sonny Lofthus è Il confessore, un eroinomane che s’incolpa dei delitti altrui per espiare le colpe di un padre poliziotto corrotto e suicida. Ma la verità, dopo dodici anni di prigionia, sembra un’altra. Sonny decide perciò di fuggire dal carcere di massima sicurezza e portare a termine il suo piano di vendetta. L’unico che ha capito cosa collega la serie di omicidi che tempestano il romanzo è l’ispettore capo Simon Kefas ex collega del padre di Sonny. La caccia all’uomo diventa così una caccia alle verità recondite di un passato comune.
Quando ci saremo lasciati alle spalle la deleteria moda per il giallo scandinavo saranno pochi i nomi che ricorderemo. Fra questi probabilmente Jo Nesbø. Non certo per lo scavo psicologico dei suoi personaggi – Sonny sembra tagliato con l’accetta, spigoloso e senza profondità, molto meglio il suo deuteragonista, per quanto altrettanto stereotipato (solitario, a un passo dalla pensione, con doti intuitive uniche, etc.)-, né per la scrittura, che manca di ricerca linguistica tutta tesa com’è a raccontare per immagini cinematografiche (pare una sceneggiatura), e neppure per la lettura sociale del territorio, Oslo, tranne che per alcuni involontari esotismi causati dai nomi dei quartieri o delle strade, sembra una qualsiasi metropoli tentacolare dove la malavita internazionale impazza senza regole.
La forza di Nesbø sta nel mantenere la promessa che fa al lettore: leggerai per oltre 500 pagine senza annoiarti mai. Il dispositivo che ho fabbricato per te sarà complesso (e tutto da decrittare) eppure fatto di elementi che già conosci, di modo che non ti perderai mai per davvero.
Nesbø è un artigiano, un orologiaio. Il bello per lui non sta nel decoro, nell’intaglio, nella nobiltà del metallo. Sta nel meccanismo. Inesorabile.
(precedentemente pubblicato su Cooperazione, n° 3 del 13 gennaio 2015)
di Mariasole Ariot
Un passaggio interno : occhio ad occhio in sequenza successiva Lili Hofer (Bolzano 26.2.1984 – Bastia 2.6.2015) ha lasciato questi testi a Flavio : un resto di ciò che resta, la presenza viva di un’assenza. E Flavio, attraverso una finestrella che si apre e ci apre al mondo [il micro/macro cosmo della Hofer, a ciò che stava fuori, che attraversa il mezzo], li passa a noi con un appunto :
Per un’antologia di poeti scomparsi. Possiedo un campo in provincia di Parma, poso le lapidi.
Dunque posiamo la lapide, le apponiamo un nome, ingrandiamo le immagini.
I processi di ingrandimento delle immagini
La prima volta, inattesa e desiderata,
che un uomo mi scrive.
Forse ci incontreremo,
passeremo qualche giorno insieme.
I.
Il libro è aperto sul tappeto
della camera dell’albergo.
I due si incontrano
in quella bambola di Bellmer
dove la voce
smette di somigliare alle parole.
Guardandoci così da lontano
siamo legati a ciò che resta nascosto,
amore mio.
Fort La Haine, Mons.
II.
decostruzione di un’attesa
una stella, dicevi, una luce cadente
io bruciavo, non ancora baciata
radicina, tu
ti strappo via
girando in bocca
una caramella
III.
Ci sdraiamo a pancia in su
pensiamo che il sole non esista,
una coperta gialla e azzurra.
Confondiamo la cattura con il gioco.
IV.
Può rifiutarsi,
quando dirà no lui si fermerà.
Al quindicesimo minuto
stanno davvero scopando.
Tre ceffoni e finalmente piange
continuano come se fosse amore,
lei è innamorata,
voglio innamorarmi così.
V.
ero Caligola, folla, Rolls-Royce, tu che uccidevi la bambina,
piangevi, la delusione dei corpi abbandonati alle fantasie
diventano funzionari, commedianti, impotentii
dovevo fare un tema su un film
mi perdevo, bello o brutto sempre la solita
miseria il sogno ricorrente per cui credo
di non avere mezzi
per far fronte alla realtà
VI.
Wim Wenders. America.

Nel salone l’inquadratura
si stringe sul quadro sopra al distributore
di bottiglie di Coca Cola e al divano rosso.
Nella sequenza successiva
ci sei tu, mentre guidi.
VII.
i.
passi, stoviglie, sinfoniette
fossi qui scriveremmo insieme è tutto
pieno di colombine
ii.
ho un segno sottile sul cuore,
ti ho fatto male?
iii.
eri l’unica cosa viva nell’universo
“sono stato così vicino, così dominato nel sangue,
così intento a dominare il suo”ii
VIII.
Una notizia. La città è schiacciata sul mare.
La bora soffia sul golfo e i vetri tremano.
Vorrei rannicchiarmi in tondo come il levriere,
ho con me tre epistolari. Dormire ogni notte
in un albergo diverso.
Harry’s bar, Trieste.
IX.
i.
quando non riesco a dormire e mi dici di immaginare
animaletti elettrici, vorrei uno striscio del tuo sangue
da guardare al microscopio
ii.
alle Beaux–Arts ho trovato un quadro
che avremmo dovuto vedere insieme, una sintesi,
un leone morto assalito dalle lepri
X.
Tate Modern. Sul Tamigi
le navi coi graffiti, Stetson
1 stella marina sui tacchi
2 io e te una cattedrale, una voliera
su un dirupo
3 × 3 tutta la galleria Bourgeois
Ode à Ma Mère, suite di nove ragni
Vado a cercare le foglie, the limp leaves
Waited for rainiii
Sempre tuo, Cornell
XI.
Il levriere invita al gioco il bulldog
di ceramica alla reception.
Riscrivere tutti i viaggi
come se fossero immaginari.
Ora andiamo a scegliere il vino
a Saint Émilion. Probabilmente
perdiamo il treno. Troviamo due
lettini in soffitta, Le Moulin Fleuri.
XII.
Facciamo la gelatina dei pesci
la fregola
nelle mutande.
Cerchiamo qualcosa da mangiare.
Dovremmo essere più sinceri
ma è impossibile.
XIII.
Lungofiume, c’è il sole.
I due sparano ai papaveri,
ai diphylleia grayi che saltano in aria
come palloncini pieni di fumo.
La gente si sveglia con un cane
che gli salta sul letto.
XIV.
il dottore dice che non hai mai amato nessuno
forse questi uomini belli
sono una corda tra te e il mondo
restano anche se li rendi infelici
vorrei chiedere scusa a tutti
e in questo sono sincera
se non ho una mia statura
ma quella di ciò che vedo
Note
i A.Camus
ii F.Kafka
iii T.S.Eliot
di Elisabetta Scantamburlo
Tra le braccia grosse, morbide, e massicce tiene uno scricciolo. Un neonato tenero di appena una settimana, suo nipote, figlio della sua unica figlia. Lo tiene con naturalezza, come se il piccolo essere avesse trovato il suo posto, e lo guarda negli occhi che ancora, dicono, non vedono nulla. Attorno a lui e alla tavola su cui dormono i resti del pranzo natalizio appena consumato, i pochi parenti invitati. Da una parte gli uomini assaggiano con calma la grappa che lui ha comprato durante una delle sue ultime gite in montagna. La voce lontana della sua compagna sta raccontando di come si è messo a piangere quando sua figlia l’ha chiamato dall’ospedale per dargli la notizia. In un’altra occasione gli avrebbe dato sicuramente fastidio. In questo momento invece, che gli altri bevessero pure la grappa senza di lui, che lei parlasse e che le sue ascoltatrici sorridessero.
Accoccolato sul suo braccio, grande quanto quello, sta suo nipote, come una pietra incastonata nel modo più perfetto in un bracciale. Il piccolo aveva pianto poco prima tra le braccia del padre, ma nelle sue sembra aver trovato la pace. Ora è sveglio tuttavia e, a lui, stringe il grande indice. La manina non riesce a fare il giro della circonferenza del dito. Sì, è commosso, anche adesso, ma la gioia di avere tra le braccia quella cosina è così grande che lo fa anche ridere e i due sentimenti in lui si compensano. Pensa che quella cosina dieci giorni prima non c’era e ora è entrato nella ruota e fra dieci, vent’anni, sarà diventato qualcosa di sempre più preciso e definito di questo corpicino le cui gambette e braccia esili, lisce e rosse si muovono senza alcun controllo.
È capace così anche adesso, come il suo solito, di celare bene le sue emozioni, dietro un sorriso sardonico, immobile e ambiguo. Ma i suoi occhi, brillanti come mai, lo tradiscono a chi lo guarda bene. Il cucciolo di uomo che ha tra le braccia è così simile a sua figlia, più di trent’anni prima. Allora era la prima volta che teneva un esserino così in braccio, ma la commozione era inspiegabilmente identica. Ora sua figlia è diventata grande per davvero, è una mamma, come lo era stata la mamma di lei, sua moglie.
Sua figlia è seduta sul divano, un po’ in disparte, si riposa dalle tante attenzioni e domande rivolte a lei, dal suo iniziale entusiasmo a raccontare tutto, e dalle tante energie che la nuova vita le richiede. Guarda suo padre che tiene in braccio suo figlio. Dopo tanti anni di matrimonio nemmeno lei ci credeva più, eppure eccolo lì. Le sembra ancora impossibile di esserci riuscita, che dal suo corpo sia uscita una creatura così, perfetta. Aveva avuto paura anche, aveva temuto di morire. Chissà se sua madre aveva provato le stesse sensazioni quando era nata lei. Gli stessi timori, gli stessi dolori. Non può chiederglielo, perché da sette anni non c’è più e in questo momento la sua mancanza è ancora più forte. Se fosse vissuta un po’ di più. Se lui fosse nato prima. Pensieri che sa essere assurdi le riempiono la testa, ma almeno soffocano il desiderio di immaginare il sorriso di lei, pieno e malinconico, i suoi occhi chiari e umidi, le battute che avrebbe fatto e i discorsi che avrebbe inventato col bambino. Anche tra le braccia di sua madre il piccolo avrebbe trovato pace, non aveva dubbi. Anche lei l’avrebbe trovata quella pace, tra quelle braccia, ancora. Le mancava tanto, sempre.
Osserva suo padre che sta passando il piccolo tra le braccia della sua nuova compagna. Come l’avrebbe passato nelle braccia di sua madre. Lei l’ha accettata questa nuova donna, e le piace anche. Diversa da sua madre, in qualche modo ne condivide però una genuinità e una spontaneità discreta che lei apprezza nelle persone di quella generazione.
Sulla credenza dietro i parenti, tra le vecchie bomboniere e i piatti del Buon Ricordo, ora c’è una foto incorniciata di suo padre e di questa donna. D’accordo con suo padre avevano deciso che le altre foto, vecchie, era arrivato il momento di tenerle altrove. Lì, una volta, c’era la foto dei suoi genitori. Ora il posto di sua madre è stato occupato da un’altra. E lei l’ha accettato. Succede. La vita va avanti. Le vite e le persone trascorrono, i ruoli si scambiano, i gesti restano gli stessi. Le sfumature, solo, cambiano. E quelle sfumature sono, senza fine, mondi a parte.
di
Francesco Forlani
Sicuramente il titolo del libro aveva attirato la sua attenzione e a seguire la copertina. Si trattava di un’edizione tascabile, sans plus; sull’ombra della donna, gigantesca rispetto alla silhouette del detective, due strisce di coca sistemate con cura certosina dal critico letterario dopo averle tagliate con una carte fidélité del Monoprix. Il critico, lui, s’era fatto notare in passato per aver tuonato contro il mainstream, di tutti i generi, ma con particolare acrimonia rivolta ai gialli, poco importa quanto raffinati o politicamente a lui vicini, con la sola eccezione dell’autore del Pasticciaccio. In realtà il critico, che per certi versi ricordava Orson Welles alla fine della sua carriera, si era trasferito in Francia da una decina d’anni disertando quella società letteraria e principalmente i suoi annosi dibattiti che pure lo avevano consacrato critico e innanzitutto e per lo più feroce interprete e nume tutelare di tutte le più autentiche avanguardie.
Accanto a sé, seduta ad un tavolo un poco in disparte e in ombra, rispetto al resto della casa in cui si beveva e ballava con musica house a tutto volume, una ragazza minuta, sicuramente poeta a giudicare dal pallore e dal vestito nero che le lasciava nude le braccia, libere e conserte. Perché allora Conan Doyle? Eppure non mancavano libri in quella casa fasciata su ogni parete da altissime librerie, sicuramente fatte su misura, in legno di noce e affilate in modo che i libri ci stessero senza cedere un centimetro sui bordi. Dal critico in questione si sarebbe aspettato almeno il volume dell’Horcynus Orca appena pubblicato in Francia proprio per sua intercessione. A meno che quello che sembrava a primo acchito une place d’honneur, fosse solo il semplice supporto alla degringolada notturna e non andasse interpretato come esattamente il contrario, ovvero una vera e propria degradazione operata sul campo, da materia letteraria a semplice supporto come quando si utilizzi un libro per fare da zeppa a un mobile azzoppato. Nel caso in cui si fosse trattato di mise en valeur, però, se proprio non si poteva disporre di uno Stefano D’Arrigo sarebbe bastato un autore più modesto, perché contemporaneo, seppure alto, come quello adocchiato tra gli scaffali in tre diverse edizioni sistemate giusto di fronte, a rendere buon servigio: il Limonov di Emmanuel Carrère.
A proposito, un’altra significativa cosa accadeva da circa un paio d’ore, da quando s’erano scatenate le danze. Alcune donne, venute accompagnate dai propri mariti o compagni, non lesinavano tra una pausa e l’altra di quel felice gettito di vita, baci ad altre donne, in piena bocca, a piena lingua. Ad attirare la sua attenzione non era stata tanto la sinuosità dei corpi, il capo reclinato come in un passo di tango fa la femmina, le mani perdute tra i capelli lunghi, ma la naturalezza, ed eleganza va detto, con cui la cosa succedeva, mescolando le facce, cambiando spesso passo e partner in una sola sequenza di gesti. E così gli era sembrato che anche la poetessa, levatasi di scatto alle prime note di un pezzo dance molto in voga negli anni ottanta, Voulez-vous coucher avec moi ? (ce soir) volesse tentare il gran tour. La presa sulla giovane autrice era sicuramente attribuibile alla citazione colta contenuta nel titolo, essendo di fatto ripresa da Three Soldiers di John Dos Passos nel 1921: la frase in questione, riportata nella trascrizione americana faceva esattamente così:
« Bon soir, ma cherie,
Comment alley vous?
Si vous voulez
Couche avec moi…. »
E di certo, la ragazza che ora si scatenava nel mezzo della pista levando le braccia al cielo come Silvana Mangano in Riso Amaro, mostrando un’ombra di peli che seguendo una linea, probabilmente di sudore, sembravano un tratto di mascara tra le ciglia, sapeva sicuramente che la stessa frase ricorreva per ben due volte nella poesia Little Ladies di E. E. Cummings, scritta a un anno di distanza dall’uscita del romanzo di Capote:
(ladies
accurately dead les anglais
sont gentils et les américains
aussi,ils payent bien les américains dance
exactly in my brain voulez
vous coucher avec
moi? Non? pourquoi?)
Poco importava dunque che la domanda che gli venisse posta più di frequente quella sera non riguardava, come del resto era solita porsi fino a una decina d’anni prima, l’origine, da visibilmente straniero, o la professione, più o meno suggerita dalla maniera di vestirsi e di presentarsi, ma la sessualità. Sei eterò? Come se si fosse deciso tutto a un tratto che la propria terra non sarebbe stata più definita da un territorio ma dalla carte delle proprie ambizioni sessuali. Di certo l’altra questione rimaneva sospesa e così lo sarebbe rimasta. All’alba, ormai, i primi chiarori rivelavano in riverbero i contorni delle palazzine, fino ad allora avvolte nel buio e ora finalmente visibili come flics sbucati all’improvviso per una retata.
Sicuramente il titolo del libro aveva attirato la sua attenzione e a seguire la copertina. Si trattava di un’edizione tascabile, sans plus; sull’ombra della donna, gigantesca rispetto alla silhouette del detective, non restava più nulla.
150 anni fa veniva pubblicato Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Ho chiesto a scrittori, studiosi, appassionati di pensare un loro contributo personale per celebrare questo capolavoro del linguaggio e dell’immaginazione. I post si susseguiranno a cadenza irregolare fino all’autunno e saranno contraddistinti dal tag: 150 anni di Alice, presente anche nel titolo. I post già pubblicati si possono trovare QUI. (NDF)
di Licia Ambu
Un tale mi disse che risvegliandosi la mattina presto è meraviglioso trovare, almeno in complesso, tutte le cose allo stesso posto dove erano la sera […] il momento del risveglio è il più rischioso della giornata; una volta superato senza essere trascinati via dal proprio posto, si può stare tranquilli per tutto il giorno[1].

Alice è un frattale.
Frattale è quella figura geometrica dove un elemento ripete se stesso su scale diverse e sempre più piccole, all’infinito. Alice è un frattale del disorientamento. Alice è un frattale del sovvertimento. Una bambina senza sottrazione di possibilità,
fiduciosa, pronta ad accettare le cose più folli e impossibili con tutta quella fiducia totale che solo i sognatori conoscono; e infine, curiosa, follemente curiosa, e con l’avido godimento della Vita che viene solo nelle ore felici dell’infanzia, quando tutto è nuovo e bello.[2]
e composta da una testa, un corpo, linguaggio, nozioni e molta immaginazione. Tutti elementi che concorrono a formarne l’identità e che, cadendo nel buco, attraversano metamorfosi e mutazioni tali da fargliela perdere.
Alice che cade nel buco sognando: è proprio andare via da un’altra parte con la testa restando qui col corpo. Una fuga da fermi. Alice resta sul prato […] Quello che ti fa andare da un’altra parte con la testa è qualcosa che senti, sempre molto fisico. […] dov’è che sei tu? Nella testa o nel corpo? […] Come se il corpo richiamasse a sé la testa passando in rassegna il suo sapere per rimetterla a posto, per ritrovare un’identità: chi sono? Che ora è? Dove sono? Alice non sa più chi è. Dove ha lasciato il suo corpo e dove va con la testa?[3]
Il buco è incipit di un altrove costellato di buffe creature, un luogo basato sull’armonia universale del non senso e zeppo di roseti da ridipingere dietro cui si ordinano continuamente decapitazioni. L’immaginazione di Alice apre le danze, partendo senza riserve al seguito di un coniglio sbucato dal nulla. La sperimentazione del disorientamento ne investe tutte le parti: il suo corpo cessa di essere statico e inizia a mutare, ad allontanarsi da lei, a comprimerla, a renderla microscopica o gigante. Improvvisamente il collo si allunga talmente da farla scambiare per un serpente, e i piedi sono così lontani da farle prendere in considerazione l’idea di iniziare con loro una corrispondenza scritta. Corpo che si plasma all’evenienza esterna, ma con una regolazione senza possibili previsioni e attraverso curiosi espedienti. Una domanda di metamorfosi che serve ad appagare il desiderio ambientale: una minuscola serratura, una casa, una chiave da raggiungere. Di fronte a questo disorientamento fisico bisogna correre ai ripari, dunque la testa, come unico mezzo di salvezza, inizia a mandare a memoria le filastrocche per capire bene se le cose sono in regola. Richiamare il sapere di proprietà personale per restare ancorati, per ridefinire una realtà, per avere la certezza di non essersi persi. Si muove la testa se il corpo è fermo, si ferma la testa quasi se il corpo si muove. Ma nemmeno i versi stanno al loro posto, c’è un coniglio bianco vestito di tutto punto e Piccol’ape tutta scombinata. Le cose che Alice sapeva, e sapeva di sapere, non sono più nel posto in cui le aveva lasciate e questo può solo portare alla logica conclusione che nemmeno lei stessa si trovi più lì.
Sta a vedere che alla fin della suonata sono proprio Mabel, e mi toccherà far trasloco in quella sua baracchetta sciatta sciatta e avrò si e no uno straccio di giocattolo e, oh, quante cose che dovrò imparare daccapo! No, qui bisogna prendere una decisione: se sono Mabel non mi sposterò di un millimetro! Inutile che ficchino dentro la testa per convincermi ‘Vieni su, tesoro! Mi limiterò a guardarli dal basso in alto e dirò: ‘Ma allora chi sono? Prima me lo dite e poi, se mi andrà di essere quella persona, ritorno su, altrimenti sto qui finché non sono diventata qualcun altro… ma, oh cielo![4]
La piccola vittoriana si ritrova ad abitare un corpo senza possibile controllo, con una testa apparentemente inutile alla causa, e viceversa. Lo stesso smarrimento si gioca anche sul piano del linguaggio, stordito anche lui rispetto ai canoni. Nelle parole di questa storia, nell’impianto stesso della lingua, il suono prevale sul senso così che il significante cambia di forma, di corpo: la butterfly ha le ali fatte di burro e il racconto del topo si confonde con una coda molto lunga,
Mine is a long and a sad tale!
It is a long Tail, certainly
 La dilatazione del suono è un ventaglio di possibilità che disorienta il senso. La certezza del racconto, e del sapersi narrare, come risoluzione vacilla di fronte all’incertezza data dalla perdita di senso. Il linguaggio non è più collante ma diventa lui stesso una possibilità, una realtà alternativa. I segni che sono la convenzione vigente si bagnano, anzi sono immersi, nel suono e ne consegue un necessario negoziato costante per riportarli a casa, per ricalibrare le conoscenze al grado zero della propria verità.
La dilatazione del suono è un ventaglio di possibilità che disorienta il senso. La certezza del racconto, e del sapersi narrare, come risoluzione vacilla di fronte all’incertezza data dalla perdita di senso. Il linguaggio non è più collante ma diventa lui stesso una possibilità, una realtà alternativa. I segni che sono la convenzione vigente si bagnano, anzi sono immersi, nel suono e ne consegue un necessario negoziato costante per riportarli a casa, per ricalibrare le conoscenze al grado zero della propria verità.
Le parole che significavano una cosa ora ne abitano un’altra, riempite di una pertinenza diversa. Il linguaggio, forma di controllo e determinazione della realtà, strumento di definizione del sé per assonanza o differenza, è completamente mutato nella sostanza e dunque la percezione del reale tutto cambia. La struttura crolla, le parole non sono più loro, hanno altre identità. E se le parole che avevo per raccontarmi non sono più quelle, allora come mi racconto adesso? Mi racconto un’altra? Mi racconto Mabel o matta o serpente? Alice è proprio come una parola che deve rispondere a innumerevoli significati. Lei stessa diventa un suono pieno di possibilità di essere. In questo luogo dell’immaginazione non ci sono le stesse prove del mondo reale, l’immaginazione partorisce all’occorrenza le evidenze che le servono a darsi plausibilità e così la libertà può manifestare se stessa all’infinito, alimentando al contempo un proprio equilibrio.
Mi dici per piacere che strada devo prendere?
Dipende più che altro da dove vuoi andare, disse il Gatto
Non mi interessa tanto dove…, disse Alice
Allora una strada vale l’altra, disse il Gatto
…basta che arrivi da qualche parte, soggiunse Alice a mo’ di chiarimento.
Oh, questo è garantito al limone, disse il Gatto, basta che metti un piede dopo l’altro e ti fermi in tempo.
La testa ci prova. Corre sul binario della convenzione, della regola grammaticale delle rime per contenere un corpo che segue suoni che ne mutano la forma, sovvertono la sostanza e plasmano. E mentre il corpo dorme, invece, la testa gioca liberamente a credere che sia possibile, al facciamo finta che, Alice ci sta alle carte che non sono solo carte, al Cappellaio, ai funghi, alla quadriglia, al coniglio. La percezione del qui e ora rende l’esperienza infinita anche per ciò che dura un solo attimo, non c’è prospettiva evolutiva, ma una sorta di ripetizione del tè delle cinque e perciò il luogo in cui sei esiste nel momento in cui lo concepisci possibile, lo inventi, lo senti, lo leggi,
Perché io ho la dimensione di ciò che vedo
E non la dimensione della mia altezza.[5]

Ma è anche una signorina centrata, Alice. Il suo disorientamento pare conoscere bene la differenza tra la realtà e l’immaginazione qualche volta, sa quando accettare che un mazzo di carte può sì ridipingere delle rose e giocare a croquet, senza scordare del tutto che resta sempre un mazzo di carte quando si perde la pazienza. Il gioco è bello ma poi deve anche finire a un dato momento.
Alice non si può far altro che seguirla, non si può fissare mai perché è mutazione, movimento costante. Il disorientamento è chiave, bottiglietta, risveglio, unico modo per cadere come si deve. Dietro un coniglio che è una serendipità continua, si snoda il viaggio di un’eroina che esiste per noi come una carta, o come una bimba, o come una storia in cui ci piace cercarci.
Il buco di Alice non è mai dove pensi che sia. Un buco stabile, che sai già dov’è, è solo spettacolo, finzione teatrale o turistica. Le strategie di controllo ti propongono buchi stabili che sono li per portarti lontano. Ma la questione sta nell’avvenimento che ti passa vicino; non ti accorgi neanche che sta per succedere, poi succede, allora lo vivi o niente. Inutile stare a fare la critica dell’avvenimento; e non puoi neanche tenerlo come modello una volta che l’hai vissuto. Per questo il buco di Alice non è un modello, è soltanto un movimento di caduta. Alice che cade nel buco sognando: è proprio andare via da un’altra parte con la testa restando qui col corpo. Una fuga da fermi.[6]
Alors, qu’est-ce que t’as fait?
J’ai vieilli[7]
[1] Franz Kafka, Il processo, Mondadori, 1980.
[2] Lewis Carroll, Alice on the stage, The Theatre, Aprile 1887.
[3] Gianni Celati (a cura di), Alice Disambientata, L’erba voglio, 1978.
[4] Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Feltrinelli, 2005, testo originale a fronte, trad. it di Aldo Busi.
[5] Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine, Feltrinelli, 2001.
[6] Gianni Celati (a cura di), Alice Disambientata, edizioni L’erba voglio, 1978.
[7] Raymond Queneau, Zazie dans le métro, Gallimard, 1959.