di Davide Coltri

La porta a vetri si è aperta svelando una cinquantina di sedie grigie. C’era posto qui e là tra gli altri candidati, tutti attorno ai venticinque anni. Una ragazza coi capelli lunghi e castani mi ha fatto un mezzo sorriso e mi sono seduto vicino a lei.
«Anneke», ha detto stringendomi la mano.
«Per quale posizione?», ci siamo chiesti all’unisono.
Era la stessa. Abbiamo fatto un’espressione imbarazzata e siamo rimasti in silenzio, io intento a torturarmi le unghie, lei a sottolineare una dispensa.
Dopo un po’ un tizio con una cartelletta in mano ci ha invitato a scendere tutti al piano di sotto, uno stanzone immenso con delle divisorie in compensato.
«Vi raggrupperemo in coppie di candidati che competono per la stessa posizione. Dei valutatori registreranno le vostre reazioni agli scenari», ha annunciato.
Non ha risposto alle nostre domande di chiarimento.
Durante le otto ore successive siamo stati sottoposti a cinque simulazioni: un attacco terroristico, un tentativo di rapimento, la stesura di un progetto di assistenza alimentare, montare una tenda senza istruzioni, lanciare un appello alle parti belligeranti. Per ogni parola che dicevamo, per ogni gesto e reazione, c’era un omino in casacca gialla che prendeva appunti.
Anneke e io siamo stati alleati e antagonisti, sollecitati a dimostrare che uno era migliore dell’altra e che allo stesso tempo eravamo in grado di accantonare la rivalità per formare un duo efficiente e collaborativo. Lei ogni tanto sorrideva e si complimentava se avevo un’intuizione valida. Durante una pausa ci siamo scambiati i numeri di telefono. Quando sono tornato a casa, la sera, ho pensato che ci eravamo persino divertiti, nonostante le circostanze sfavorevoli.
Nei giorni successivi, agli amici che mi chiedevano come fosse andata rispondevo: «Bene, ma c’era questa ragazza olandese…»
Ci sentivamo quotidianamente, per informarci se l’una o l’altro avesse ricevuto la buona notizia. Una settimana dopo la selezione, quando una mail mi ha comunicato l’esito, ho pensato che doveva esserci un errore. Ho scritto un messaggio ad Anneke, poi l’ho cancellato, infine ho preso il telefono.
«Complimenti, te lo meritavi davvero», ha detto.
«Lo meritavi anche tu, più di me», ho risposto.
«Non arrenderti», ho concluso riattaccando.
Un mese dopo ero in Iraq: l’aereo è atterrato in una pista arsa dal sole e un autista gentile che non parlava inglese mi ha accompagnato al campo profughi in cui avrei trascorso buona parte dell’anno successivo.
*
Poco tempo dopo, uscendo da un aeroporto ancora più assolato, Anneke è stata investita da una raffica improvvisa di vento e sabbia. Mentre tentava di ripararsi dietro un pilastro di cemento, il foulard di seta che teneva in testa le è volato via ed è sparito tra i vortici di polvere che stavano in agguato al di là del recinto del parcheggio.
Ha aspettato quasi mezz’ora, poi un furgone con il simbolo della sua organizzazione è entrato nello spiazzo e si è fermato davanti a lei. La portiera si è aperta ed è salita. Dietro al volante c’era un uomo sulla quarantina, muscoloso, con un berretto nero in testa. Aveva un’espressione seria, tesa. Le ha mostrato il badge, come prescritto dal protocollo di sicurezza. Anneke ha trovato strano che venisse a prenderla il capo missione anziché un autista.
«Stava pranzando», ha detto lui.
«Molto gentile da parte sua».
«Dammi del tu».
«Andiamo in ufficio?»
«No, sei stanca per il viaggio. Inizierai domani».
«Grazie. Quanti siamo in casa?»
«L’alloggio dello staff è pieno. Starai da me per un po’».
Anneke ha percorso con gli occhi la linea dell’orizzonte: il cielo aveva un colore strano, sembrava pronto a squarciarsi.
«Non mi avevano detto niente di una seconda casa», ha buttato lì.
«È nuova», ha detto l’uomo, sterzando a sinistra.
Si sono fermati davanti a un cancello chiuso. Una guardia ha slacciato la catena, la macchina è entrata nel cortile e si è fermata. I due sono scesi. Una gettata di cemento si infilava tra le mura di quattro casette basse. Camminando nello spazio angusto tra le pareti, Anneke ha avuto l’impressione di inoltrarsi in un labirinto.
«Qui», ha detto l’uomo aprendo una porta di ferro.
La stanza non aveva altro arredamento che un lettino, due sedie e un armadio. In un angolo c’era la porticina del bagno.
«Le linee internazionali non funzionano, ma domani ti daremo un telefono locale», ha continuato lui, «nel frattempo se hai bisogno di qualcosa vieni da me», e per la prima volta ha sorriso. Gli mancava un incisivo.
«Vorrei riposare un po’», ha detto Anneke. Il bisogno di stare sola era più urgente del sonno.
«Prego», ha detto il capo missione, ed è uscito.
Anneke ha seguito il clac-clac dei passi che si allontanavano, poi si è spogliata e si è infilata sotto al lenzuolo infeltrito. Ha steso la coperta attorno a sé e ha appoggiato la testa sul cuscino. Da fuori proveniva il brusio ostinato di una radio e ogni tanto la risata sguaiata della guardia. Una luce strana, tra il giallo e il viola, filtrava nella stanza attraverso le imposte scassate dell’unica finestra. Ha chiuso gli occhi e si è addormentata.
Quando si è svegliata faceva quasi buio. Il capo missione era lì, seduto in fondo al letto, e le accarezzava le gambe.
*
«Anch’io ho fatto molta fatica, ma probabilmente è solo l’impatto iniziale», le ho scritto in chat, «non è facile restare positivi in mezzo a tanta miseria, in un posto di cui non capisci la lingua, lontani dagli amici e dalla famiglia».
Ho atteso una risposta, un commento.
Niente.
Sono andato avanti coi pensieri:
«E poi sento una voce maledetta che mi fa vergognare ogni volta che penso alle mie esigenze, a quello che farebbe bene a me, perché sono qui per aiutare gli altri».
«È vero», ha scritto lei.
«C’è qualcos’altro che non va?»
«Devo andare»
«Fatti sentire quando vuoi fare due chiacchiere».
Messaggio non letto.
*
Il capo missione le ha tolto la mano dalla bocca. Anneke ha sentito il sapore acre del suo sudore sulla punta della lingua. Il battito del cuore le esplodeva nelle tempie, ma il resto del corpo era completamente irrigidito.
«Alla guardia do cinque dollari ogni giorno», ha detto lui toccandole la guancia.
Anneke ha chiuso gli occhi, ha aspettato che le dita le scendessero lungo il collo. Invece la mano si è sollevata di colpo, con lo stesso scatto nervoso con cui poco prima aveva rinunciato a risalire oltre il ginocchio. Il movimento è stato tanto repentino che si è chiesta se la sua pelle, bagnata di sudore freddo, avesse emesso una scarica elettrica. Ha riaperto gli occhi, non aveva fiato per parlare.
Il capo missione era in piedi al suo fianco. Si era tolto il berretto: la testa pelata aveva una forma sproporzionata, a punta. Gli occhi erano sbarrati, grosse gocce gli pendevano dalla fronte.
«Non è successo niente», ha detto lui, senza cambiare espressione.
Anneke ha fatto cenno di sì con la testa.
L’uomo ha espirato sonoramente, è uscito sbattendo la porta e ha detto qualcosa di incomprensibile alla guardia.
Anneke si è alzata, è andata in bagno a lavarsi la faccia, ha vomitato. Un soffio gelido le è entrato nel corpo. È rimasta sveglia tutta la notte.
Il mattino seguente il capo missione le ha aperto la porta della macchina senza nemmeno guardarla in faccia, ha guidato in silenzio fino all’ufficio, ha radunato i colleghi e le colleghe e l’ha presentata a tutti. Qualcuno le ha rivolto un sorriso strano, come di disprezzo.
Le hanno consegnato un telefono. Si è chiusa in bagno, ha digitato un numero, ha premuto il tasto verde col simbolo della cornetta, poi la sua testa è stata allagata da uno scroscio inarrestabile di parole.
Una voce sottile ha insinuato che in fondo era anche colpa sua, perché aveva accettato di dormire a casa di lui. Un’altra voce, dura e implacabile, le ha comandato di guardare avanti, le ha ricordato le notti insonni sui libri del master, la frustrazione dei mesi in cui non trovava lavoro, la volontà, che risaliva almeno all’adolescenza, di mettere gli altri davanti a sé. Quando una terza voce più dolce e fragile l’ha ammonita che quanto aveva subito aveva il nome preciso di un crimine, le altre si sono unite in un grido sprezzante e hanno urlato che era lì per assistere donne e bambine che erano davvero state stuprate dai soldati governativi. Lei, invece, non era stata praticamente toccata. In fondo, insistevano, non le era successo niente.
Ha riattaccato alla fine del secondo squillo.
Nelle settimane successive, mentre distribuiva kit igienici in un villaggio pieno di sfollati, mentre raccoglieva informazioni sull’impatto dell’ultimo attacco aereo, l’urgenza di affrontare il fatto è scemata fino a trasformarsi in un fastidio dai contorni vaghi. L’unica eredità tangibile di quanto era successo sopravviveva nella necessità di dormire vestita.
Un muro impenetrabile si è alzato tra lei e il capo missione: si rivolgevano la parola solo se vi erano costretti per motivi di lavoro. Ogni mattina facevano il viaggio verso l’ufficio insieme, ogni sera rientravano con la stessa macchina, ormai assuefatti a un silenzio totale. Quando un collega che abitava nell’altra casa si è licenziato, Anneke non ha chiesto di cambiare alloggio: un rifiuto avrebbe dato nuovo spessore al fatto.
Poi, nel mezzo di un pomeriggio che non aveva niente di diverso dagli altri, lui è piombato nel bagno delle donne e l’ha assalita, premendole una mano sulla bocca e bisbigliandole in un orecchio di non fare resistenza. Per dei secondi interminabili l’ha palpeggiata con una foga che le avrebbe lasciato dei segni viola sul seno destro, poi Anneke si è divincolata, gli ha dato una gomitata nelle costole e ha urlato fuori tutto il gelo che le si era insinuato sotto la pelle. Mentre sbatteva la porta alle sue spalle e correva verso il centro dell’edificio gridando aiuto si è sorpresa a provare sollievo. Ha pensato che i colleghi avevano sentito le urla, lo avrebbero visto uscire dal bagno delle donne, avrebbero capito tutto. Sarebbe stato licenziato, la storia sarebbe finità lì.
Lei non avrebbe dovuto fare o dire nulla, non avrebbe dovuto dare un nome a quello che aveva vissuto.
*
«Nonostante la stanchezza sono contento: la settimana scorsa abbiamo inaugurato la prima scuola. Lì come va?»
È apparsa la scritta: ‘Anneke sta scrivendo’, poi è scomparsa, riapparsa, scomparsa di nuovo. Infine:
«Sono tornata a Rotterdam dai miei genitori».
«Sei stata male?»
«Sì».
«Una di quelle malattie tropicali che esistono solo in Africa?»
«No».
Una lunga pausa.
«E come passi le giornate?»
Messaggio non letto.
*
Non c’era nessuno: la grande stanza centrale del primo piano, sempre affollata di gente che prendeva acqua dalla tanica o faceva fotocopie, era deserta. Anneke si è tirata indietro i capelli, si è ricomposta, è corsa al piano di sopra. Il corridoio era vuoto ma si sentiva il brusio dei colleghi nascosti negli uffici. Ha sbirciato oltre una porta semiaperta, ha incrociato lo sguardo di una donna di cui non ricordava il nome. Quella si è messa a ridere e ha fatto un cenno a qualcuno. La testa riccia di un ragazzo giovane è spuntata nella fessura tra lo stipite e la porta, ha guardato Anneke divertita ed è scomparsa di nuovo. Anneke ha sentito dei passi avvicinarsi dietro di lei.
«Tutto sotto controllo», le ha detto la voce di lui in un orecchio.
È rimasta immobile, i passi sono scesi giù per le scale. L’odore stantio del fiato di lui è rimasto nell’aria.
È tornata a casa, camminando più veloce che poteva sotto un sole spietato. Ci ha impiegato due ore. Si è messa a letto, ha pianto a lungo. È rimasta a guardare il soffitto, a sperare che quella tensione insostenibile finisse, almeno per quel giorno. Si è persino augurata che lui venisse a farle visita, si è illusa che potessero ancora parlarne. Si è addormentata che era quasi l’alba.
Sì è svegliata alle sette in punto, ma non si è alzata. Verso le otto e mezza qualcuno ha bussato alla finestra. Era un autista.
«Oggi ti porto io, il capo è andato via».
«Via?»
«Ha preso l’aereo ieri sera».
«Licenziato?»
L’autista ha riso: «No, vacanza con la famiglia».
«Vacanza», ha fatto eco Anneke con voce afona.
L’autista ha riso di nuovo e ha ammiccato: «Va sempre, ogni tre mesi. Ti dispiace?»
Anneke non ha risposto. Si è chiesta se fosse possibile che quella storia finisse così, senza scandali, con il molestatore che se ne andava al mare con moglie e figli, lasciandola libera di fuggire. Si è chiesta se fosse solamente un brutto sogno, poi ha sentito un fitta di dolore tra i seni, dove la cintura faceva pressione.
«Portami a casa», ha detto all’autista.
«Niente ufficio?»
«No».
Mentre faceva le valigie una voce debolissima l’ha rassicurata che avrebbe ricominciato a vivere, a essere di nuovo se stessa.
«L’elenco dei nuovi assunti non lo guardo mai: rischiavamo di non incontrarci per mesi», ho detto.
Non era cambiata di molto dall’unica volta in cui ci eravamo visti, tre anni prima. Solo gli occhi, dietro la stessa luce gentile e decisa di allora, rivelavano un’ombra di rassegnazione, come se avessero capitolato davanti a una stanchezza che sapevano essere incurabile. Siamo usciti, siamo entrati in un bar e ci siamo seduti a un tavolino, davanti a due tazze di tè.
Ha voluto che le raccontassi dei posti in cui avevo lavorato, dei progetti che avevo portato avanti. Parlavo velocemente perché avevo fretta di sapere: il suo profilo facebook era fermo al giorno in cui annunciava la partenza per la prima missione, e ai miei saluti in chat non aveva più risposto.
«E tu dove sei stata?», ho chiesto.
«Da nessuna parte», ha risposto bevendo un sorso di tè.
«Sei rimasta sempre a Rotterdam?»
«Per due anni non ho fatto niente», ha detto guardando la gente che passava veloce sul marciapiede oltre la vetrata.
Ha posato la tazza e la manica della maglia si è ritratta un po’, svelando una cicatrice profonda sul polso. Ho trattenuto il fiato e l’ho fissata negli occhi. Per qualche secondo mi ha lasciato a lottare con la tentazione di guardare di nuovo, guardare meglio.
«Ci sono tante cose che ti devo dire», ha detto toccandosi la cicatrice con un dito.


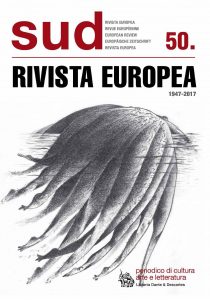
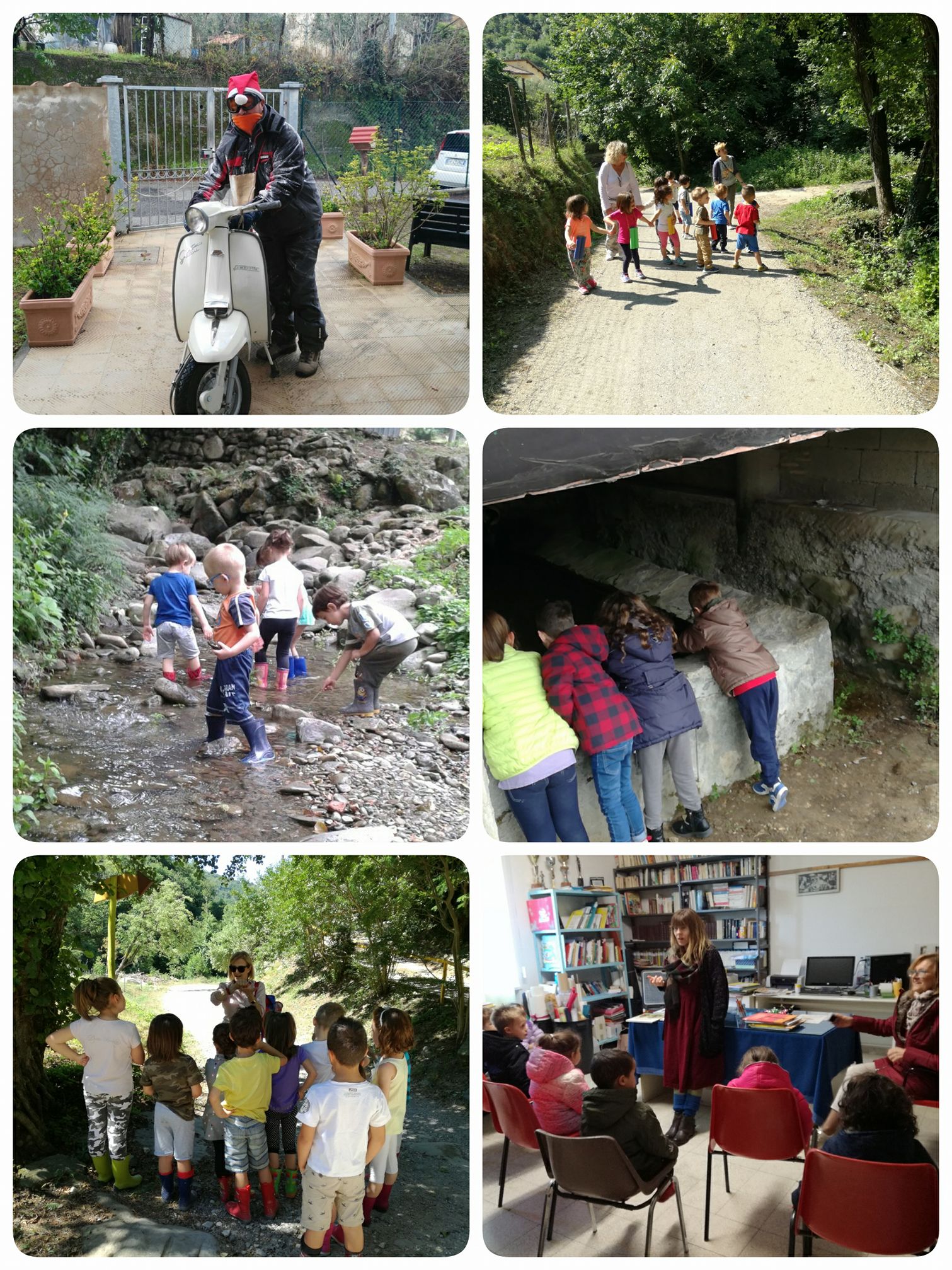


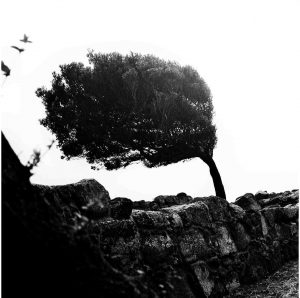
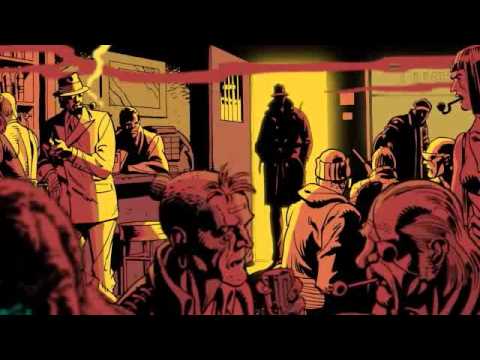


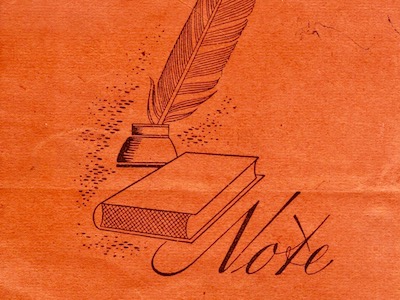
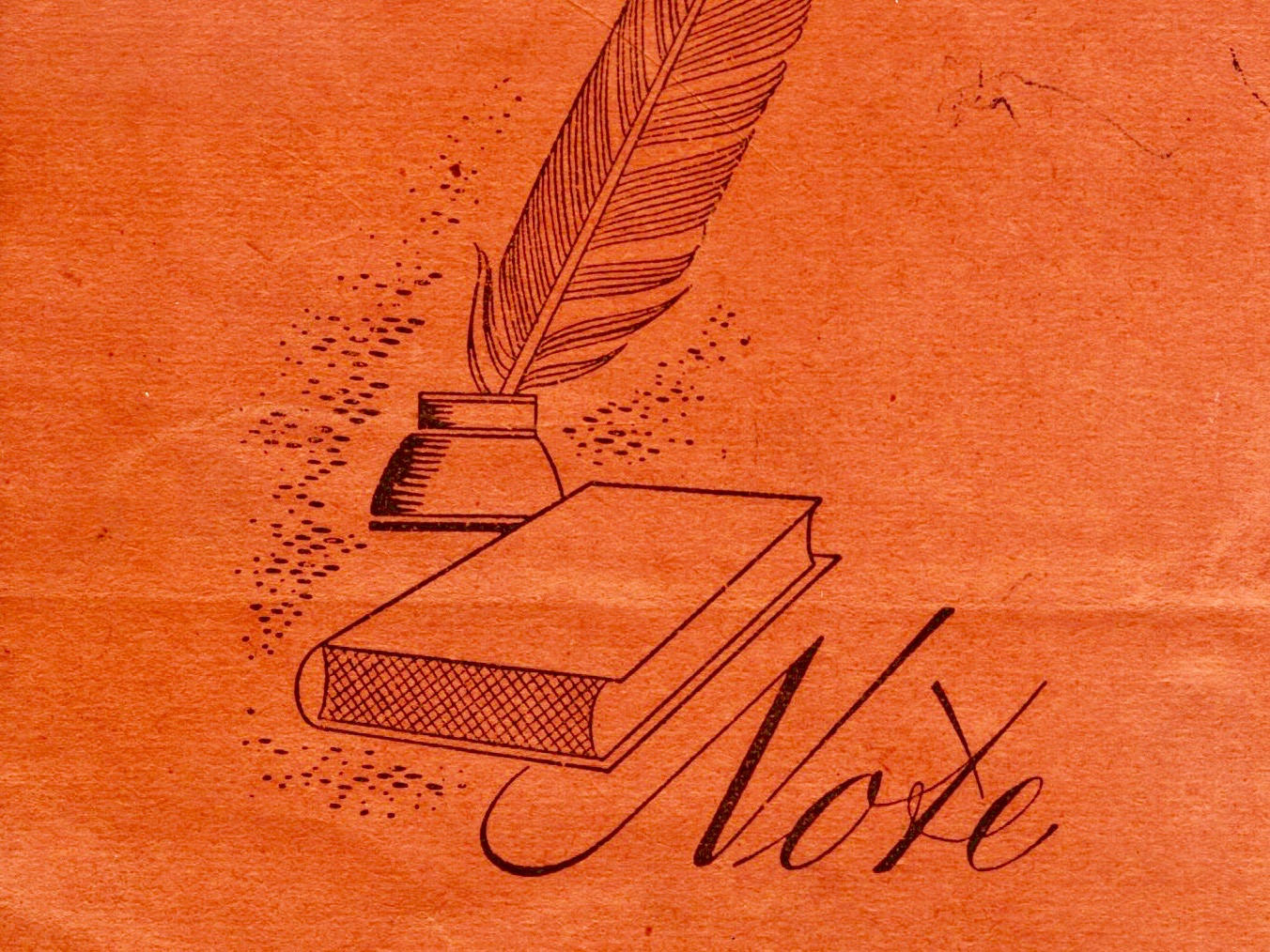
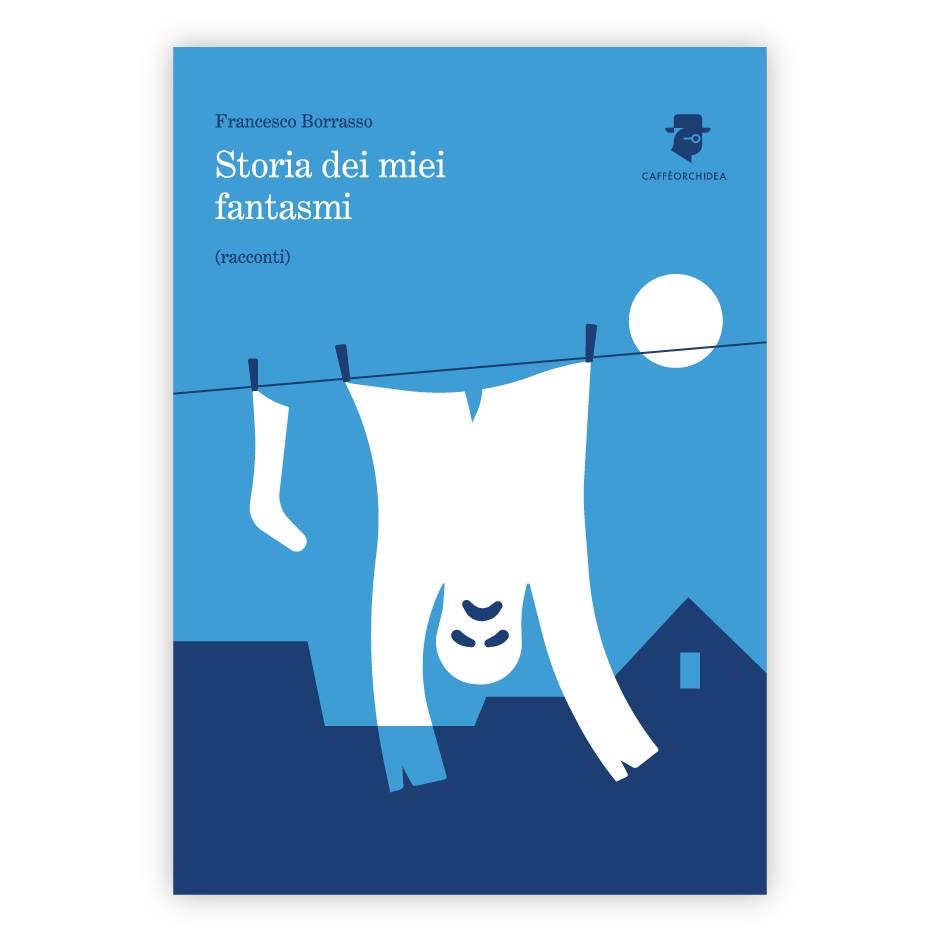
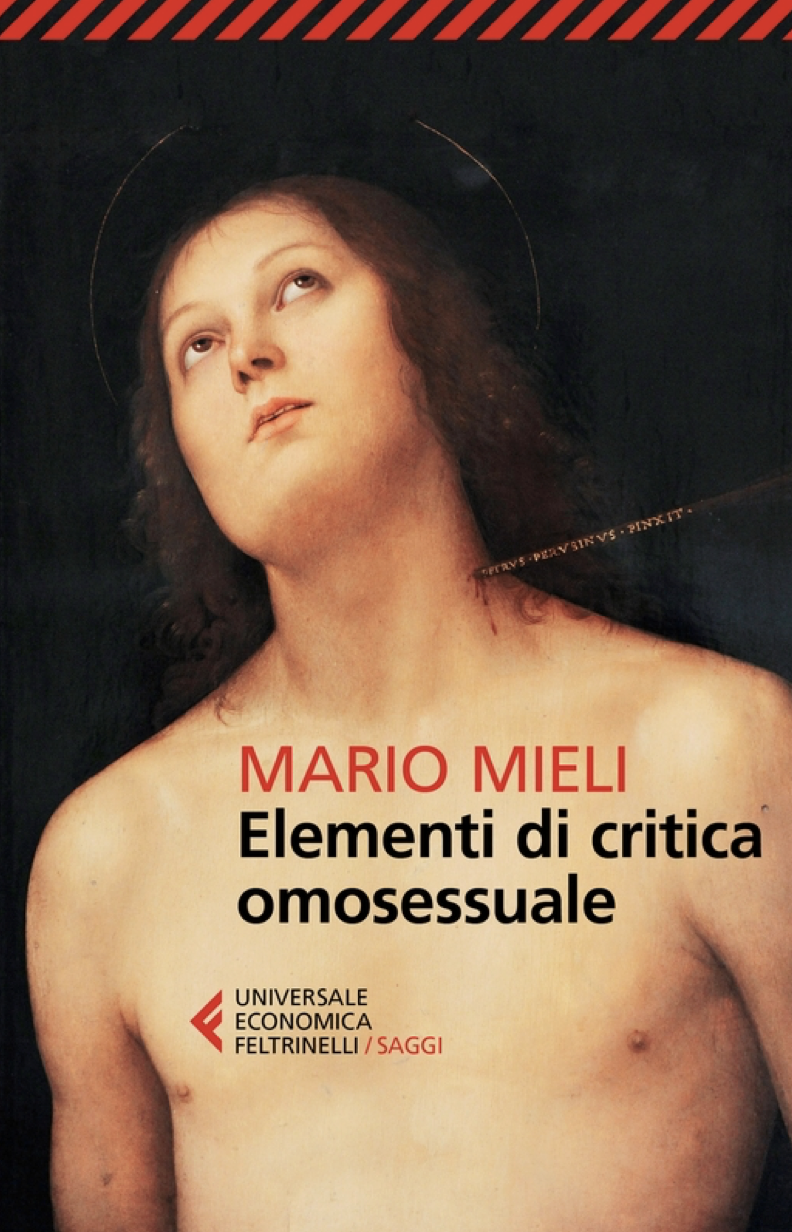

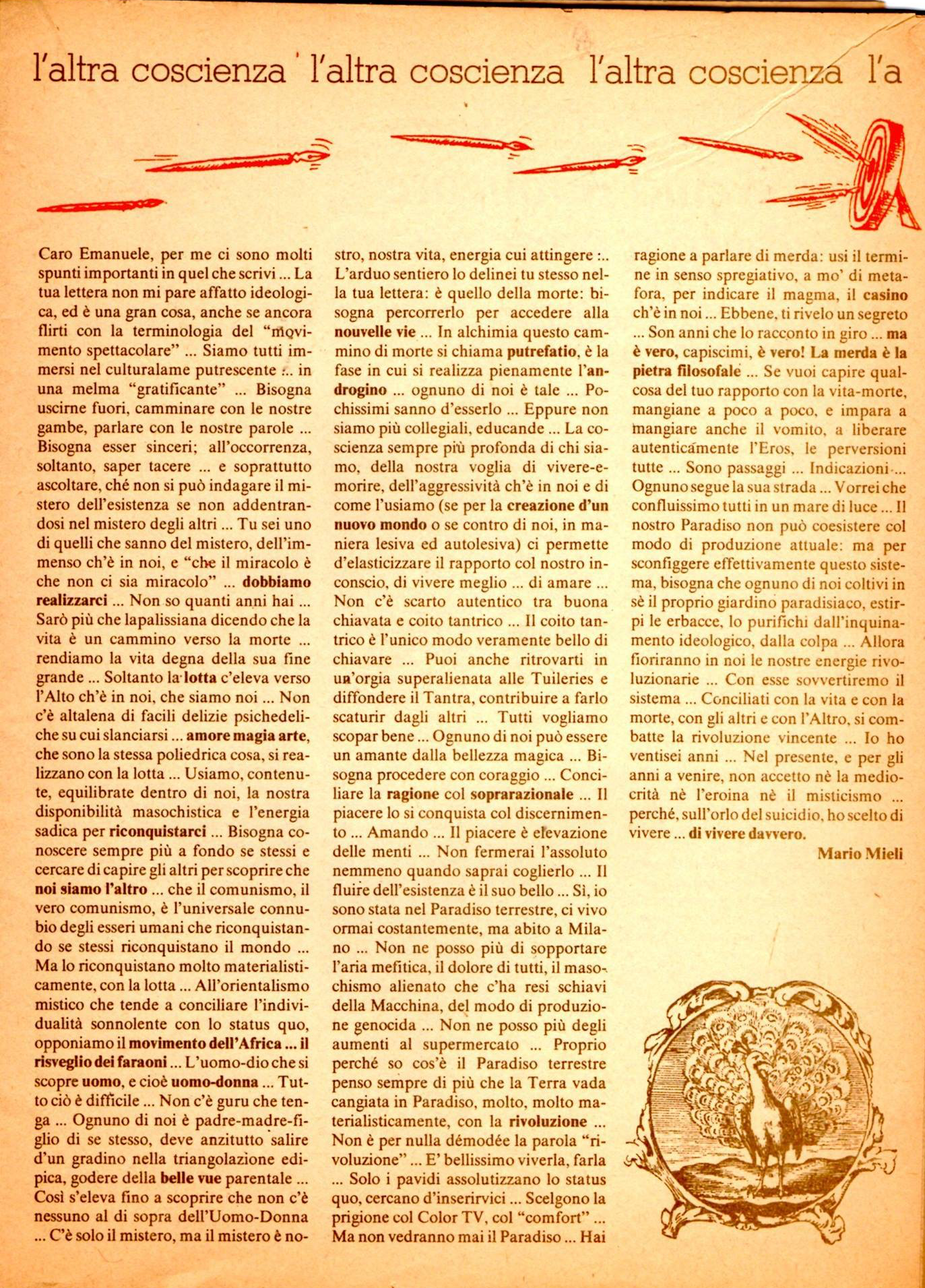
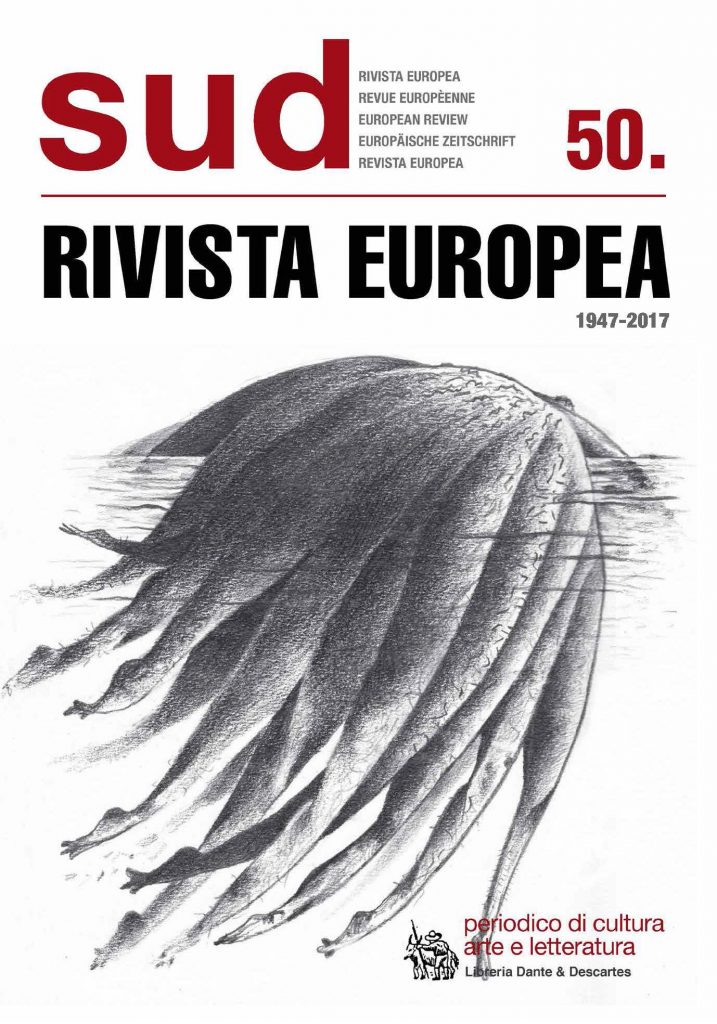 Europeana Remixed
Europeana Remixed 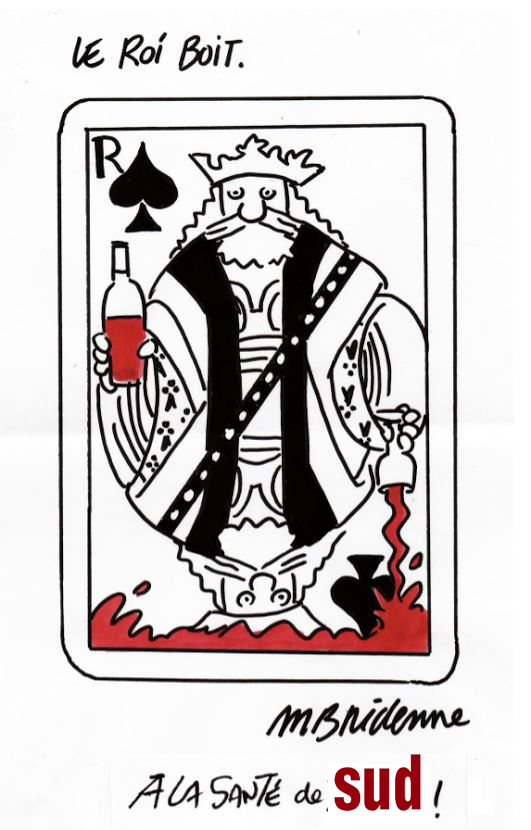
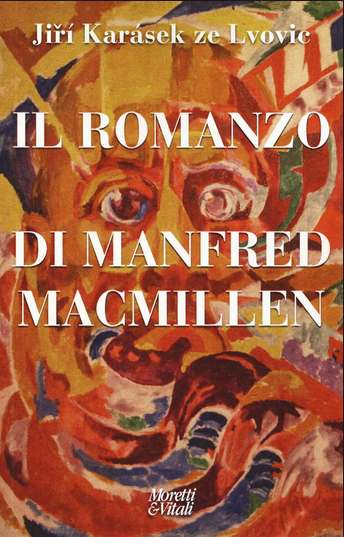
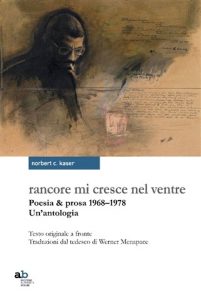
 di Claudia Crocco
di Claudia Crocco