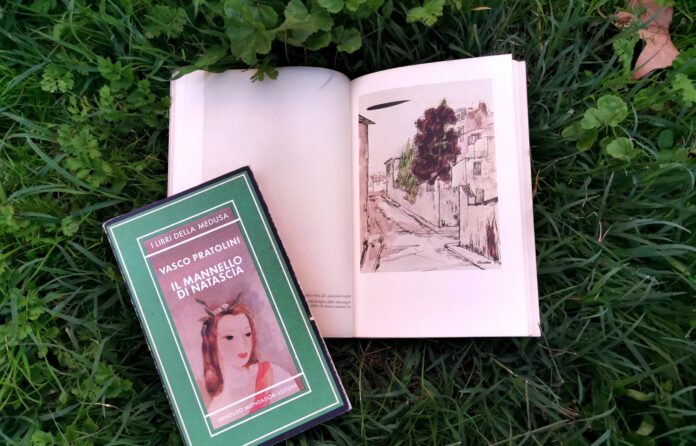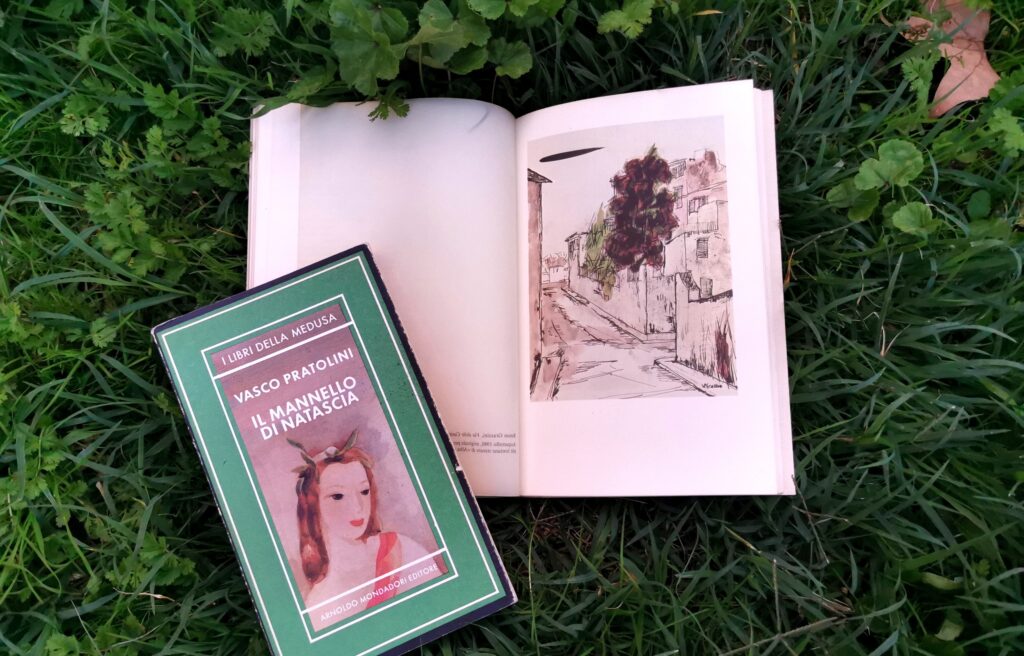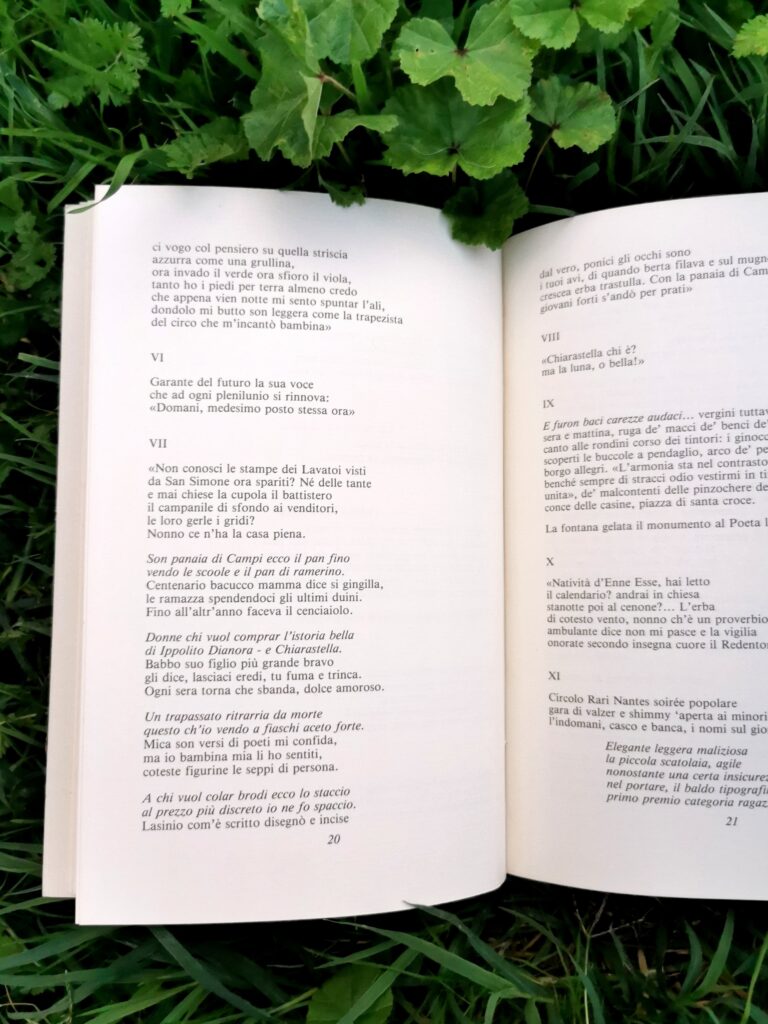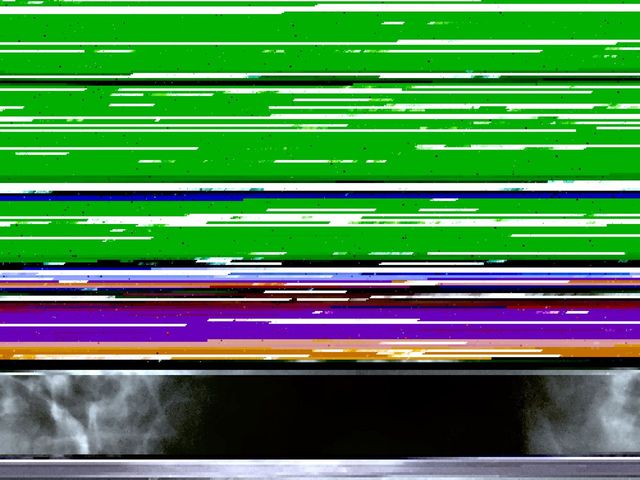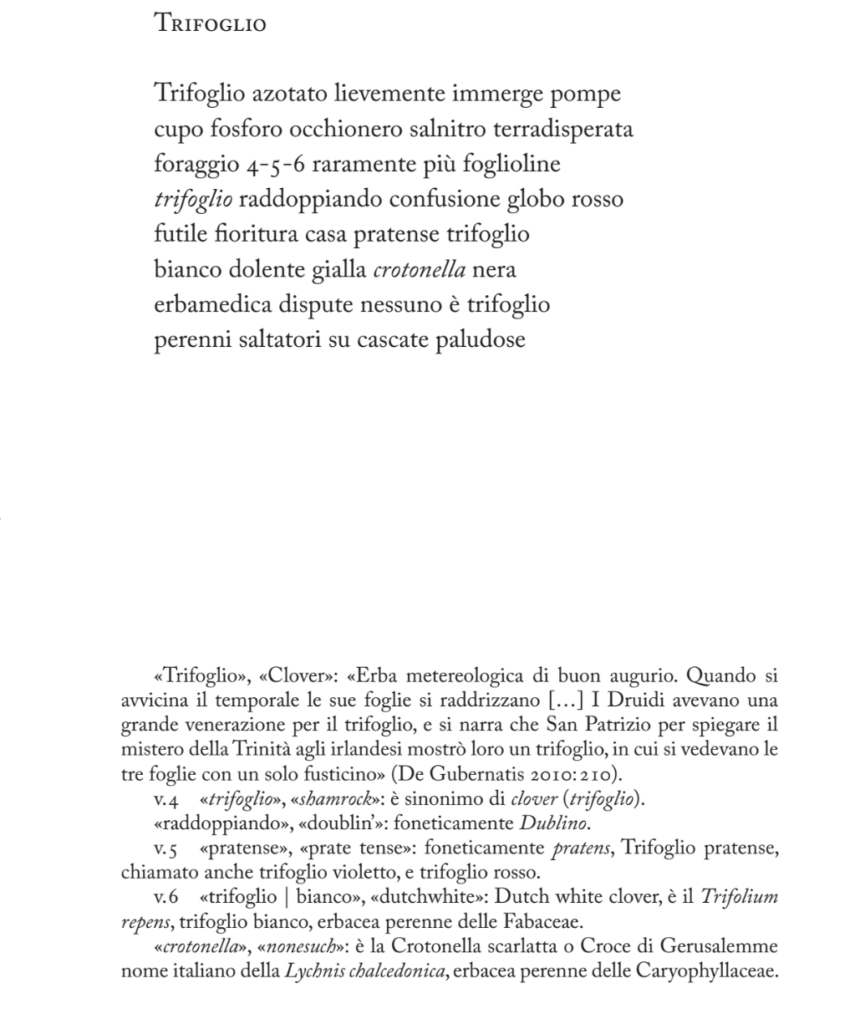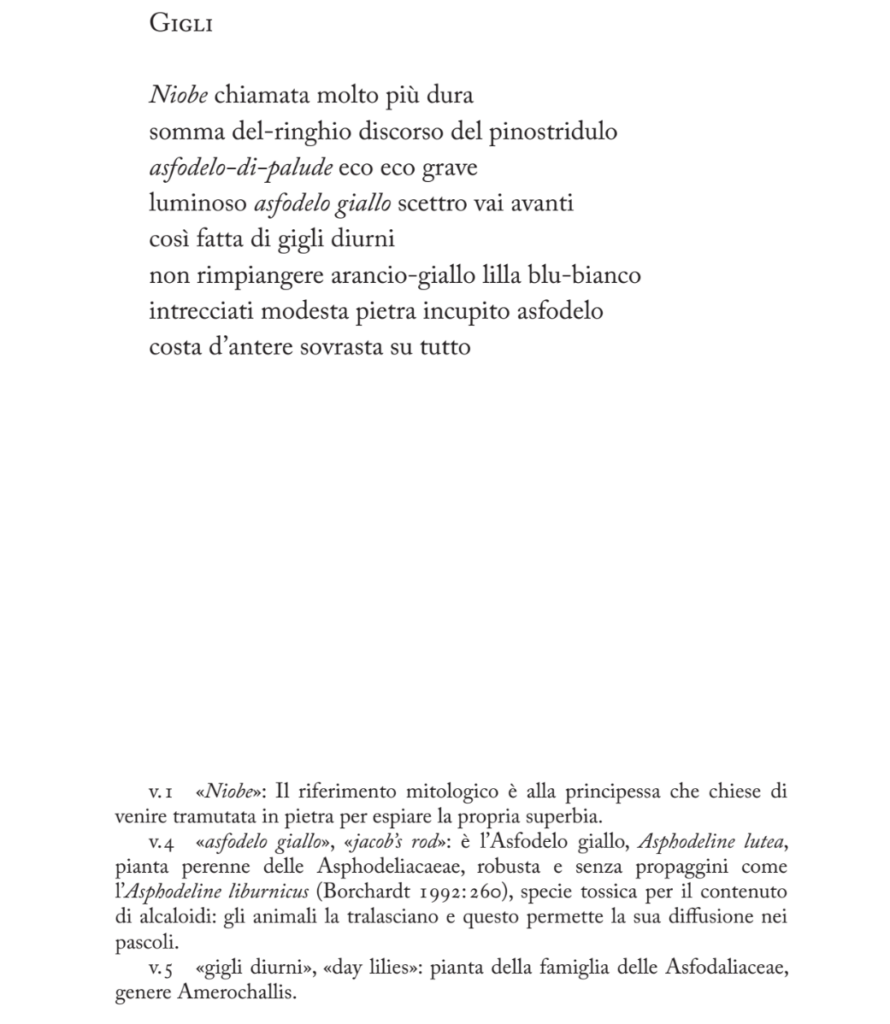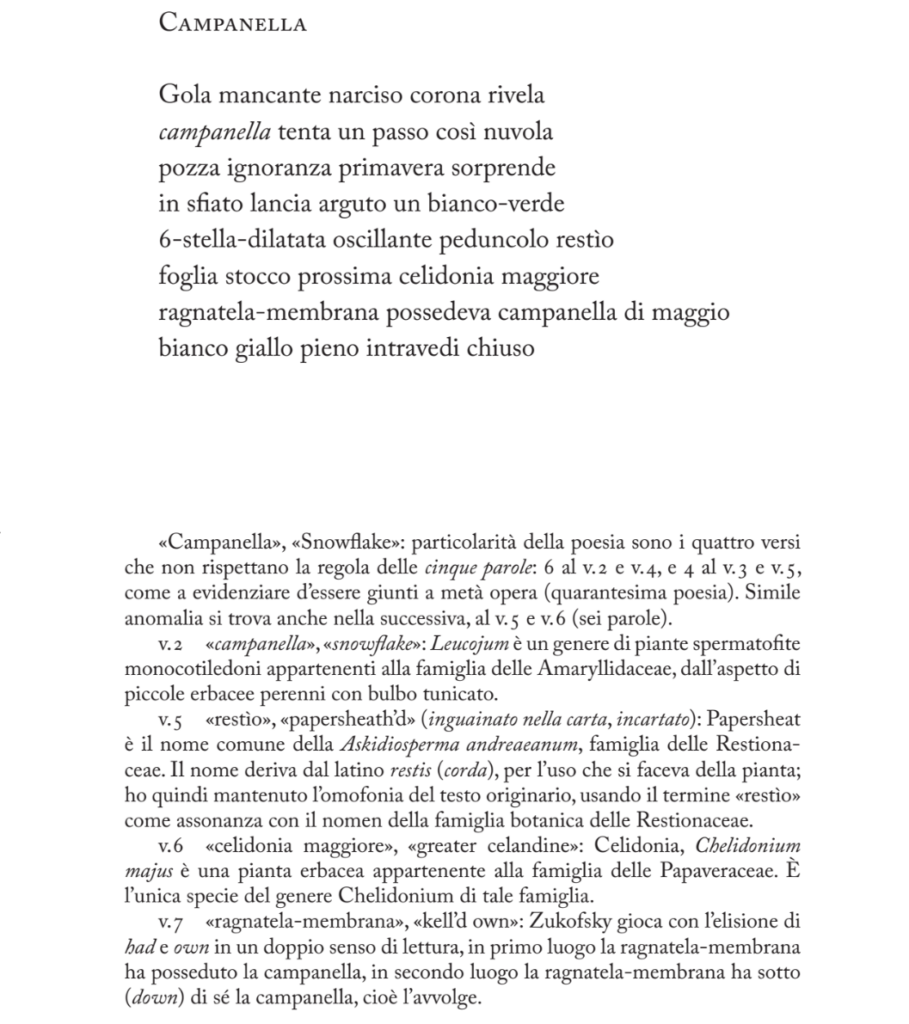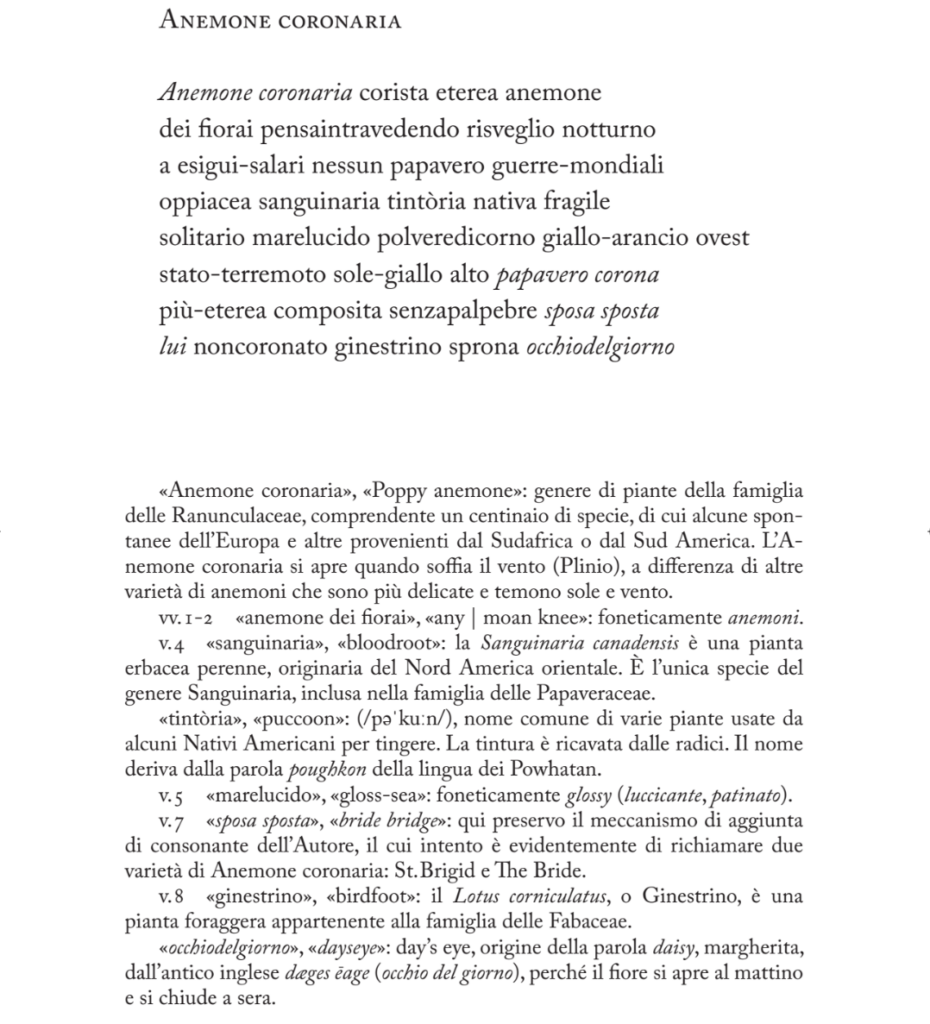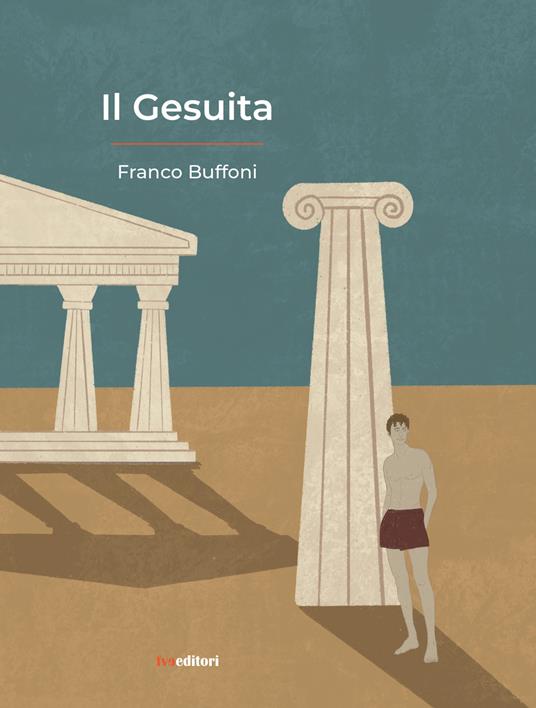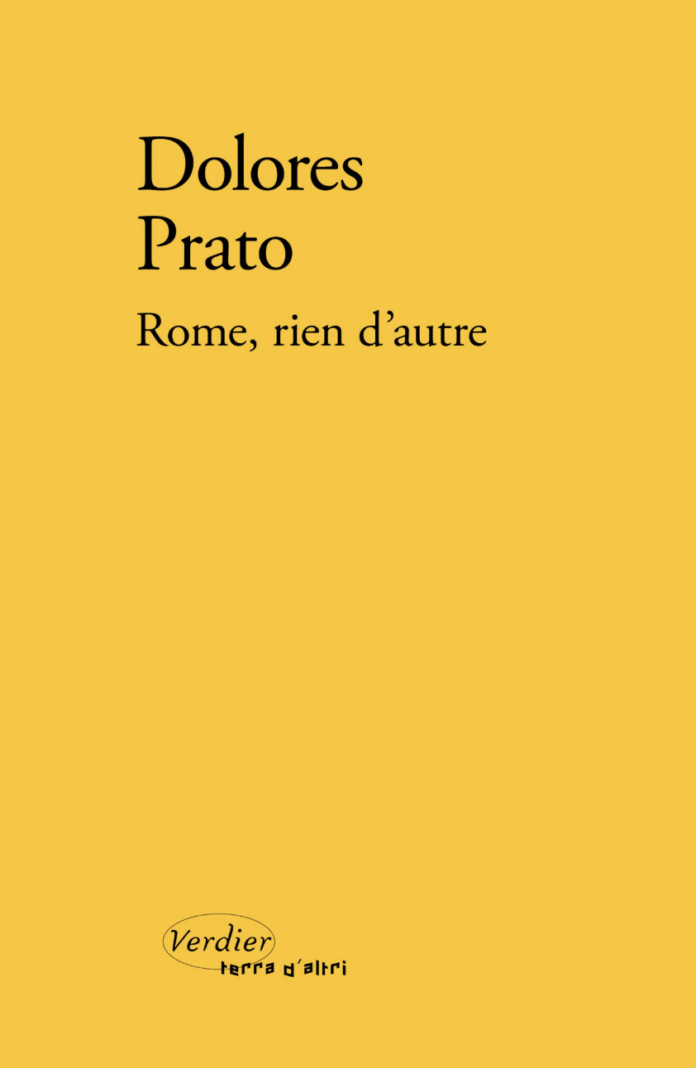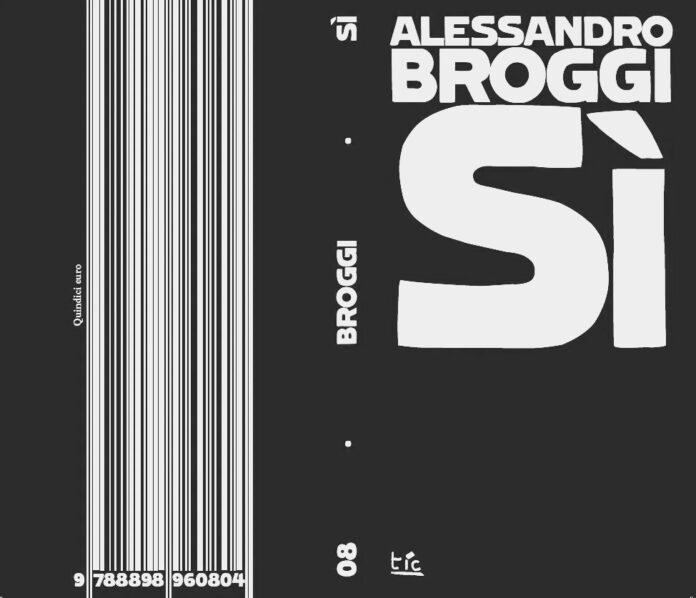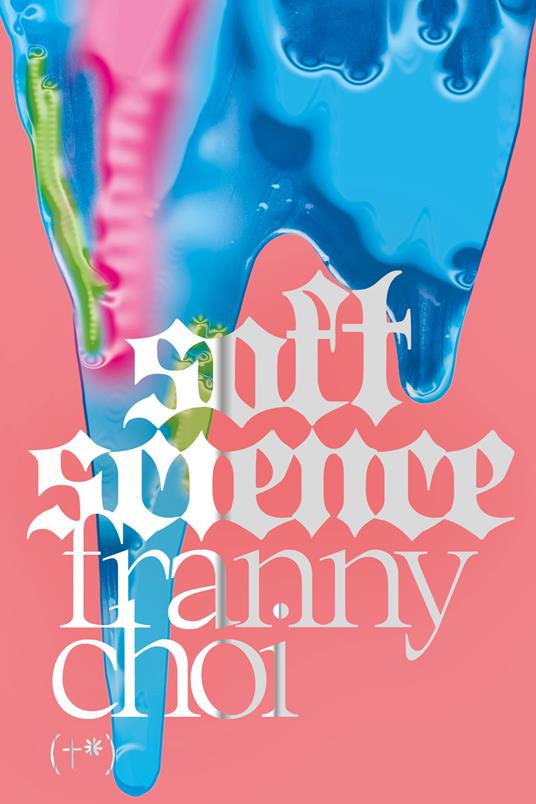di Daniele Ventre
Il Gesuita, romanzo di Franco Buffoni uscito nel 2023 nella collana Gli Oltre di FVE editori, si articola in quattro tempi narrativi. L’esordio in medias res, nel mezzo del cammino dell’adolescenza del protagonista Franco, si colloca storicamente nel 1964 a Gallarate: l’indicazione cronologica incipitaria è volutamente nello stile del romanzo tradizionale. Tradizionale è anche l’io narrante e la focalizzazione interna fissa, che però comporta in qualche modo che il narratore intradiegetico si ponga come protagonista agito dalle circostanze, punto di vista che squaderna esperienze, in un flusso di accadimenti ridotti a stream of consciousness.
In prima battuta, per il protagonista de Il Gesuita, in realtà le categorie lacaniane da richiamare sono due: dell’una, l’essere agito, abbiamo già detto, e vi si potrebbe aggiungere il corollario heideggeriano della gettatezza; l’altra, la forclusione (non nel linguaggio del romanzo, ma di fatto nella psiche del narratore interno), legata alla presenza esterna, ipercontrollatrice, di un padre mai nominato (è semplicemente “il padre”) che da ufficiale di fanteria è “abituato a dare ordini”.
Nelle prime pagine sembra agire sotto traccia la dittologia virilismo dispotico e allusione all’elemento “guerresco”: nel primo capitolo l’io narrante, che “stava con la Michela”, ha la sua prima esperienza omosessuale durante la proiezione di un film di guerra al Cinema Impero di Gallarate, il cui nome e la cui aura architettonica, entrambi echi del ventennio, come riecheggiamenti dei Cinema Impero di Asmara e di Roma, creano una struttura reticolare implicita di richiami storici che alludono al substrato ademocratico e ideologicamente tossico alle radici di una parte consistente dell’Italia contemporanea. In un simile contesto, il protagonista si viene strutturando, nei capitoli 1-6, in una sorta di dualismo fra il suo orientamento sessuale, scoperto in modo improvviso e semi-traumatico, e la proiezione sociale del suo rapporto con la propria identità. Il suo primo impatto con sé stesso è rappresentato nel flusso di coscienza-discorso indiretto libero del capitolo d’esordio; nell’erlebte Rede viene però incapsulato, spontaneamente, anche il dialogo monosyllabos con il partner occasionale (“Apri bene… Apri bene…”, “No/ Dai, stai buono”), con abolizione parziale della punteggiatura, fornendo all’intera scena, greve di mera fisicità, la connotazione di un fenomeno puramente intrapsichico. L’effetto contrastivo fra l’esperienza omosessuale e il biglietto en français della Michela (“Quand tu serais à la mer avec une belle suédoise, te souviéndras-tu de moi?”) condensa infine l’intero sistema delle circostanze esistenziali in cui l’io narrante è per il momento gettato: 1) la sua omosessualità, per ora socialmente latente; 2) l’attesa sociale verso un’eterosessualità seduttiva di conquête; 3) l’obbiettivo di questa eterosessualità seduttiva, la bella svedese, ovvio bersaglio del latin lover soggetto di due ben note narrazioni cinematografiche che, guarda caso, si collocano nell’orbita temporale dell’epoca di inizio del romanzo. Al 1963 data infatti I mostri di Dino Risi, in cui l’episodio Latin lovers-amanti latini, vede protagonisti due personaggi interpretati da Tognazzi e Gassman che su una spiaggia tentano di sedurre la stessa bella bagnante, la quale si dilegua, così che i due uomini si ritrovano mano nella mano. Del 1965 è la parodia di cassetta di Franchi e Ingrassia, in cui l’ambiguità del mito machista italiota si manifesta nel suo aspetto comico, mentito e atteggiato. In questo rimpallo di ipogrammi della cultura popolare e del cinema, attraverso un gioco di allusioni, nel capitolo de La Michela, si delineano, a cerchi concentrici, l’ambiente storico e antropologico, il sistema di attese che circondano il giovane uomo in fase di maturazione, la dinamica discriminatoria del virilismo, e al centro il personaggio stesso, con i suoi gusci proiettivi e il suo friabile mimetismo. Sul piano narratologico, assistamo a una peculiare modalità di narrazione segmentata; il sistema di attese (della Michela, implicitamente del padre) che circondano l’io narrante, la struttura reale del suo desiderio, gli ipogrammi del cinema anni ’60, costruiscono una parvenza dissociata, dietro il cui manifestarsi esteriore si cela una identità non ancora pienamente centrata.
Il mancato centramento è anzitutto relazionale: in primo luogo nel vagheggiamento per l’Alberto (cap. 2), con la sua fisicità da atleta, vagheggiamento che rimane inappagato, e si concreta in una gestualità furtiva, slittata feticisticamente su una lettera che il giovane scrive al protagonista, sulla scrittura (“scrivo una poesia pensando all’Alberto”), sul “telefono a muro” (cap. 3) tramite cui i due ragazzi comunicano. È nell’episodio del telefono a muro che interviene, come mera fonte di divieto generalizzato, il padre, che viene subito liquidato (“a Chianciano due settimane a curarsi il fegato”) ed è oggetto di odio per i suoi immotivati editti di interdetto. L’Alberto si caratterizza come l’opposto del protagonista Franco: vive fuori della storia, lo hanno “cannato a scuola”, ignora che nel vicinato vive il poeta David Maria Turoldo, o che nel mondo gli equilibri geopolitici sono stati alterati dalla caduta di Krushëv. L’alberto (“con la a minuscola”, come si auto-definisce in una lettera al protagonista), rappresenta quasi l’intemporalità del desiderio come tale: infine si rivelerà come colui che “non ha capito nulla”. Non corrisponde al desiderio, e ha tutti i connotati prevedibili del “povero ma bello” di risiana memoria. Nello slittamento progressivo del desiderio, l’Alberto si annoda, lungo il primo dipanarsi della trama, con altre tre presenze: la Patrizia, di cui il protagonista, che ha deciso di conformarsi esteriormente all’attesa sociale dell’eterosessualità, dice apertamente: “non so se la amo: io la devo amare”; il compagno di classe, Roberto, per cui il protagonista Franco rappresenta, senza saperlo, ciò che per Franco stesso rappresenta l’Alberto; la fugace ricomparsa dell’uomo della prima esperienza, stavolta cercato, non sensa che il protagonista si autoflagelli (“sei un invertito, un finocchio…”). È quasi il caso di saphēnízein Buffoni ek Buffoni sottolineando, per quanto sia banale, che al momento iniziale de Il Gesuita l’io narrante, sedicenne, ancora in costruzione esistenziale, è lo stesso io poetante-narrativo, la stessa persona loquens di alcuni versi di Jucci: “In una poesia dei sedicianni/ scrivendo come se io e il mio ipotetico lettore/ fossimo etero, sillabavo:/“Dietro un muretto, due invertiti smaniano”./ poi – e già ti conoscevo – da proustiano/ divenni gidiano…” e il richiamo è tanto più diretto, quando si pensi, in quanto la presenza dei “due invertiti” è evocata dalla stessa Patrizia, come puntualizzazione dell’ordine pubblico omofobico. Nel racconto di Patrizia, i due uomini nudi in macchina, sorpresi dai carabinieri, sono collocati, quasi in allegoria, nel luogo “dove capita che i ladri abbandonino le auto rubate” e viene spontaneo cogliere qui un’ulteriore allusione alla quasi coeva, o di poco successiva, aneddotica pasoliniana e penniana in cui pederasta e ladro/bandito sono in qualche modo associati, nell’immaginario dei pregiudizi omofobici radicati nell’Italia del boom economico, dalla loro dimensione furtiva e marginale. In questo succedersi di vicende interiori ed esteriori, procedono le prime sei lasse di prosa del romanzo, saldate da una sorta di struttura ad anello con movimento processuale, secondo uno schema facilmente sintetizzabile nelle grandi linee: a) Michela “donna dello schermo” + prima traumatica esperienza omoerotica con uno sconosciuto; b) passione non corrisposta di Franco per l’Alberto; c) presenza interdittiva del padre; b1) passione non corrisposta di Roberto per Franco + seconda, stavolta cercata, ma ammantata di sensi di colpa-autodenigrazione, esperienza omoerotica del protagonista con lo stesso sconosciuto; a1) Patrizia “donna dello schermo”. Questa cellula narrativa tradizionale, già attiva negli incunaboli del romanzo occidentale, dal Satyricon al Lazarillo de Tormes, rivela il fatto che Il Gesuita, più che un banale Bildungsroman a tema, è una sorta di versione sublimata del romanzo picaresco; o meglio, se di Bildung si deve parlare, va intesa nel senso primitivo di “costruzione/assemblaggio” progressivo sul piano narratologico, e sul piano ontologico, più che nel senso banale, catacrestico, di “formare/educare”, che ha nel sassone moderno il verbo bilden.
Che sia in qualche modo questa la chiave di lettura, lo si intuisce nel capitoletto intitolato a Guido Guinizelli. Lo scarto narrativo, rispetto alle prime sei lasse, è riassorbito dalla struttura a schidionata dei capitoletti, l’unico trait d’union essendo sempre il centro coscienziale del flusso ideativo del protagonista. La virata logica verso la cripto-gnosi dello stilnovo, la cui comprensione critica è organata sul precisare “la differenza tra concezione ontologica e concezione gnoseologica dell’amore” e sulla struttura delle “immagini naturali (sole fuoco selva luce pietra stella calamita)”, fa emergere per mera contiguità associativa il processo per cui Franco cerca di inscrivere l’aspetto sublimato, ingenuo, del suo amore per l’Alberto, nelle categorie che il primo contatto con la letteratura gli fornisce. Tale sublimazione, nella letteratura medievale, è per alcuni ancora una volta espressione del corpo forcluso; in realtà qui il protagonista ne coglie lo spirito autentico, come autofondazione esistenziale attraverso la relazione d’amore. L’inserzione ex abrupto di visioni metafisiche, evocate tramite gli snodi narrativi di un’estemporaneità quotidiana (lettura occasionale, lettura di scuola), si ritrova anche in altri narratori europei contemporanei: si può citare a titolo di esempio l’Arno Schmidt di Dalla vita di un fauno. Qui tuttavia l’inserzione della metafisica dell’amore degli stilnovisti assume una maschera di ironia affettuosa, specie se si riflette sulla natura di flashback autobiografico finzionale che la narrazione assume. Segue in effetti al capitolo Guinizelli l’invio delle poesie d’amore di Franco all’Alberto con tutte le ‘o’ al loro posto, in una lassa narrativa in cui lo stato sentimentale del protagonista rasenta i canoni dell’amor de lonh (“Il Roberto, la Patrizia, è bello stare con loro perché esiste l’Alberto, è lontano, ma c’è”; lo strano entimema “Alberto esiste perché è lontano”). Immediatamente dopo, però, la Patrizia dilegua dall’orizzonte ottico con il tradimento: la sua breve lettera d’addio è un passo di scrittura tematica, che prelude alla conclusione della prima parte del romanzo, come avremo modo di chiarire fra poco. In sfrigolio contrastivo con la desolazione lasciata da Patrizia, oggetto del disprezzo di Franco, il ritorno di Alberto (con la sua “sana” ignoranza politica, che lo tiene lontano dalle inquietudini dell’epoca, condensate in scritte murali come “La Cina è vicina/ è già in Albania”) si traduce in un momento di gioia suprema. Il capitolo 9, Vacanze di carnevale, in cui questi due momenti si concentrano, segna l’inizio di una nuova linea narrativa marcata dall’usuale circolarità progressuale. Tale linea narrativa conduce: 1) allo sgretolamento del microcosmo relazionale di Franco, per come si delineava nei capitoli 1-6; 2) all’emergere dell’odio nei confronti della figura ipercontrollatrice del padre; 3) all’apparire di Klaus, il gesuita, 4) alla dissoluzione dell’immagine dell’Alberto come oggetto d’amore (l’Alberto è infine nel novero dei “nemici”). Questa nuova, più articolata, cellula narrativa, segue lo snodo metafisico del capitolo 7, e si dipana dal cap. 8 al capitolo 30. La comparsa di Klaus che scrive al protagonista, trasforma le pulsioni del personaggio narrante, attuando quella sublimazione che era cominciata idealmente nella digressione su Guinizelli. Klaus è in teoria in corrispondenza ideale: apprezza le poesie, e in genere le passioni artistiche, del personaggio narrante, ma nella sua lettera, sin da subito, questo apprezzamento si manifesta con un verbo che ha connotati fortemente fisici: “palpare”, che nel contesto in cui è usato viola una serie di blande restrizioni semantico-sintattiche. La “vita con Klaus” procede in questa dimensione ambigua, in cui il gesuitam scrivendo al protagonsita, usa la parola “spirito” virgolettata; nel frattempo si viene profilando l’estinzione della pulsione a cercare esperienze in contesti di marginalità (il cinema, il cimitero) e della violenza implicita in tali esperienze (che alla violenza si riducono: “un vecchio che salta fuori all’improvviso, spingendomi alla fuga”; “un altro giovane che … mi dà un pugno sul naso… e mi porta via i soldi e l’orologio”). Questo breve passaggio conclusivo, richiama in negativo le esperienze omoerotiche occasionali ad apertura e chiusura dei sei capitoli iniziali; soprattutto smentisce in rebus l’associazione spontanea fra omosessualità e mondo marginale/criminale, che è immediata nell’immaginario in bianco e nero degli anni in cui la narrazione muove i primi passi. In questo processo, il gesuita viene rivestendo un semi-volontario ruolo di maestro/costruttore; gli appartiene una visione esterna obbiettiva delle cose (coglie per es. la potenziale relazione di Roberto, immaginando sia quest’ultimo, e non Alberto, il destinatario), gli regala, per il compleanno (nuovo momento cronologicamente scadito: 3 marzo 1965) le poesie del poeta gesuita G. M. Hopkins, antifrastiche rispetto al dono di Roberto, le poesie di Lorca; si intuisce che i personaggi sono di fatto associati all’identità del loro ideale alter ego poetico, proiettato verso l’altro come dono del proprio intimo processo identificativo sul piano culturale. In questo sistema, quasi una sorta di conflation ring, i messaggi inviati tramite il dono soffrono di eterogenesi dei fini: il gesuita offre una sorta di insegnamento; la risposta di Franco, con la sua traduzione “calcistico-dissacratoria” semi-consciamente orientata, per transfert, al mondo agonistico dell’Alberto, suscita l’ilarità di Klaus (cap. 13: Che terribile che sei); per ovvie ragioni Roberto regala Lorca, con tutto il complesso di implicazioni che ne deriva, considerando ciò che per Roberto il protagonista rappresenta; prima di questi doni di compleanno, però, un libro di poesie era stato già regalato, quello di Franco, all’alberto (con a decisamente minuscola), ed è quest’ultimo a essere estraneo al gioco. Non è casuale se poco dopo il narratore interno, incontrando un compagno delle medie di Alberto, che lo conosce nella dimensione quotidiana e abitudinaria, prenda atto della sua realtà ordinaria e constati con disappunto: “Lui così non esiste”. Intrecciata con la figura del gesuita, la figura dell’Alberto viene così erodendosi progressivamente. Mentre l’evoluzione dei personaggi procede, si manifesta ancora una volta, come presenza turbativa e fonte di divieti unilaterali, la figura del padre (cap. 15-16): ancora una volta il padre interviene, convocando il figlio e dando ordini (“Mi dice che quel gesuita non lo devo più frequentare”), per poi agire dietro le quinte, da “onnipotente”, facendo trasferire Klaus a Roma; la presenza del padre (“la macchina di tuo padre”) impedisce anche a Roberto di avvicinarsi; la lettera di addio di Klaus, trasferito d’autorità, è poi causa dello sfogo (scritto) del protagonista; sfogo che produce l’effetto dell’ “odio” verso il padre simbolo della “virilità anni Sessanta” evocata nei capp. 1.6. Di questo odio del figlio il padre stesso prende coscienza, uscendone distrutto (19-21), per effetto della sua volontà di vigilare su ciò che il figlio scrive in segreto.
L’azione del padre come figura genitoriale distorta, controllatrice, vittima psicologica paradossa della sua stessa, destinale deriva dispotica, si condensa nella dittologia verbale che fa da titolo al cap. 16, “troncare, sopire”, in sinistra assonanza e quasi in parallelo isocolo e isoritmico con il sorvegliare e punire di foucaultiana memoria; il suo sgretolamento è anticipato da un passo di scrittura tematica all’inizio del cap. 17, con il crollo del reguitti, del servo muto, che a sua volta riprende il “crollo, bum, tutto rotto, confuso” che segue, nel cap. 3, al primo divieto del padre, di interagire con l’Alberto. L’elaborazione-rifiuto della figura paterna, al culmine dell’ “odio” filiale, è condotta attraverso una analisi impietosa, in cui si stigmatizzano “l’incubo di essere ancora… giudicato dal padre”, “i suoi maldestri atti d’amore”, l’ostentazione del rampollo e i ricordi infantili (“mi chiedevo quante volte dovrò far salire l’elicotterino… perché lui pensi che sono contento che me l’ha regalato”), l’inefficacia delle sue azioni disciplinari (tenere occupato il figlio e impedirgli di leggere); in parallelo, la paternità esteriore e assente lascia al protagonista uno spazio sotterraneo dove la sua identità si sviluppa in modo latente. Il parricidio interiore che il protagonista compie, con tanto di immaginazione della pena che ai parricidi infliggevano i romani (“Essere gettati nel tevere in un sacco insieme a un cane, un gallo, una vipera e un serpente”) è immune di principio anche al perdono incondizionato (“i padri sanno perdonare tutto… ma tanto ti odio lo stesso”) e compie questa sorta di Entgötterung del paterno il cui progredire segna gli snodi narrativi dei primi trenta capitoli.
Nel frattempo, anche l’Alberto compie la sua parabola come personaggio: dalla sua freddezza (cap. 22, Mare), all’ebbrezza momentanea, condivisa con Franco, di Tandem (cap. 23), in cui ancora una volta il dettaglio biografico di un poeta, Pascoli (il suo legame con Severino “Ridiverde”), è proiezione e manifestazione indiretta del desiderio del protagonista, e in cui però l’Alberto esorta quest’ultima a farsi la ragazza per non “fare lo sfigato” -e appare qui una terza, ancora più evanescente, “donna dello schermo”, la Marie-France-, all’episodio della rondine, rimasta intrappolata nella camera della madre e poi liberata (un correlativo oggettivo, e un senhal, evidente dell’ingabbiamento esistenziale risolto), all’episodio della fonovaligia (cap. 25), in cui si attua una nuova triangolazione poetica: uno dei sonetti a Ganimede, di Richard Barnfield, è inviato da Klaus al protagonista (con evidente allusione a un eros sublimato e metaforizzato: ancora una volta, forcluso e al contempo evocato nel mito), il quale lo “trasmette” ad Alberto, che superficialmente non recepisce, si allontana, in cerca di una “nuova arrivata”. Gli ultimi capitoli (26-30) segnano una progressione rapidissima nel distacco dalla figura dell’Alberto: la manifestazione del trasporto fisico verso di lui da parte di Franco determina una reazione di rifiuto (cap. 26, La sdraio: “Lo abbraccio violento goffo. Mi respinge con forza”), a cui segue la tortura del cap. 27, con l’umoristico rovesciamento di ruolo (il padre immagina che il protagonista sia stato traviato dall’Alberto, mentre stava accadendo l’esatto contrario, con tutti i buffi contraccolpi, fra cui il vano tentativo di convincere la moglie a “cambiare mare”), e con un altro rovesciamento di ruolo: l’atteggiamento di disprezzo che all’inizio il protagonista aveva rivolto verso la sua seconda “donna dello schermo”, la Patrizia, è ora rivolto verso di lui dall’Alberto, che diviene in tutto e per tutto immagine virtualmente antisimmetrica di Franco, perfino nella complicità con il proprio padre, nel condannarlo (cap. 28: “Alberto confabula un momento con suo padre, entrambi mi guardano scuotendo la testa”). La confidenza con il prete “non vecchio, gentile”, che segue, ed è funzionale a una sorta di crisi di crescita del personaggio, si presenta come una sorta di surrogato del dialogo con Klaus, e si esaurisce in un ennesimo dono proiettivo, un anodino libro di Raoul Follereau, resistente e missionario impegnato contro la lebbra. Alberto si rivela infine un altro esempio di virilismo tossico anni Sessanta, e insieme al padre del protagonista si ritrova “per sempre dalla parte dei nemici”, per “lo stigma” che l’omosessualità comporta agli occhi del virilismo machista che l’Alberto comunque rappresenta. Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, le macro-strutture narrative connotate da circolarità in progress continuano ad agire; abbiamo qui tre momenti, scanditi dall’affioramento delle memorie letterarie (i poeti), e in particolare: 1) Guinizelli-poeti dello stilnovo, gnosi dell’amore (contesto in cui sembra affiorare, nel retroterra, una sorta di tesi dei Fedeli d’amore à la Luigi Valli), a cui segue a) la contemplazione dell’Alberto che esiste in quanto lontano e straordinario, in quanto distanza e desiderio + ultima “donna dello schermo” (quasi inesistente “tanto per parlare in francese”: Marie-France) + sospirato ritorno di Alberto; b) apparizione del gesuita Klaus; c) vita con Klaus; 2) compleanno e triangolazione non recepita dei poeti, Klaus-Hopkins per Franco, Roberto-Lorca per Franco, (Franco) per Alberto a cui segue, a1) incontro con il compagno di scuola di Alberto = Alberto “quotidiano e ordinario” che “così non esiste”; b1) nuova presenza interdittiva del padre + allontanamento/obliterazione di Klaus + parricidio interiore da parte del protagonista; c1) rapporto altalenante con Alberto, in cui campeggia 3) un nuovo episodio non recepito relativo al mondo poetico, Zvanì-Pascoli – Severino-Ridiverde, a cui segue la disillusione risolutiva dopo 4) la lettura del sonetto a Ganimede di Barnfield. Questa macrostruttura di primo livello è incastonata in una struttura più semplice, che può così riassumersi: α) dissociazione fisico-psichica e sociale del corpo e dell’orientamento sessuale; β) esperienze violente/clandestine e associazione omosessualità-marginalità-crimine (lo stigma); γ) azioni interdittive dell’autorità paterna + manovre elusive di Franco; δ) passione per l’Alberto; ε) prima “fondazione” culturale dell’esperienza amorosa con Guinizelli; a cui corrispondono simmetricamente: α1) assestamento culturale della dimensione fisico-psichica, grazie alla figura sublimatrice del gesuita, β1) abolizione delle esperienze violente/clandestine; γ1) azioni interdittive dell’autorità paterna + ribellione dell’odio da parte di Franco; δ1) fine della passione per l’Alberto; ε1) fondazione di una “missione esistenziale”, ovvero il superamento dello stigma che la virilità anni Sessanta associa all’omosessualità. Le due sequenze sono opposte, simmetriche e speculari anche dal punto di vista del trattamento dell’enciclopedia della società anni Sessanta dal punto di vista dell’adolescente Franco: ipogrammi, o cripto-rimandi, culturalmente “deboli” o “banali” (il cinema per come riflette il senso comune distorto -le tracce se ne rinvengono in via ipotetica, per mera contiguità cronologica e interpretazione di atmosfera e Zeitgeist); sistema esplicito dei riferimenti poetici/culturali, con slittamento/fuga del destinatario rispetto al donatore e alla sua proiezione culturale ed esistenziale nel libro -un esempio per tutti: l’attrazione non riconosciuta di Roberto per Franco, che si trasforma nel dono delle poesie di Lorca -che fra l’altro dovrebbero essere quelle delle censurate Obras completas del 1953, in cui mancano i Sonetos del amor obscuro, di tema omosessuale. Nel complesso, le macrostrutture circolari in progressione delle prime quarantasette pagine del romanzo determinano il costituirsi di un personaggio centrato, con una missione in positivo, per quanto si sia originata da una sorta di assestamenti in negativo. Franco attua una triplice dialettica del no: 1) contro l’autorità del padre; contro il machismo di Alberto; contro lo stigma sociale espresso dalla virilità anni Sessanta, rappresentato dagli uomini e introiettato dalle donne, stigma che colloca l’omosessualità fra le devianze (Alberto guarda il protagonista con un misto di disprezzo e di pietà per il caso da curare) o in regioni contigue al furto e alla prostituzione, o quantomeno nella squallida clandestinità fisiologica di una toilette pubblica.
La seconda parte del romanzo sposta la narrazione su un piano intellettuale, tanto quanto l’esordio si colloca in una dimensione di fisicità traumatica e di dimensione dissociata. Il capitolo trentuno si incentra sulle coordinate dell’amore pederotico che è ordinaria amministrazione presso i greci, con la sua distinzione di ruoli fra erastés-maestro ed erómenos-discepolo. Il protagonista liquida la passione per Alberto come l’effetto di un errore di valutazione: l’essersi voluto annoverare fra gli erastài “senza averne l’età e l’autorevolezza”, in un contesto che peraltro è strutturalmente omofobico (lo stigma che abbiamo detto). L’attrazione per Alberto è in realtà, per un fenomeno proiettivo, un effetto dell’iniziale dissociazione/non centratezza del protagonista, così che si può tranquillamente affermare, che nel suo consuntivo di inizio seconda parte, Franco implicitamente stabilisca un ennesima, più sofferta posizione dialettica del no: il sistema sociale fondato su disvalori omofobici ritiene equivoca l’omosessualità; in realtà l’equivoco sussiste, ma come equivoco cognitivo-esistenziale, vale a dire come fraintendimento, prodotto della mancata accettazione di sé stesso e dell’introiezione dei sistemi repressivi (i gusci proiettivi, e protettivi, che occultano/forcludono la vera struttura del desiderio).
Una volta superato l’auto-fraintendimento, il protagonista immagina di potersi progettare come erómenos: in tale prospettiva, l’unico possibile erastés è Klaus, non fosse il suo allontanamento a opera del “padre molto reverendo” di Franco, padre incline al troncare/sopire, un sorvegliare/punire di fatto castrante. Nel frattempo, il padre equivoca, rassicurato, nell’interpretare la frequentazione di Franco con la Michela e la Patrizia, ora a tutti gli effetti “donne dello schermo” complici della dissimulazione onesta del protagonista narrante. Come si può notare, l’esordio del secondo macro-momento narrativo de Il gesuita riepiloga, nuovamente e contrario, con rovesciamento speculare e circolare, la sezione incipitaria. Gli elementi a supporto di questa mappatura narratologica sono molteplici: basterà qui richiamarne alcuni, i più emblematici. Infatti: Se all’inizio a) la presa di coscienza della propria omosessualità arriva al protagonista da un rapporto passivo casuale, imposto, e poi cercato, in una dimensione di fisicità bruta; qui a1) l’accettazione della propria identità conduce il portagonista a progettarsi come eròmeno di un personaggio connotato al massimo grado di profondità intellettuale, che si rivolge a lui sistematicamente come a uno “spirito” (agglutinando Klaus, Guinizelli e Petrarca, a uno “spirto gentile”); se b) all’inizio le storie con Michela e Patrizia sono accettate come mascheramento sociale del desiderio con la rassegnazione del conformismo; ora b1) sono cercate in una dinamica di scaltra complicità; se c) il padre è presenza interdittiva castrante, ora c1) è ridotto a “vecchierel canuto e bianco”/”vecchierel bianco e infermo” di petrarchesco-leopardiana memoria, così che se prima d) il suo andare a Chianciano per la cura del fegato è atteso come momento di liberazione ora d1) il suo ritorno da Chianciano diviene occasione propizia dello snodo narrativo destinato a far procedere la vicenda centrale del romanzo. Incidentalmente, sappiamo che anche il padre cela dietro i gusci proiettivi-protettivi dell’ipocrisia la struttura del suo desiderio: ha sposato la madre di Franco (nel romanzo, semplicemente “la madre”, ipostasi opposta al padre), la quale è dolce e remissiva, ma il suo ideale di donna è una personalità volitiva e decisa, come una certa albergatrice di Santa Maria Maggiore che è la sua vera compagna. Un’irregolarità latente che accomuna, e nello stesso tempo distingue, a causa dell’asimmetria uomo-donna imposta dalla virilità anni Sessanta, il padre e una sua cugina, Giulia, che dopo il liceo rimane incinta di “un bellimbusto che le aveva dato due gemelle prima di finire in galera per una gravissima rapina” e viene perciò ripudiata per anni dalla famiglia, salvo poi riacquistare rispettabilità come impiegata della Corte dei Conti (divenendo cioè, per parafrasare Gadda, una statale distintissima). Giulia, che abita a Roma e viene a Gallarate per visite a parenti vivi e morti, è avvicinata dal protagonista, così che questi ottiene di poter trascorrere con lei il periodo natalizio, avvicinandosi a Klaus, di cui solo ora scopriamo con evidenza che è stato allontanato per esplicita richiesta del padre, titolare della ditta ristrutturatrice degli impianti dell’Aloisianum, dove Klaus proseguiva i suoi studi. È interessante notare qui un’altra corrispondenza fra le due prime parti del romanzo: nei capitoli 1-6, nella storia si definiva la trama antropologica del virilismo e la struttura delle relazioni interumane nello scenario degli anni Sessanta; qui (capp. 33-34) la prospettiva si allarga a una prospettiva implicita sull’intera società del boom economico e dintorni: la dimensione normativa condivisa copre l’anomalia come una foglia di fico troppo stretta; nello stesso tempo il sistema in transizione e sviluppo si fonda sul sopruso radicato nei rapporti interni all’economia, piccoli o grandi che siano. In questo panorama Franco comincia a porre in atto il suo progetto personale: “voglio amare ed essere amato”, riferimento a Hesse, ma di fatto anche ipogramma frommiano. Si viene delineando poco a poco, sempre in rebus e senza proclami ideologici, una concezione di fondo che potremmo definire neo-marxistica, e un’idea rivoluzionaria: una visione secondo cui la struttura del desiderio è riflessa in modo deforme ed è soggetta a torsione pulsionale ad opera della sovrastruttura antropologica della società e del suo pseudo-principio di realtà che in effetti è solo il sistema di direttive emesse dal centro di comando (e dei concreti rapporti di forza ad essa sottesi). In una generica prospettiva neo-marxistica, missione dell’intellettuale è scardinare le istituzioni culturali deformanti e rovesciare dialetticamente la concezione ideologica di principio di realtà che esse diffondono. Dal punto di vista del protagonista narrante, la rivoluzione consiste nel liberarsi dal padre (= dalla rete di ordini-comandi-soprusi di cui il padre è il centro geometrico) e nel contempo l’erastès di elezione, Klaus, deve “liberarsi dai gesuiti” (in ultima analisi, da un’altra maschera del padre); su un piano categoriale, la lotta per riappropriarsi della struttura del desiderio alienato è organica alla lotta per riappropriarsi di sé stesso e della propria unicità individuale -ed è del resto Klaus stesso ad aver prefigurato questa maturazione, definendo per tempo Franco, in modo mediato, attraverso l’analogia con Nietzsche (cap. 38), “robusto pensatore individualista” in un senso diverso da quello che ci si aspetterebbe, quasi da sinistra hegeliana, quasi, paradossalmente, neo-stirneriano, considerando che la riappropriazione di sé contro un conformismo alienante è quanto di più eversivo si possa determinare, in una società conformistica industriale di massa in via di formazione e assestamento. In tal senso, la lotta contro lo stigma, che poi alla fine sarà lotta per costruire istituzioni non omofobiche e in generale non discriminatorie, è sostanzialmente una lotta di avanguardia che ha come teatro l’orientazione pulsionale. La cosa è tanto più paradossale, se si pensa che all’epoca in cui il romanzo è ambientato i partiti comunisti e in genere gli orientamenti politici legati al socialismo reale (la cui presenaza è nello sfondo, fra le notizie su Krushev e le scritte anti-maoiste di cui alla prima parte) sono apertamente omofobi tanto quanto i loro opposti di estrema destra. In sostanza, nella sua lotta il protagonista è fondamentalmente solo, avendo contro un sistema che ex professo è alienante, il capitalismo industriale con il suo conformismo perbenista, ma anche il suo falso opposto, il cattivo comunismo della statalizzazione totalitaria sovietica.
Poste tali premesse, si comprende meglio il processo narrativo che si incentra nel rapporto con Klaus: all’annuncio che i “tempi remoti” del rivedersi non sono così remoti, Klaus risponde “un po’ da erastès (quale il protagonista vorrebbe che fosse), un po’ da prete (quale effettivamente è)”. L’intreccio epistolare fra il gesuita e il narratore interno, corrispondenza che in altri autori avrebbe seguito uno sviluppo a sé come forma narrativa goethiana e foscoliana, è qui condensato in poche lasse di prosa e prefigura l’apparizione di un nuovo personaggio fondamentale nella trama, Jason, l’archeologo americano impegnato in politica; il richiamo scoperto a Wilde e al suo vulgato aforisma sulle tentazioni, apre anche la via al nodo centrale di questa macro-sezione: “stanare Klaus” (cap. 36), ovvero combattere contro la sua fede, stante il fatto che la fede del protagonista non sussiste come problema, poiché semplicemente non è, “forse non c’è mai stata” (il parricidio metafisico alla base del parricidio psicologico). Il rapporto fra erastès potenziale e colui che si progetta eròmenos tende da principio a un rovesciamento di ruoli: il protagonista ha una visione neo-kantiana della legge morale (“sento fortemente dentro di me la legge morale”) senza bisogno di ordini tassativi da parte di una religione autoritaria. Così, per sgretolare la fede di Klaus, che gli è necessario per “crescere e conoscersi”, superando gli effetti delle sue esperienze “ributtanti” o insoddisfacenti, Franco scava proprio nella biblioteca dei gesuiti, cavandone fuori le argomentazioni di Marsilio da Padova sulla convenzionalità controllatrice delle religioni: si attua così una sorta di contro-maieutica (il presunto allievo cerca di stanare dalle sue convenzioni intellettuali il presunto maestro). La risposta di Klaus (cap. 38), Franco rassomiglia al padre più di quanto non immagini, ha funzione parimenti maieutica, di senso inverso, dall’individuale all’universale, per parafrasare i pensatori medievali; soprattutto, la risposta di Klaus, che si serve di Nietzsche come grimaldello concettuale e di Cecco Angiolieri come ironia affettuosa e rivelatrice, fa da contraltare alle ricerche di Franco. I capitoli del dialogo epistolare con Klaus assumono così la fisionomia di un dialogo platonico ed è come se nella sua ulteriore maturazione, il protagonista superasse la semplice dialettica del no, il conflitto, l’opposizione reattiva, per guadagnare la dimensione di una dialettica diairetica (di tipo platonico appunto) e nel contempo eretica. È una dimensione comunque rischiosa, poiché stavolta il nemico da affrontare non è un padre facilmente ridimensionabile, per quanto latore di una educazione all’ipocrisia, né la superficialità di un mancato partner come Alberto, ma uno Stato che ancora possiede nel suo ordinamento giuridico una legge ambigua (una sorta di dispositivo tuttofare per la carcerazione di “indesiderati” ideologici, fra cui gli omosessuali) come quella sul reato di plagio, per cui in quegli anni è perseguito Aldo Braibanti, accusato di “manipolazione psicologica” verso Piercarlo Toscani e Giovanni Sanfratello. Il rapporto Klaus-Franco potrebbe finire alla stessa maniera, e si muove sul filo sottile, rarefatto, di un intellettualismo soffuso, in cui i riferimenti evocati, dal Defensor pacis a Nietzsche a Cecco d’Ascoli, il razionalista ed eretico oppositore di Dante, fino ad arrivare allo Stephen Daedalus joyciano mediato da Pavese, identificano un terreno comune di confronto, in cui è paradossalmente l’eròmenos “candidato” a giocare all’attacco; stavolta, i poeti, o meglio gli autori, nel senso classico del termine, sono evocati come forme di fondazione, non più come mera proiezione individuale: così per esempio, si allude polemicamente alla coppia Dante-Manzoni come alla causa culturale dell’essere, quello italiano, un popolo di beghini, a differenza del popolo inglese, fondato su Shakespeare e su Walter Scott. Il capitolo 44 (Vedi che ti vengo incontro) corrisponde, a distanza, al capitolo su Guinizelli della prima parte, e costituisce una sorta di puntualizzazione ontologica; l’andamento che Klaus imprime al discorso riecheggia a distanza le intrusioni del latino medievale nella prosa de La vita nuova, fra il discorso dell’appetitus e il tema dei trascendentali come metacondizione della bontà, verità, unità dell’esistente. Ma nel corso delle schermaglie verbali a distanza, in cui la struttursa narrativa complessa della prima parte si è ridotta, volutamente, a dialogo platonico dislocato, botta e risposta, echi di maieutiche a ruoli invertiti, Klaus appare trincerato, nel senso filosofico e in un senso metaforico del termine: trincerato, nel senso del decostruzionismo, nei predicati della sua tradizione filosofica, ma anche arroccato nell’armatura istituzionale della sua fede, dell’ordine dei gesuiti e della chiesa. Sistematicamente, Klaus sposta e sublima l’attrazione verso lo “spirito”, il “cervellino”, tendenza che per Franco è insoddisfacente, così che in realtà, se la mappatura delle strutture narrative interne ai capp. 33-46 è abbastanza semplice (botta e risposta in un dialogo filosofico travasato in una sequenza epistolare), essa acquista profondità in rapporto alle strutture circolari progressive della prima parte, “picaresca”. Di fatto si possono notare, a largo raggio, disposizioni antisimmetriche: A) esperienze fisiche “ributtanti” con uomini vs. A1) costruzione ideale della relazione erastès-eròmenos; B) frequentazione a distanza e poi ravvicinata dell’Alberto, superficiale e indifferente destinatario delle attenzioni affettive e culturali del protagonista vs. B1) frequentazione a distanza e poi ravvicinata di Klaus, ricettivo delle attenzioni affettive e culturali del protagonista (o più semplicemente: assenza di dialogo vs. dialogo profondo); C) triangolo “imperfetto” di mancate corrispondenze (Roberto-Franco-Alberto) vs. C1) triangolo di corrispondenze (Franco-Klaus-Jason, quest’ultimo a partire dal cap. 55). La parentesi epistolare si chiude con il cap. 46 (Ogni virtù barcolla), chiuso dalla citazione integrale di un sonetto scespiriano, in cui di fatto Klaus (ipoteticamente l’erastès) dichiara a Franco un bisogno più profondo di quanto Franco stesso (ipoteticamente l’eròmenos) non ne abbia di lui. Da un certo punto di vista, l’intera sezione che precede le “vacanze di Natale” e la partenza per Roma, è una sorta di casistica (gesuitico-stilnovistica) del servitium amoris (di cui al cap. 45: “sono pronto a servirti”). I capitoli 47-51, ultime lettere di transizione immediatamente prima della partenza, culminano nel dibattito sul Natale, in cui si contrappongono la visione olistica-tradizionale del gesuita e la decostruzione di Franco, che analizza tutti i fenomeni di sincretismo che il natale nasconde e più avanti (cap. 51) mette in discussione la coerenza morale e politica dell’ordine a cui Klaus appartiene. Di fatto si assiste al procedere della lotta del protagonista contro la fede di Klaus; che questa fede sia rivolta al Lui con la maiuscola (cap. 52), rende la situazione ancora più complessa e ambivalente. I capitoli della permanenza a Roma e del rapporto diretto con Klaus (dal 53 al 60) sono incentrati su una schermaglia a tre, Klaus-Franco-Jason, che come si è accennato schematicamente, è simmetrica e antifrastica al terzetto improprio Alberto-Franco-Roberto.
Il capitolo 53, con molteplici allusioni alla Roma di Nerone di cizekiana memoria, sembra avvalorare una chiave di lettura peculiare. Se nei capitoli 1-30 sembra di leggere una sorta di romanzo neo-realista, non lontano dall’atmosfera dei ragazzi di vita pasoliniani (né potrebbe essere altrimenti, vista la tradizione del genere letterario), il complesso dei capitoli 31-60 (ma in qualche modo anche la terza parte), vira verso una sorta di riscrittura à rebours del Satyricon: si può in effetti affermare, senza troppo andare errati dal vero, che comunque Il Gesuita nel suo insieme, fra dinamiche compositive tradizionali (circolarità, digressioni dotte), io narrante, casistiche, prosimetro, citazionismo funzionale sul piano narrativo, capitoli brevi, lunghi al massimo due pagine, è un romanzo antico esteriormente contaminato da elementi moderni e tardo-moderni: se ne manifesta la consapevolezza metaletteraria al cap. 63 (lasse iniziali della terza parte), che guarda caso si intitola Puer furbo, in cui il protagonista si immagina al centro di un sermo milesius alla Apuleio, o alla Petronio, nel ruolo del puer inaffidabile. Tali figure di pueri sono diffuse nella novellistica di età tardo-repubblicana e alto imperiale; la citazione è patente: Giovenzio (Catullo), Marato (Tibullo) ma soprattutto l’ambiguo puer Pergamenus (Satyr. 85-87), in realtà il terzetto omosessuale nel mondo greco-romano imperiale è per eccellenza quello costituito da Encolpio-Gitone-Ascilto, poi mutato, nel corso della narrazione petroniana, in Encolpio-Gitone-Eumolpo. I riferimenti petroniani sono disseminati, dissimulati ed estremamente sottili: proprio al cap. 53, l’allusione al castrato sposo di Nerone, Sporo, destinato a una fine tragica insieme all’imperatore (un caso di martirio improprio, che prefigura il cap. 69, della terza parte, intitolato a sant’Elagabalo martire) richiama e contrario un passo del romanzo petroniano (Satyr. 108) in cui il puer furbo (Gitone) minaccia di evirarsi per rimuovere la causa del contendere fra i suoi molteplici amanti potenziali. Il Satyricon e la fabula milesia agiscono come meta-testo frammentario. Il tema “milesio” resta sospeso, per il momento, in questo passo di scrittura tematica, e procede latente (con il protagonista che ama essere al centro dell’attenzione-attrazione di Klaus e Jason), nelle schermaglie amorose e nella Wanderung culturale di Franco Klaus e Jason a Roma, è prefigurato, nel suo esito “fisico” al capitolo 56 (“suo padre teme…”), ed è destinato a svilupparsi nei capitoli dal 61-75 (terza parte). Nel frattempo, ai capp. 58-60, l’ultimo mediamente un po’ più lungo delle ordinare lasse narrative del romanzo, si viene prefigurando un’altra linea narrativa, che giungerà a compimento nei nove capitoli della quarta e ultima parte: quella dell’impegno politico e sociale, legata alla rivoluzione dei costumi partita dai campus univesitari americani a fine anni Sessanta; l’acquisizione di coscienza che le parole di Jason producono in Franco, prospettando un ulteriore fase evolutiva, si manifesta fra l’altro nell’acquisizione dell’anglismo gay nel senso di homosexual, una parziale novità all’epoca in cui il romanzo è ambientato, è segnata, fra l’altro dall’ennesima citazione narrativamente finalizzata: quella di un pentametro giambico di The Rape of the Lock di Pope: “Belinda smiled and all the world was gay”, cap. 58 “Belinda rise e gaio fu tutto il mondo”, unica accezione in cui l’aggettivo gay era in precedenza noto al personaggio narrante. Il ruolo di Jason, come maestro alternativo a Klaus (in effetti, come erastés più plausibile rispetto a Klaus) comincia a definirsi appunto in questo tratto finale della seconda parte: la storia di Hendrik Christian Andersen e di Henry James conosciutisi a Roma, diviene una sorta di anticipazione tematica del finale del romanzo. In questi capitoli centrali si definisce anche il “gioco adulto” per cui Klaus tende a cedere il suo potenziale eròmenos a Jason. “Adulto” è Leitwort delle fasi clou della seconda e terza parte (accompagna anche l’esperienza del “sesso adulto” con Klaus e poi con Jason ai capp. 71-74).
La terza parte è costruita in progressione speculare rispetto alla precedente e riprende, sia pur nel più breve giro di quindici capitoli, la dinamica di macrostrutture circolari che caratterizza la prima: A) il dialogo con Jason, nel capitolo 61 (Annamo bene!), presenta in forma eterodiretto il tema della doppia determinazione (in questo caso, il double bind non è del protagonista, ma di Klaus: se questi deve “cadere” o restare fedele alla sua vocazione, per opera o con l’aiuto di Jason); A1) nel capitolo 71, dieci lasse narrative dopo, Franco è per un momento, anche sul piano fisico, l’amante di Klaus, che cade effettivamente per opera di Jason; B) al capitolo 62, in cui Jason dichiara apertamente che Klaus (di cui ha chiarito che è di fatto innamorato quasi da subito del protagonista) sta “castrando la sua vita”, le “esperienze di baci” con Klaus e con Jason, anticipano (B1) la preparazione all’incontro con Klaus (cap. 70 e inizio del 71); i capitoli “culturali” in cui (C) Klaus si avvicina emotivamente a Franco (capp. 63-66), corrispondono a C1), all’ulteriore e definitivo capitolo “filosofico” in cui la resistenza emotiva di Klaus è sgretolata dalle argomentazioni di Franco e di Jason su “Sant’Elagabalo martire” di fatto sacrificatosi per una religione e una possibilità di costruzione del sacro che, avendo perso, non ha potuto creare un suo martirologio. Il capitolo 68 (Bar boy) con la visita e l’interazione fra i due “maestri” Jason e Klaus, e la “sorpresa” di quest’ultimo circa la “funzione mistica” di Ganimede (l’eromenos di Zeus) nel contesto del politeismo antico. L’esito conclusivo non è però quello previsto da Franco: i capitoli conclusivi (72-75), prefigurano l’abbandono di Klaus, tramite lettera. L’ultimo capitolo, dal titolo platonico (evocatore delle ultime parole di Socrate morente) ΑΣΚΛΗΠΙΩΙ ΣΩΤΗΡΙ, “ad Asclepio salvatore”, si chiude con il classico finale sospeso, ex abrupto, e richiama, all’interno della macro-struttura circolare che ingloba le due parti centrali del romanzo, l’esordio “platonico” relativo alla riflessione su eròmenoi ed erastài (cap. 31).
L’ultima parte, la più breve, di appena nove capitoletti, porta a compimento il processo narrativo circolare del romanzo. Le strutture narrative di questa parte conclusiva sono alquanto più semplici e lineari: si assiste semplicemente alla progressione della presa di coscienza del protagonista, accompagnato dalla voce di Klaus ormai virata verso il rosso dell’allontanamento (nelle sue tre lettere racconta di aver abbandonato l’ordine e il sacerdozio, per sposarsi e per avere un figlio, che chiamerà Franco: una nuova forma di sublimazione mediata) e dalle riflessioni di Jason, che è diventato il nuovo punto di riferimento amoroso di Franco. La progressione si compie nella presa di coscienza finale, che richiama il “voglio amare ed essere amato” delle fasi iniziali della seconda parte: “sono stato desiderato, dunque sono cresciuto”. Si tratta, stavolta, non di un semplice entimema (come ai tempi dell’Alberto: “Alberto esiste quando è lontano”), ma di un cristallino sillogismo, ellittico della premessa maggiore, ma di limpidezza catesiana ([chiunque sia desiderato, cresce – sono stato desiderato – dunque sono cresciuto: un sillogismo della figura Darii, alla stessa maniera di [omne quid cogitat est]- cogito- ergo sum). Klaus si trova, alla fine del romanzo, ad aver ceduto ai gusci antropologici delle attese della virilità anni Sessanta riguardo al ruolo dell’uomo (“ha bisogno di sentirsi protetto e cerca protezione nelle istituzioni che conosce: la chiesa cattolica, il sindacato, il matrimonio”). Il romanzo addita invece la “nobil natura” di coloro che sanno levare i loro occhi “incontra” alla reale struttura del desiderio e alla convenzionalità transitoria delle soprastruzioni valoriali, come l’eretico Cecco d’Ascoli, quasi un Lucrezio medievale, che con le sue terzine sillogistiche si oppose a Dante e all’autorità ecclesiastica, e pagò con il rogo.
Un’ultima osservazione resta da fare, proprio in termini di strutture triadiche e sillogistiche. Nel romanzo, a livello macro-strutturale, una sorta di battuta ternaria sembra agire, nella scansione narrativa: trenta capitoletti per la prima e la seconda parte, quindici per la terza, nove per l’ultima. La struttura triadica anima anche in qualche modo il procedere dell’intera narrazione: la circolarità delle sezioni connotate da Ringkomposition conosce momenti centrali meditativi, di stop and go; poco dopo la fine della prima parte, e verso il centro della terza, dialoghi filosofici criptati nel racconto costituiscono pause meditative altrettanto fondamentali, le cui reti di riferimenti tematici si estendono su larga scala. Soprattutto, è nella costruzione di terne di personaggi che il sistema narrativo procede: la terna dei desideri frustrati (come abbiamo detto, Roberto-Franco-Alberto; la terna dei desideri compiuti (Klaus-Franco-Jason). In questo sistema di tappe cristallinamente logiche si viene costituendo la vita nova di Franco, la presa di coscienza e la riappropriazione del desiderio contro le strutture alienanti delle distorte antropologie organiche alle reti di comando del dominio socio-economico.