di Lukas Bärfuss
(Per gentile concessione de L’Orma Editore, pubblichiamo un estratto, le prime pagine, da Hagard, romanzo di Lukas Bärfuss tradotto da Marco Federici Solari, e da pochi giorni in libreria. L’autore (1971), scrittore, saggista e drammaturgo svizzero, è tra le più importanti voci del panorama letterario di lingua tedesca. In seguito alla pubblicazione di Hagard è stato insignito del prestigioso premio Georg Büchner)
Da troppo tempo tento di comprendere la storia di Philip. Vorrei scoprire il mistero che nasconde. E per l’ennesima volta ho fallito, incapace di decifrare l’enigma delle immagini che mi perseguitano, immagini crudeli e comiche come in ogni racconto in cui desiderio e morte si incontrano.
So tutto, e non comprendo nulla. La successione degli eventi mi è chiara. So come inizia la storia, conosco il giorno, e conosco il luogo: il chioschetto dei brezel davanti ai grandi magazzini di piazza Bellevue. So quando finisce, ossia dopo trentasei ore, nel primo mattino di giovedì tredici marzo, su un balcone da qualche parte in periferia. Anche gli avvenimenti tra quell’inizio e quella fine sono stati appurati: la questione della pelliccia, la prima notte passata in macchina al freddo e al gelo, il portafoglio smarrito, la gazza, la scarpa perduta, la morte del matematico giapponese… tutto ciò è ormai chiaro come il sole. Le circostanze, però, le condizioni che hanno reso possibile quegli eventi restano celate. Quanto più mi riesce di precisare i dettagli, tanto più il mondo dove la storia si è svolta si fa spettrale. Si potrebbe pensare che mi capiti come a quel tipo che a furia di fissare gli alberi non vedeva più la foresta; solo che la foresta – su questo voglio insistere – è una pura ipotesi, un sistema astratto non riscontrabile nella realtà. La foresta si dissolve in singoli alberi proprio come il cielo si dissolve in singoli pianeti, stelle e meteore.
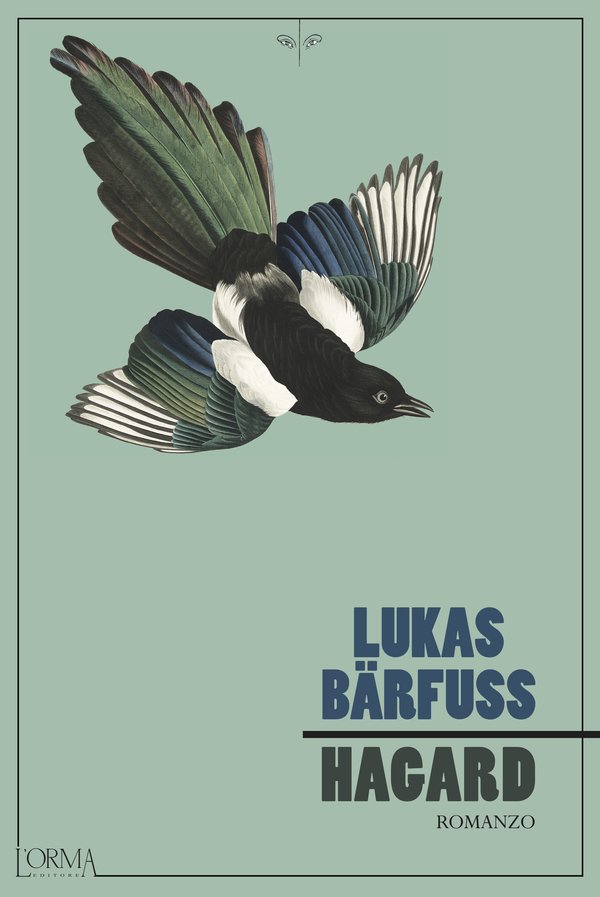
Dopo numerosi tentativi andati a vuoto di trovare un filo conduttore tra le immagini, sono giunto alla conclusione che non sia tanto la storia in sé a sfuggirmi. Il punto è il mio coinvolgimento; voglio scoprire cosa abbiano da dirmi quelle visioni in grado di affascinarmi, incantarmi e a volte condurmi sull’orlo della follia. Mi sono convinto che la mia esistenza sia appesa a questa storia, però, allo stesso tempo, sono consapevole di quanto sia ridicola questa idea; non ho nulla da temere: potrei accantonare gli eventi di quei giorni di marzo e non mi accadrebbe niente. La mia vita proseguirebbe come prima. A pensarci bene, per salvarmi mi basterebbe riuscire ad ammettere definitivamente il mio fallimento. Benché sembri semplicissima, la storia di Philip è troppo grande per me. È come se a ogni tentativo dimenticassi sempre qualcosa, un qualche dettaglio essenziale, come se mi sfuggisse l’indizio capace di mettermi sulla giusta traccia. Quante volte ho giurato di lasciar perdere, ingannando me stesso come l’ubriaco con l’ultimo bicchiere. Sono un giocatore che, a un passo dalla bancarotta, si fa dare di nuovo le carte… Voglio rischiare, tentare ancora un’altra volta, far risorgere gli eventi un’altra volta ancora, e poi che tutto resti pure così com’è.
Sì, la mia frenesia non mi ha dato pace. Anch’io ho le mie ossessioni, ovvio, e come tutti me le tengo volentieri per me. Non perché mi vergogni, alcune semplicemente stonano con l’immagine che ho di me stesso e che ormai, a metà della mia vita, coincide con quella che hanno i miei simili: un uomo con molte debolezze e ancor più principi. Ma l’eros non si cura dell’immagine che abbiamo di noi, al contrario spesso sembra quasi sforzarsi di contraddirla. Tutti hanno il loro lato oscuro, così almeno si dice, ma col tempo ho compreso quanto poco questa oscurità sia da intendersi in senso morale. Le tenebre non vanno associate con il male così come la luce non va legata al bene. La parte buia è quella in cui manca la luce, nient’altro; e mi ci è voluto del tempo per capire che di notte i gatti sono per davvero neri, non lo sembrano soltanto: sono proprio privi di colore. Come ci sono arrivato? Ah, sì, le mie ossessioni. Mi vengono in mente Le confessioni di Rousseau, che ho letto qualche anno fa. Se non ricordo male, l’autore comincia a scrivere un resoconto completo e del tutto sincero sulla propria persona, senza escludere nulla con intenzione: tralascerà di raccontare solo quello che ha dimenticato. Ricordo quanto poco mi fossi fidato di quel proposito, mi pareva una trovata da scrittore, erano «parole vuote», come si suol dire, e ho continuato a diffidare dell’autore fino al punto in cui narra delle sue preferenze sessuali. Non riesco a ricordare in che termini ne parli, so soltanto quanto mi abbiano colpito e come da quel momento in poi io abbia prestato fede alle sue affermazioni. Dovrei dunque rivelare anch’io le mie perversioni per rendere credibile questo racconto?
Alcuni aspetti della storia di Philip mi imbarazzano, e non sono i momenti bizzarri, osceni e malati che pure vi si trovano. Piuttosto non riesco a rassegnarmi alla futilità di certi dettagli. Sono molti gli elementi che paiono quasi insignificanti e del tutto banali. Ad esempio, per me sarebbe più facile se l’attenzione di Philip non fosse stata catturata da quelle ballerine color prugna, un paio di normalissime scarpe basse che da tempo non sono più appannaggio esclusivo delle danzatrici. Calzature acquistabili per pochi soldi, reperibili in qualunque negozio, nelle forme più diverse, cucite o incollate, con o senza fiocchetto, opache o laccate, in ogni tinta possibile e immaginabile. E che nel nostro caso fossero ben rifinite e di una pregiata pelle di vitello non cambia nulla rispetto al dato di fatto: all’inizio di questa storia c’è un paio di scarpe da donna.
L’inizio? Non è mica una cosa facile. Nessuno può stabilire con quale evento prenda avvio una storia. In principio Dio creò il cielo e la terra, così è scritto, ma prima che ha combinato? E qualunque cosa fosse, perché non fa parte del principio? I fisici, che sostituiscono Dio con il Big Bang, obietteranno che la domanda è assurda perché presuppone il tempo, e questo prima di Dio o del Big Bang non esisteva. I libri e i film pretendono di cominciare, ma nella realtà a partire da quel primo inizio non esiste più nessun altro inizio. E, per inciso, neppure alcuna fine, se può essere di una qualche consolazione. L’Uno fluisce nell’Altro; ma la maniera in cui la conclusione di una certa storia si colleghi al principio di un’altra rimane inaccessibile allo spirito umano. Chi vuole districare la trama della realtà finirà per rimanervi impigliato. Personalmente rifiuto questa tesi. Desidero risolvere l’enigma, ma non ho alcuna intenzione di impazzire.
Sono un testimone di quei giorni di marzo, e in quanto testimone li racconterò, senza omettere né risparmiare nulla. Alcuni elementi mi porranno in cattiva luce, ma non mi importa. Per risultare credibile potrei espungere qui qualcosa, inventare lì qualcos’altro, ma non voglio. La mia ossessione, dunque lo confesso, la mia ossessione è la veridicità. Insulse o meno che siano, sono state proprio delle ballerine color prugna a smuovere Philip. Perché le ha seguite? A ciò non so rispondere. Sarà stato un gioco, almeno al principio, un gioco innocente e innocuo, perché se Philip avesse intuito cosa sarebbe accaduto nelle ore successive avrebbe lasciato stare la donna all’istante. Non cercava la propria rovina, e tantomeno il pericolo, anche se poi, giunto il momento, quando ha compreso a quale filo fosse appesa la propria esistenza, ha affrontato quel pericolo senza esitare.
Quel che è certo: martedì undici marzo, alle quattro e un quarto, Philip, un uomo sulla quarantina inoltrata, massiccio e da qualche anno un po’ fuori forma, attendeva in un bar al limitare del centro storico un certo Hahnloser. Philip non lo conosceva, sapeva solo che di recente la sua impresa di tinteggiatura era fallita e l’uomo si vedeva costretto a cedere un lotto di terreno di proprietà della sua famiglia da generazioni, un fondo non edificato in una zona soprastante il lago. A Philip il luogo dell’appuntamento non andava a genio, avrebbe preferito la sala riunioni della sua ditta, ma fiutando un affare veloce che stimava potesse fruttargli, diciamo, trentamila, e poiché verso le sei doveva comunque raggiungere Belinda, che non abitava lontano da quel caffè, aveva accettato.
Il locale si trovava in un suntuoso palazzo signorile dell’Ottocento, un ex Grand Hotel dell’epoca della più intensa espansione urbanistica della città, quando vennero rasi al suolo i bastioni per gli artiglieri e innalzati gli argini del lago. Oro e velluto rosso dominavano l’ambiente, un’ampia scalinata conduceva a una terrazza dove madri con bambini sedevano a tavolini colmi di resti di dolciumi, bicchieri di sciroppo vuoti e tazze di caffè. Hahnloser si faceva aspettare, e Philip fu tentato di ordinare una fetta di torta in bella mostra in una vetrinetta, ma, poiché non voleva in nessun caso farsi sorprendere con la bocca piena e l’orario convenuto era passato da appena cinque minuti, si accontentò di un caffè in cui versò due bustine di zucchero. Di Hahnloser però non c’era traccia neppure dieci minuti più tardi, dieci minuti che sarebbero bastati e avanzati per ingollare quasi la metà di una torta. Philip provò a chiamarlo e a mandargli un messaggio: nessuna reazione. E, dopo essersi fatto confermare da Vera che il numero fosse giusto, scorse le ultime notizie riguardanti l’aereo della Malaysia Airlines, un Boeing 777, che la domenica precedente era scomparso da qualche parte all’altezza dei Quaranta ruggenti con a bordo duecentotrentanove anime, una tragedia che lo incuriosiva e lo inquietava. A Kuala Lumpur le autorità non avevano la più pallida idea di cosa fosse accaduto al velivolo. La ricerca, che di ora in ora veniva ampliata ad aree più vaste, rimaneva senza esiti. Oltre a cinesi e malesi, la lista dei passeggeri conteneva pure i nomi di due austriaci, che si erano rivelati poi essere degli iraniani saliti a bordo con passaporti falsi. Per alcune ore i due erano stati ritenuti terroristi, finché non era emerso che si trattava di immigrati clandestini e di conseguenza pure quell’ipotesi investigativa era sfumata. Rottami non ne erano stati trovati e le macchie di petrolio nello stretto di Malacca derivavano dal quotidiano traffico navale.
A un certo punto Philip decise di compiere una ricognizione del locale, ma non notò nessuno che corrispondesse alla descrizione di Hahnloser. Ritornato al proprio tavolino, lo trovò sparecchiato; una signora in carne con una cuffietta azzurra occupava il suo posto. Philip rimase per un attimo interdetto, indeciso sul da farsi, poi afferrò la propria ventiquattrore, pagò al bancone, prese il resto e uscì in strada.






