Deserto solitario
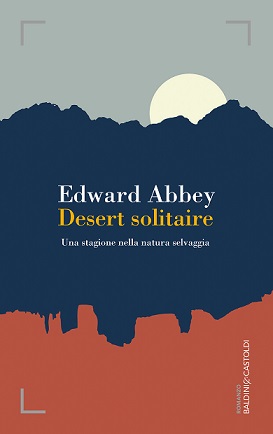 (torna in libreria Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia. Attualissimo, non ostante gli anni. Ringraziamo l’editore per averci regalato un estratto del libro. G.B.)
(torna in libreria Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia. Attualissimo, non ostante gli anni. Ringraziamo l’editore per averci regalato un estratto del libro. G.B.)
di Edward Abbey
Qui da solo, immerso nel silenzio, capisco il terrore che molti provano in presenza del deserto primordiale, la paura inconscia che li spinge a voler domare, alterare o distruggere ciò che non riescono a comprendere, a ridurre il selvatico e il preumano a dimensioni umane. Qualunque cosa piuttosto che confrontarsi direttamente con l’anteumano, con quell’altro mondo che ci spaventa non tanto perché sia pericoloso o ostile ma per qualcosa di molto peggiore: la sua implacabile indifferenza.
Via dall’ombra, nella calura. Procedo a passo pesante nella gola sinuosa, nel silenzio, severo ma fragile. In questa atmosfera così arida i suoni non svaniscono, non producono eco e neppure muoiono dolcemente ma si estinguono all’improvviso, bruscamente, senza il minimo riverbero. Il cozzare delle rocce l’una contro l’altra è come uno sparo: sordo, improvviso, eccessivo.
Dietro la curva successiva, eccolo, inaspettatamente, il ponte di pietra.
Inaspettatamente, scrivo. Perché? Avevo fiducia, sapevo che il ponte sarebbe stato qui, sfidando ogni probabilità. E sapevo anche abbastanza bene quale aspetto avrebbe avuto: tutti lo abbiamo visto in fotografia almeno un centinaio di volte. E non sono nemmeno deluso in quel modo vago che spesso proviamo quando ci troviamo di fronte a uno spettacolo che a lungo avevamo immaginato. Il Rainbow Bridge non sembra né più piccolo, né più grande di quanto avessi previsto.
Poi mi sento in colpa. Newcomb. Perché non ho insistito che venisse con me? Dovevo afferrarlo per i peli della sua lunga barba da selvaggio e trascinarlo per il sentiero, caricandomelo in spalla come San Cristoforo al momento di attraversare il torrente, inciampando sulle pietre e scaricandolo infine sotto il ponte, lasciandolo lì a marcire o a strisciare di nuovo verso il fiume. Nessuno avrebbe potuto desiderare una defenestrazione più incantevole.
Attraverso la finestra di Dio sull’eternità.
Oh, be’. Salgo ai piedi del contrafforte orientale e metto la mia firma e quella di Ralph nel registro dei visitatori. Lui è il numero 14.467 e io il successivo a firmare questo libro da quando i primi uomini bianchi raggiunsero il Rainbow Bridge nel 1909. Non molti per essere passato più di mezzo secolo, e soprattutto nell’era della pubblicità. Ma non è mai stato un viaggio semplice. Fino a oggi.
La nuova diga migliorerà le cose, ovviamente. Quando sarà piena, l’acqua arriverà fino al Bridge, trasformando un’avventura nella solita escursione in motoscafo. Per chi lo vedrà in futuro sarà impossibile capire che metà della bellezza del Rainbow Bridge risiedeva proprio nella sua lontananza, nella relativa difficoltà ad accedervi, nella natura selvaggia che lo circondava e di cui era parte integrante. Una volta rimossi questi aspetti, il Bridge non sarà nient’altro che un’isolata bizzarria geologica, un’ulteriore estensione di quel diorama museificato a cui il turismo industriale tende a ridurre il mondo naturale.
L’eccellenza è tanto difficile quanto rara, disse un uomo saggio. Se è così, che cosa accade all’eccellenza se eliminiamo la difficoltà e la rarità? Parole, parole… Il problema mi fa venire sete. C’è una sorgente sull’altro lato del canyon, proprio sotto una cengia alla base occidentale del Bridge.
Scendo giù, risalgo dall’altra parte e raccolgo l’acqua dal muschio gocciolante con l’aiuto di una lattina abbandonata lì da qualcuno.
Il caldo è impressionante. Mi riposo per un attimo all’ombra, mi addormento e sogno nella luce terribile del mezzogiorno. Quando il sole cala dietro l’orlo del canyon, mi alzo e ritorno da Newcomb e al nostro bivacco.
Ma vengo attirato dalla traccia di un sentiero che sembra condurre fuori dal canyon, passando sopra il Rainbow Bridge.
Tardo pomeriggio, il canyon si sta riempiendo di ombre, non dovrei tentare. Decido comunque di provarci: risalgo un ghiaione e traverso un lungo terrazzo inclinato che sbuca nell’aria sottile alla base di un alto dirupo. Impossibile proseguire.
Ma dall’alto penzola una corda, fissata a un punto invisibile. La provo, sembra ben ancorata, e aiutandomi con quella e qualche opportuno punto d’appoggio per i piedi e le mani mi faccio strada fino in cima. Da lì all’orlo del canyon la strada è lunga ma non impegnativa.
Sono di nuovo all’aperto, fuori dall’inframondo. Da quassù, il Rainbow Bridge, trecento metri più in basso, è solo una cresta di arenaria di non eccessiva importanza, un minuscolo oggetto perduto nell’intricata vastità del sistema dei canyon che si irradia dalla base della Navajo Mountain.
Più interessante è la vista verso nord, est e ovest, che rivela la struttura generale del territorio che abbiamo attraversato a bordo delle nostre piccole imbarcazioni.
Il sole, ormai in prossimità dell’orizzonte, splende nell’aria limpida sotto strati di nuvole, illuminando con tenui variazioni di rosa, vermiglio, terra d’ombra e ardesia, i complessi tratti e i dettagli, definiti in maniera netta dall’ombra, del paesaggio del Glen Canyon. Vedo la mesa dai bordi squadrati oltre la confluenza del San Juan e del Colorado, gli altopiani dello Utah centro-meridionale, e più in là, centocinquanta chilometri o anche più in linea d’aria, le cinque vette delle Henry Mountains, compreso il monte Ellsworth, vicino a Hite, da dove è cominciato il nostro viaggio.
A oriente una tempesta isolata ribolle sopra il deserto, una massa di nuvole color lavanda sta bombardando la terra di fulmini e pioggia. Ma è così lontana che non riesco nemmeno a sentire i tuoni. Tra qui e là, tra me e le montagne, si estende lo spazio selvaggio del canyon, il territorio magico di guglie, pilastri e pinnacoli dove non vive nessuno, e dove, non visto, nelle fosse neroblu della roccia, scorre il fiume.
Luce. Spazio. Luce e spazio senza tempo, perché in questo Paese le tracce della storia umana sono minime. Nella dottrina dei geologi, con il loro schema di ere, eoni ed epoche, tutto scorre, come insegnava Eraclito, ma dal punto di vista mortale dell’uomo il paesaggio del Colorado è come una sezione di eternità: senza tempo. In tutti i miei anni nel Paese dei canyon – a parte durante le inondazioni – non ho mai visto una roccia cadere di sua spontanea volontà, per così dire. Per convincermi dell’esistenza del cambiamento, e quindi del tempo, spingerò giù una pietra dalla cima di un dirupo, la osserverò scendere e aspetterò – fumando la pipa – di redigere il resoconto del suo impatto e della sua disintegrazione. Farò del mio meglio per aiutare i processi naturali e verificare le ipotesi della morfologia geologica. Ma non ne sono del tutto convinto.
Gli uomini vanno e vengono, le città nascono e muoiono, intere civiltà scompaiono; la terra resta, solo leggermente modificata. Restano la terra e la bellezza che strazia il cuore, dove non ci sono cuori da straziare. Capovolgendo Platone ed Hegel a volte penso, senz’altro in modo perverso, che l’uomo è un sogno, il pensiero un’illusione, e solo la roccia è reale. Roccia e sole.
Sotto il sole del deserto, nella sua dogmatica luminosità, le favole della teologia e i miti della filosofi a classica si dissolvono come nebbia. L’aria è limpida, la roccia intacca crudelmente la carne. Frantumate la roccia e l’odore della selce vi salirà alle narici, acre e pungente. Di giorno mulinelli di polvere danzano sulle pianure di sale; di notte i cespugli pieni di spine si incendiano. Che cosa significa? Non significa nulla. È come è, e non c’è bisogno di trovarvi alcun significato. Il deserto sta lì e svetta oltre ogni possibile qualifica umana. Per questo sublime.
Il sole sta per toccare gli altopiani traforati a occidente.
Per un attimo sembra sobbalzare, espandersi, poi all’improvviso tramonta. Mi metto in ascolto per un tempo lunghissimo.
Nel crepuscolo e alla luce della luna scendo verso la corda, verso la cengia, verso il fondo del canyon sotto il Rainbow Bridge. Nell’aria volteggiano i pipistrelli. Le lucciole volano vicino alle sorgenti e rospi piccolissimi ma dal vocione profondo cantano il loro gracidio verso di me mentre arranco oltre i loro stagni per il lungo sentiero che mi riporterà al fiume, al fuoco, alla compagnia e a una cena di mezzanotte.
Siamo alla fine del nostro viaggio. Al mattino, io e Ralph mettiamo via la nostra attrezzatura, la carichiamo sui gommoni e lanciamo un’ultima occhiata a questa scena che – lo sappiamo – non vedremo mai più come la vediamo ora: il fiume Colorado, maestoso, libero e selvaggio, che scorre
vicino alla base delle pareti torreggianti, che ruggisce tra i massi sotto l’imboccatura del Forbidden Canyon; il Navajo Point e il precipizio del Kaiparowits Plateau centinaia di metri sopra, oltre le pareti interne del canyon; e a oriente, banchi di nubi spinti dalla tempesta impilati l’uno sull’altro, bordati d’oro e scintillanti nell’alba.
Ralph fa una fotografia, rimette la macchina nella custodia waterproof che tiene a tracolla sul petto, e salta nella sua imbarcazione. Partiamo.

