La distinzione: «alla radice del linguaggio»
di Paris Bordon
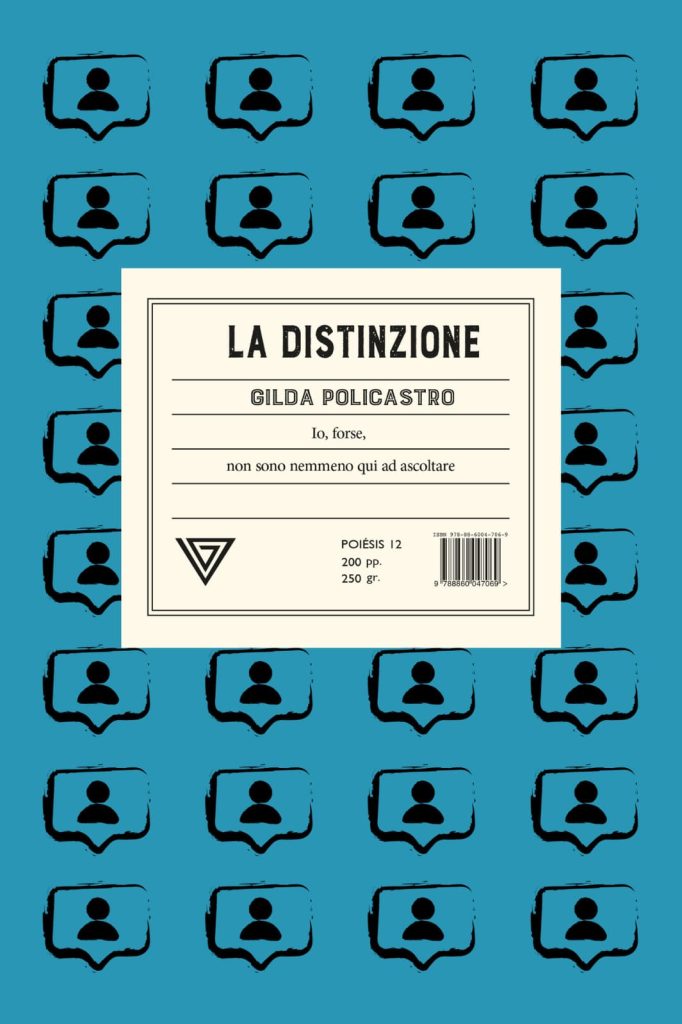
Nell’affrontare una nuova opera di poesia, preferisco avvicinarla, per quanto possibile, senza mediazioni, ignorando prefazioni, postfazioni, commenti sulle fascette o sul retro della copertina: blurb. Aprendo dunque il recente volume di Gilda Policastro, intitolato La distinzione, uscito per Giulio Perrone Editore all’inizio del 2023, sono partito risolutamente dalla prima pagina del testo, occupata da una citazione del poeta francese Olivier Cadiot, posta in esergo, che recita: «Une maladie est guérissable / Un malade est inguérissable». In seguito ho cominciato a leggere i testi uno dopo l’altro, nell’ordine in cui mi si presentavano: metodo che qualcuno riterrà puerile. Quasi mai, infatti, un tale modo di procedere risulta privo di intoppi. Mano a mano che prendeva forma sotto i miei occhi l’articolazione del libro, senza ancora poterla afferrare nella sua interezza, una serie di interrogativi mi spingeva a ritornare su qualche pagina già letta, come quando si è costretti a compiere due passi indietro prima di spiccare un salto. In particolare, giunto a pagina 40, la necessità di guardarmi indietro, di ricapitolare il cammino percorso, spiazzato da un’improvvisa e (per me) faticosa incursione nella lingua inglese, ha avuto come esito quello di ricordarmi che, tutto preso dalla fretta di entrare nel vivo dell’opera, avevo scordato di fare attenzione al titolo. Grave mancanza.
Sarà che a pagina 40, superata la poesia introduttiva, intitolata Precari, che da sola compone la prima sezione (Antefatto) e oltrepassati i sei testi successivi, compresi nella sezione Sala d’attesa (vera anticamera dell’opera, che introduce uno dei temi dominanti del libro: l’ospedalizzazione), ero ormai entrato nel cuore della terza parte (i nove testi di Dispositivi), il cui tema dominante gravitava sempre intorno alla morte, alla fatalità, alla violenza e alla malattia. Sorgeva quindi spontanea, almeno per me, la domanda sulla ragione che giustificasse tali raggruppamenti, tali – appunto – distinzioni. Il titolo non sembrava fornire molti appigli: chi/cosa si distingueva da chi o da cosa e, soprattutto, sulla base di cosa? Sotto il titolo della copertina, dopo il nome dell’autrice, una citazione dall’ultimo lapidario testo che conclude la Suite depressiva (p. 88), sembrava volermi offrire qualche indizio: «Io, forse, non sono nemmeno qui ad ascoltare». L’assenza di un soggetto? Sì, ma quale? Nei testi che avevo letto, di soggetti ce n’erano addirittura troppi, onnipresenti, ingombranti: dal soggetto femminile di Precari, che si rivolgeva alla propria madre e che sembrava saperne molto di poesia e di letteratura; da quelli di Sala d’attesa, tra cui l’eterno paziente in attesa di guarire o di morire, ricercatore compulsivo di descrizioni di malattie su internet, destinato in ogni caso a restare malato; a Giovanna, nel testo intitolato Workout (in Dispositivi), vittima della fatalità di “una tonnellata secca sul cranio”. Se si doveva parlare di assenza, dunque, in tutte queste storie di dolore, ciò che mi colpiva di più era, semmai, la loro mancanza di pathos, la loro lucida, oggettiva, a tratti grottesca, rappresentazione: come se l’io parlante non fosse il soggetto attivo della locuzione, bensì un soggetto parlato attraverso la messa a punto di vari dispositivi testuali. Un soggetto in ascolto, ma, forse, non qui, non del tutto coincidente col contenuto dell’enunciazione. L’effetto che ne derivava era la percezione di una frattura talmente netta tra corpi e linguaggio, da impedire, come ha notato acutamente Beatrice Magoga[1], «di far aderire la propria voce di lettore all’evento», introducendo «uno scarto, rispetto al testo, tale da indurre a un’osservazione critica del fenomeno». Simile intuizione era confermata immediatamente dai due testi successivi: GP(T)-3 e Poesia ASMR: il primo costruito attraverso la successione di tre “esercizi” eseguiti dall’omonimo programma di intelligenza artificiale e il secondo attraverso l’introduzione dell’altro tema portante di tutto il libro, ossia la riflessione sulla scrittura poetica.
Accanto infatti alle “serie ospedaliere” (Gite ospedaliere e Histoire d’H) oppure all’Intermezzo di Suite depressiva, si susseguono altre sezioni in cui l’attenzione dell’autrice si rivolge in misura determinante alla natura del linguaggio poetico (come in Inattualissime, testi costruiti a partire dall’«ascolto casuale in situazioni di vita sociale») e allo statuto della poesia, inteso sia come fenomeno editoriale (si veda Blurb, in Libri (anche poesie), serie di citazioni tratte dagli slogan promozionali in uso nel mercato librario), sia in riferimento al suo valore intrinseco, sentito però in modo sempre più precario o problematico («non ci credo più alla poesia se non faccio i versi sul dolore del mondo questo angusto atomo di dolore catafratto», p. 97), eppure ostinatamente affermato, fino all’esasperazione (e basta!), nell’unica poesia (poesia e basta) dell’ultima sezione, Appendice, definita «giochino di annegamento della poesia / nei bei versi del gran mare di niente» (p. 183) e costruita attraverso una lunga enumerazione il cui principio compositivo viene dichiarato, riflessivamente, all’interno del testo stesso: «Poesie lista, cataloghi, elenchi (come questa)» (p. 184).
Questo divorzio tra la vita organico-psichica e il linguaggio approfondisce ulteriormente quella frattura di cui si è detto tra vita reale e testo. In questa distinzione tra vitalità e dimensione linguistica, si spezza il rapporto di coappartenenza dei due piani l’uno con l’altro (garanzia del senso dell’esperienza e del suo godimento) per istituire invece un nuovo rapporto esclusivamente univoco: il linguaggio riflette l’esperienza senza rinviare a quest’ultima la sua immagine, la sua rappresentazione. Dimensione sadica del linguaggio che enuncia ciò che accade in una forma opaca, amorfa e, paradossalmente, indifferenziata, sempre narcisisticamente frustrata. Nel turbinare delle voci che si accavallano, si scambiano le parti, in una parola, nella fredda ilarità dell’enunciazione, i corpi precipitano nell’astenia, nell’orrore del cibo, sono abitati dalla depressione, che non è solo «un diritto / che ti conquistavi con la sfiga materiale» quando «non ti alzavi dal letto» (p. 75), ma una condizione permanente e pervasiva. Il loro luogo emblematico diventa, di conseguenza, l’ospedale, dove si assiste a una continua messa in scena pornografica della malattia: dalle immagini grottesche dei corpi esposti allo sguardo («Te spogliano, te tolgono le scarpe, manco ar bagno te fanno anda’», p. 63), o nutriti a forza («Possiamo per cortesia interrompere? Forza ingoi», p. 155), fino alla loro equiparazione a cose morte («Pazienti, a letto, come pennarelli nelle bustine: se non li estrai stanno», p. 62). Indicativa della studiatissima articolazione del libro è la sezione Bravure, posta, non a caso, in posizione centrale: cinque virtuosistiche prose che effettuano una ricognizione di ognuno dei cinque sensi nel loro rapporto col mondo. La disforia della percezione («non ti ho capito ripeti devi ripetere non ho sentito», p. 91; «pensavamo a cosa mangiare ma non c’era niente», p. 93; «nei nostri rifugi sporchi che puzzano», p. 96; «Sono belle le case di chi non abita le case di lusso», p. 99) si scontra (si distingue) con l’euforia pettegola, onnipervasiva e sintatticamente sregolata del linguaggio; come nell’ultima prosa in cui il titolo Con-Tatto culmina in un incidente mortale: «sfortunato è stato molto sfortunato contro un palo andava piano era uno scooter proprio sfortuna» (p. 102).
La vera malattia, dunque, quella da cui non si guarisce, che rende il malato inguaribile, che non è più solo «il passatempo dei sani» (p. 148), non consiste tanto nell’affezione di un corpo (come spiegare altrimenti i fenomeni depressivi?) o nelle cosiddette “passioni dell’animo”, ma nel suo rapporto col linguaggio. Ne deriva che, per andare alla radice della malattia, bisogna andare prima di tutto alla radice del linguaggio. Non tanto per curare (il passatempo dei sani non sembra essere tra le priorità del libro), quanto per capire: e solo la letteratura (e in particolare la poesia) è in grado di sondare la frontiera sempre mutevole tra corpo e parola. Se in un’estetica che, per semplicità, potremmo definire tradizionale o classicista, la coincidenza tra veste linguistica e suo contenuto definiva il carattere del “poetico”, La distinzione sposta, distingue, divarica ancora di più di quanto già non accadesse, questi due termini. La poeticità, che siamo ancora abituati a considerare intrinseca a un testo, nonché l’unica prospettiva da cui dipende il suo valore artistico, diventa ubiqua: il linguaggio, sottraendosi alla rappresentazione del senso di un fenomeno (alla sua dimensione spirituale, per usare i termini dell’idealismo) e non rinviando più che a se stesso, resta prigioniero della contraddizione tra il proprio silenzio, tra la propria separatezza e autonomia e la propria in-distinzione, il proprio restare comunque sulla bocca di tutti. Paradosso che rimanda a quanto già notato da Platone nel Fedro a proposito della scrittura, e che il filosofo Jacques Rancière ha individuato come l’elemento più proprio, ma contraddittorio e inafferrabile, della letteratura moderna; elemento che, tra l’altro, va di pari passo col «principio stesso di un ordine politico, quello della democrazia» (Rancière, La parole muette, p. 85).
A questo punto torniamo brevemente alla terza sezione del libro, intitolata Dispositivi. Una nota dell’autrice a conclusione del volume ci spiega che SwiftKey, il testo su cui si era arrestata la mia prima lettura, «è un esempio di scrittura automatica personalizzata che prende il nome dalla tastiera virtuale per Android e iOS». Di GP(T)-3 abbiamo già detto, ma vale la pena aggiungere (traendolo sempre dalla nota) che «al momento il GPT-3 scrive le poesie che scriverebbe un bambino di undici anni». Ma si può individuare una prossimità anche tra quest’ultima sezione, così ben caratterizzata a livello tecnico-sperimentale, e le altre che compongono il libro. Vi è infatti, tra i testi in cui il poeta cede in parte o interamente la propria autonomia e gli altri, una sorta di affinità di base a livello compositivo. Il modo di procedere di un sistema informatico, dopotutto, funziona per ricerca, prelievo di dati e loro disposizione secondo logiche che possono essere di volta in volta predeterminate. Molti dei testi de La distinzione (pensiamo alle sezioni Inattualissime, Libri (anche poesie), così come al montaggio in forma di elenco dell’ultima poesia (poesia e basta), si caratterizzano per un uso spiccato del montaggio di materiali eterogenei, in molti casi prelevati di peso dalla realtà e ospitati sulla pagina. Da ciò, appunto, quella dizione straniata, artificiale, quella voce doppia o “distinta” di cui si parlava: oralità spettrale, come il suono di una nota passata al sintetizzatore, più che recupero di un’originaria vitalità organica dell’orale. Il ricorso a tali tecniche, che a qualcuno potrebbe apparire gratuito o nient’affatto poetico, in realtà non è privo di legittimità, poiché permette di ipotizzare un ulteriore (auspicabile?) sviluppo a cui la scrittura poetica contemporanea sembra essere destinata, per una sorta di fatale attrazione derivante dalla propria natura, ossia dal progressivo allargamento di quella “distinzione” che abbiamo visto operante nel libro di Gilda Policastro.
Quando la macchina, i dispositivi si saranno sostituiti al soggetto poetico umano, sempre più sofferente per la mancata corrispondenza tra il linguaggio e la propria sensibilità, non si sarà in fondo realizzato definitivamente quel processo di liberazione del linguaggio dall’uomo e dell’uomo dal linguaggio che solo ora può apparirci, nella sua piena luce, come il compimento necessario di tutta la letteratura moderna? Letteratura che, fin dalle origini, testimoniava, nella tragica sorte dei suoi primi “martiri” (dalle ultime, imbambolate, poesie di Hölderlin, alle imprecazioni afasiche di Baudelaire sul letto di morte, allo spasmo di glottide di Mallarmé, al silenzio di Rimbaud) questa vocazione al progressivo ammutolire dell’umano. E allora, forse, non ci sarà davvero più nessuno ad ascoltare.
[1]Si veda la tesi di laurea (inedita) di B. Magoga, La poesia, la performatività e l’evento. Un’ipotesi teorico-critica sulla poesia italiana degli ultimi anni, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, p. 79.

