Demone custode – Paolo Sortino
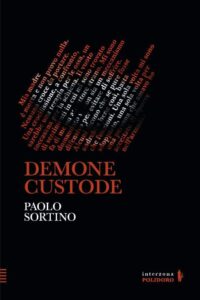
Mia madre è morta e non provo nulla. Nessuna croce da portare. Una crocifissione, a confronto, sarebbe una terapia per le ossa, un toccasana per la schiena. Il vuoto di sentimenti in cui mi sono trovato fa di me un attrattore strano. Mi sono domandato se non sia un meccanismo difensivo per evitare di soffrire. Alcuni dicono che se pure fosse andrebbe bene così, basta che funzioni. Una sola volta mi sono sdoppiato, una sola volta per una persona che amavo ho accettato di riporre nell’armadio il vero me pensando di poter vivere nel feticcio creato per piacerle, e mi è basta- to. Per andarmi a riprendere l’anima ho rischiato di non tornare indietro e ci sono voluti quattro anni di psicoterapia. Non vorrei mai riaccadesse. Neppure mia madre che ho adorato e a cui devo la vita merita tanto. Mettiti in un angolo e piangi, mi ha detto un amico. Non riesco. C’è la possibilità che la morte non sia un problema, che io debba elaborare un bel nulla.
Non che la morte non esista. Esiste eccome. Solo non mi riesce di porla in fondo alla vita. La morte arriva e dispone. Fatti, persone, sensazioni trovano un nuovo ordine. Si accumulano sul mio dorso prendendo la forma delle ali della farfalla ma non volo e non dispero. Non reagisco, non proietto, non reprimo, non ri- muovo, non regredisco. I meccanismi difensivi dell’io si attivano quando si crede che la vita sia come appare, e io non lo credo già da tempo, forse non l’ho mai creduto. Che io stia sublimando lo escludo. Se guardo il bambino che sono stato vedo una piccola anima che deliberatamente manipolava ogni cosa con dovizia di particolari, ma per andare incontro alla sofferenza, per accoglierla, e carezzarla. Almeno che non esista una sublimazione talmente grande da non vederla, che inglobi me con tutto ciò da cui discendo e ciò a cui do vita, allora questa che faccio è una sublimazione universale.
Del resto, ogni autobiografia è immaginaria. I fatti dell’infanzia non furono mai. Sono immagini proiettate su uno schermo deformato. L’alcolizzato che osserva attraverso il bicchiere non vede in modo più confuso. Il passato, il futuro sono distorti, tirati da una curvatura di sabbia fusa. Siamo stati qualcosa, poi un’altra, oggi qualcos’altro ancora.
Questo vuoto non è esattamente una novità, quanto l’ultima determinazione del demone che ho scelto nell’età più tenera. Sta rispettando i patti, sta esaudendo le mie preghiere. Mi mostra ciò che ho desiderato vedere, il dolore e la sofferenza che da piccolo mi sembravano troppo sensati per non credere fossero lo scrigno della verità, così chiesi al mio demone di renderli accessibili; la solitudine delle cose che si trasferiva in me solo osservandole; il senso di oppressione che mi dava l’asilo, con quegli oblò alle porte da farlo sembrare un ospedale pediatrico, quegli alberi posticci di carta ritagliata e colorata coi pastelli, affissi alle pareti; il vuoto dei corridoi e il freddo che produceva e andava incontro a quello esterno, schiacciandosi contro gli infissi chiusi come se la colla residua degli addobbi di Natale sui vetri non fosse in realtà la sua bava; la piccola moschea traforata di luce nella quale si trasformavano i finestroni in fondo alla stanza dei lettini, tirate giù le tapparelle, quando nell’ora del sonno richiamavo alla mente il carillon di casa, la figurina femminile in ceramica con una lunga gonna spiovente, un cestino di fiori intorno al braccio e un morbido cappellino a falde larghe, interamente grigia, perché una polvere antica le si era posata sopra e ciononostante danzava, girando su se stessa sorridente.
Udivo una musichetta provenire dai giocattoli, dai palazzi, dalle strade. Una piccola sonata straziante. Mi commuoveva la decadenza dei quartieri. Uno struggimento mi prendeva per il mondo adulto che tradiva calcoli fatti male, misure sbagliate, grossolanità ingiustificate come la bretella della cartella che restava sollevata quando sedevo, troppo ampia anche accorciando del tutto il laccio attraverso la fibbia e troppo rigida per le spalle di un bambino. Cucciolo di Saturno, di indole atrabiliare, pativo i giorni uggiosi preoccupato potessero infittire il cappotto di lana di mia madre, i suoi foulard profumati che non c’entravano nulla con lo smog del traffico che però mi piaceva inalare, così simili le emissioni di certi diesel ai cracker al rosmarino, come non c’entravano nulla l’azoto della pioggia la mattina presto e le canzoni che per anni avremmo cantato in auto lungo il tragitto per andare a scuola. Non capivo perché gli adulti avessero impostato la vita con regole che non convenivano a nessuno. Per quale motivo io e mia madre dovessimo separarci ogni giorno. In tutto vedevo un po’ di afflizione che conferiva a ogni bordo un’aura fioca di luce. Non avrei mai rinunciato alla pena che sentivo per tutto ciò che avevo intorno, al punto che arrivai a temere il rischio contrario, di potermi svegliare una mattina e trovare il mondo brillante, tirato a lucido, senza traccia di dolore, con le strade ripulite dalla sofferenza. Così corressi il tiro. Chiesi al demo- ne di rendere accessibile me, di fare entrare in me la sofferenza. Usarmi come riparo.
Nel mare dei giochi, la sofferenza era un faro per le mie barche in miniatura. Ognuna presto o tardi si inabissava nella tempesta delle emozioni ma con un tale struggicuore che sono stato vittima di un fraintendimento che ha segnato tutta la vita successiva. Quando si è molto amati a quell’età, è dolce tutto. Si cresce pensando davvero di poter apprezzare la sofferenza, di averne già intuito il senso e non è escluso che sia il migliore dei fraintendimenti, visto che a tutti ce ne tocca uno. Toglierci le illusioni si può, e passeremo tutta la vita adulta a farlo, ma il senso del vero con cui tentiamo di farle cadere è determinato da quel fraintendimento centrale che abbracciamo da piccolissimi. Un senso del vero che invero non è. Una matrice irremovibile che istruisce i gesti e i sentimenti futuri. In quel poco tempo stabiliamo tutto ciò che ci riguarda. Ci facciamo promesse che rispetteremo. Apriamo strade ai pensieri che poi i pensieri percorreranno.
Volevo che i prati di ortiche fossero teneri come cotone incolto, che lo fossero per tutte le persone sulla terra, e solo se gli altri avessero voluto che le spine pungessero, che pungessero per forza questo mi pareva fosse il desiderio degli adulti che osservavo fuori casa che allora fossero carezze per le caviglie per me soltanto. Se per riceverle devo accettare la solitudine, dissi al demone con solennità, sta bene. E se la solitudine sarà effettivamente troppa da sopportare troverò il modo di reggere la catastrofe conseguente alla scoperta, in un momento imprecisato nel futuro, di stare costruendo illusioni. Le illusioni di cui parlavano gli adulti che dal mio punto di vista vivevano nel futuro. Da lì mi parlavano. Li avrei raggiunti, un giorno, senza dimenticare le mie promesse solenni. Ma il futuro non faceva che espandersi, separandomi di più ogni giorno dai miei genitori.
Ho chiesto che il demone mi desse il potere di sublimare, all’occorrenza, qualsiasi cosa, perché nel giro lungo che si fa per distorcere e adattare la realtà la mente scorge un paesaggio, una possibilità, una verità alternativa. Un controsenso, dicono; un non senso questa verità parallela, ma è così che il sarto conosce il tessuto, mi spiegò mia madre, tagliandolo e cucendolo, o il traduttore il testo originale, tradendolo in ogni parola. Promisi di nutrire la mia verità con tale speranza che quanto c’è di ipotetico in un’illusione si sarebbe piegato a diventare una traiettoria, il disegno di un punto di fuga verso cui la mia corsa sarebbe stata così ostinata da farlo crollare nella realtà.
Volevo che il senso della mia vita fosse trovare il senso di ogni spina. Volevo dedicare la vita. Volevo dal mio demone la possibilità di osservare le storture della vita senza per questo perdere la mia strada. Più di qualsiasi altra cosa ho desiderato che a cantare fosse l’uomo muto, che i diseredati di ogni specie potessero unirsi al coro del grande lamento dell’esistenza.
Paolo Sortino (1982) ha pubblicato i romanzi Elisabeth (Einaudi) e Liberal (il Saggiatore), e i racconti Il casco verde (Minimum Fax) e Londra sfoderata («Granta», a cura di Walter Siti, Rizzoli). È stato per diversi anni redattore e autore testi del programma televisivo «Chi l’ha visto?». Collabora con le pagine culturali di Il Giornale.
I commenti a questo post sono chiusi


Buongiorno, personalmente trovo l’incipit clonato, spero volutamente, da Camus. Il mio commento potrebbe definirsi “dall’assurdo all’assoluto”. Non trovo nulla di Dostoevskij in questo demone, né la profondità di abisso che un demone comporta. Nella mia esperienza di donna e di artista (una volta detestavo questa parola, ma purtroppo lo sono), nei miei scritti, nei miei quadri, mi sono sempre fatta ispirare da un amore che allora non sapevo coincidere con la mia totale innocenza, e non come dice Ivan nei Karamazov, universale e attivo, che disdegna il singolo. Un tempo amavo sì, ogni singolo individuo nella sua unicità. Ora no. Ho conosciuto non il male, ma il Male.
Ho sperimentato la tortura fisica e mentale. La tortura non è umanamente descrivibile, non esistono parole.
E un pensiero va a Giulio, immediatamente.
Forse la morte è meglio. Ma spero che il cielo, e non solo il cielo, mi lascino ancora qualche anno di vita. Che altro? Il mio diktat è il dettato di Dante, che ho amato fin troppo ” Amor quand’ei ditta dentro, i’ vo’ significando”. Più o meno dice così!