Apologia di Maurizio Blondet
di Cesare Cherchi
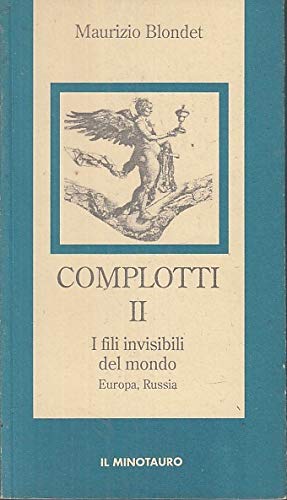
Cos’è un complotto? Come si distingue tra complotto e Storia? Negli ultimi anni, con l’avanzare del fronte della crisi epistemica le domande han ricevute molte risposte, tutte egualmente deludenti. E se il problema fosse proprio la ricerca di un criterio di demarcazione? Il filosofo Cesare Cherchi propone un cambio di prospettiva: il problema del complotto non si risolve con una definizione – in realtà solo propedeutica all’eradicazione –, bensì riconoscendo l’impotenza di ogni progetto di igiene del dibattito pubblico. E nel farlo sceglie volutamente una delle “scottature” più indifendibili: l’opera di Maurizio Blondet.
Apologia di Maurizio Blondet
Fino a non troppo tempo fa “complotto” era una parola come altre, si sarebbe potuto usare “macchinazione,” “intrigo” e ottenere un effetto pressoché identico, da qualche decina d’anni tuttavia non è così. Un complotto (con accessorie storpiature gutturali che hanno avuto una certa fortuna tra il 2010 e il 2020; “gomblotto,” “comblotto” et similia [Cosa significa gomblotto?]) è sì una cospirazione, ma una cospirazione falsa. Non solo, l’estensione semantica della parola sembra essersi spostata dalla realtà al mondo delle idee. Dicendo che qualcosa è un “complotto” non evochiamo una serie di fatti, veri o falsi che siano, quanto piuttosto l’attitudine di chi vi crede; il complotto è una perversione che ammorba la mente di qualche debole, dire che qualcuno crede a un complotto – o meglio “ai complotti” come una sorta di unica costellazione – tipicamente dice poco del complotto in questione e molto di quel qualcuno. Ma non è stato sempre così.
Negli anni ‘80 Umberto Eco parlava di complotti con un interesse che non era totalmente semiotico e che richiedeva ancora delle analisi materiali – che invece sarebbero state superflue parlando di terra piatta decenni dopo nella “Storia delle terre e dei luoghi leggendari” (Bompiani 2013). E ancora, negli anni ‘90 Carlo Ginzburg, nell’introduzione de “Il giudice e lo storico” (Einaudi 1991, ed. Quodlibet 2020) si chiedeva quando fosse legittimo nel ricostruire il passato ricorrere a un complotto. Oggi la discussione non potrebbe aver luogo, perlomeno non utilizzando la stessa parola, un complotto vero suonerebbe con un che di paradossale.
Tutto questo pensavo mentre avevo davanti, in una libreria dell’usato, i tre volumi di “Complotti” di Maurizio Blondet (Il Minotauro, 1996, 1996, 1997). A che punto della parabola usciva questo libro, quanto paradossale o ironico doveva apparirne il titolo? Domande delle quali, per ragioni anagrafiche, non mi era chiara la risposta. Ancora nell’immediato dopo guerra, si parlava di “Complotto dei Medici” senza secondi significati, qualche anno fa – nel pieno del isteria di Qanon – usciva invece “Complotti!” di Leonardo Bianchi (minimum fax, 2021), una compilazione sociologico-dileggiatoria delle teorie del complotto più strampalate.
In particolare mi era di grande interesse l’autore, Maurizio Blondet. Di lui era molto noto – si direbbe cult, se la parola non avesse perduto di significato – presso i bibliofili italiani “Gli Adelphi della dissoluzione” (Ares, 1994) che suggeriva piani luciferini dietro il programma editoriale delle edizioni Adelphi. Un mio amico mi aveva persino raccontato di aver cenato ad una tavola con Blondet una volta, questi gli avrebbe rivelato che l’induismo non esisteva, ed era una creazione escogitata per contrastare il cristianesimo.
Complotti I
Le mie intenzioni erano crudeli e ingenue; non mi aspettavo nulla di preciso, ma ho acquistato immediatamente tutti e tre i volumi con una certa attitudine sardonica, che si compiace nel trovare gusto nelle cose più false e lontane. Le aspettative venivano in qualche modo confermate dalla copertina del primo volume. “Complotti. I fili invisibili del mondo. I – Stati Uniti, Gran Bretagna” su cui capeggia un ragno che tesse la sua tela. Tuttavia già la seconda di copertina mi sorprende:
“Può la complottistica assurgere a dignità scientifica? Può diventare una disciplina congetturale, superando la barriera della pura fantasia o della dietrologia?”
Le promesse di una trattazione scientifica sono curiose, soprattutto perché paiono in contraddizione con la quarta: “Il lato oscuro della storia contemporanea, un mosaico di misteri che nessuno ha mai analizzato,” che non lascia intravedere slanci teoretici. Ad ogni modo dalle prime pagine si intuisce abbastanza rapidamente che la seconda, con tutta probabilità apocrifa, verrà disattesa. Dopo una brevissima definizione di complotto (“ciò che chiamiamo “Complotto” faute de mieux, prendendo a prestito l’espressione usata per screditare il fenomeno che scandagliamo è, prima che un “Progetto” – una “Cultura”, una visione del mondo. Che si è formata negli ultimi tre secoli, s’è nutrita di filosofie oligarchiche e messianismi iniziatici” p. 8) libro si apre con una suggestiva descrizione del viaggio del Battello Britannia in Italia nel 1992, quando nei primi giorni di Giugno i maggiori depositari del potere amministrativo ed economico italiano salirono a bordo apparentemente per rendere omaggio alla Regina, in realtà per essere introdotti nei precetti di una non meglio specificata dottrina. La pagina dopo – con un colpo di scena a cui Blondet nel corso dell’opera ci abituerà – inizia con il racconto, storicamente più che accettabile, della dismissione dei manicomi. Viene alla mente l’incipit della “Storia della Follia nell’età classica” in cui Foucault raccontava la dismissione dei grandi lazzaretti francesi per farne, appunto, dei manicomi. Nella ripresa di Blondet non ci si concentra però sugli edifici ma sulla vita libera dei ricoverati. Qualcuno di ingenuo potrebbe pensare che fosse stato un gesto umanitario – naturale conseguenza di migliori pratiche psichiatriche – al massimo ben propiziato dal relativo risparmio economico. Invece subito la tela blondetiana si tesse, individua una genealogia di biologi abolizionisti-eugenetisti; la dimissione dalla sicurezza degli istituti di cura è propedeutica allo sterminio dei più deboli. Non è ben chiaro come, ma la tecnica di Blondet deve molto alla confusione. I fatti che riporta sono quasi sempre veri, e se sono falsi sono sicuro siano errori fatti in buona fede. Dunque non si può dire faccia disinformazione. Piuttosto, una volta presentati, i fatti vengono raggruppati artificiosamente e accompagnati da commenti oscuri che lasciano sempre presagire qualcosa di ignoto e sinistro.
E a proposito di giustapposizioni; cosa c’entra tutto ciò con il viaggio del Britannia? Qui si introduce uno dei maggiori temi della trilogia: Blondet ha un interesse quasi maniacale per il ruolo nefasto dell’Impero Inglese nella Storia – ma non nel senso che ci potremmo aspettare. In questo caso in particolare Malthus-Darwin-Huxley sono espressione di una rete coloniale animata da una vasto programma di eugenetica implementato attraverso il potere economico britannico. Nondimeno, ancora una volta non è ben chiaro quale siano le mire di questa setta eugenetista, in cui sembrano confluire tutta la moderna genetica e psichiatria.
Questo pare essere una caratteristica ricorrente, forse anche giustificata dall’introduzione metodologica di sorta citata sopra. Vedremo però che questa attitudine non verrà sempre mantenuta e le premesse non sempre attese.
Il complottismo contemporaneo ci ha mal abituato, i soliti complottisti che abbiamo al giorno d’oggi, Stefania Maurizzi o Paolo Barnard per far nomi, seguono una linea frustra. Quello che fanno è una scoria della controinformazione della guerra fredda. I complotti sono tipicamente filo-americani (e per America si intende ogni forza economica e finanziari globale) dunque ci sono trame pittoresche (come il comune di Vicenza che viene consegnato ogni quattro anni al PD da misteriosi armeggi dell’esercito americano), le rivoluzioni colorate, i biolaboratori in Donbass, Putin che combatte i poteri forti. Moncherini di una controcultura filosovietica a cui molti si appoggiano per comodità, come i villici costruivano baracche nelle basiliche romane in rovina durante il basso Medioevo.
Blondet ha invece qualcosa di diverso, non ritroviamo subito i soliti riferimenti; gli americani cattivi e italiani brava gente (una sorta di perversione autoriferita del buon selvaggio). Il complottismo più bieco poi raramente si spinge indietro, Blondet invece si muove continuamente avanti e indietro dall’alto Medioevo fino ai giorni nostri. Il complotto non è un’arma impropria (spesso sovrapposto alla disinformazione) o strumento di quel centro di potere o quell’altro che cerca di vendere “cambiamenti di prospettiva” (intendere dal punto di vista orientale quello che vediamo da un punto di vista europeo o viceversa), è piuttosto un modo nuovo, totale, di intendere la Storia (più simile Zecharia Sitchin che a Giulietto Chiesa).
Nei capitoli successivi l’ampio respiro che Blondet aveva fatto intravedere all’inizio pare però spegnersi e ci perdiamo in interminabili liste di congressi, scienziati e casi di cronaca che collegano il progetto MK-Ultra, Charles Manson, Aleister Crowley, l’LSD e virus dell’HIV (con l’HIV Blondet crea una sorta di caccia al tesoro; dissemina tutti e tre i volumi di sporadiche connessioni di istituzioni o persone alla ricerca sull’HIV con le solite connotazioni sinistre, ma senza mai dire niente al riguardo).
Finalmente però il campo ritorna ad aprirsi e si identifica quello che se non è un nemico è il nemico “il fabianesimo,” un movimento politico che incarna le mire Britanniche e il progetto dell’Ordine Mondiale. Conseguentemente scopriamo – con una certa sorpresa se siamo abituati ai crassi complotti filosovietici che vanno per la maggiore in Italia – che gli americani, in quanto ribelli agli inglesi, sono nella Storia motore del Bene, anzi i neocon raeganiani sono sì il nemico (almeno questo è un topos familiare) ma solo in quanto sovietizzatori dell’originario spirito rivoluzionario americano (p. 56). Il primo volume si chiude così, con un elogio dell’America delle origini:
“Sta infatti giungendo il tempo, temo, di rimpiangere l’America capitalista che ci vinse nella Seconda guerra mondiale. Perché per tre secoli la spinta primordiale dell’America capitalista non è stato l’edonismo […]. No: la sua molla originaria stava in una sovrabbondanza di forze vitali un […] coraggio costruttivo che chi conosce l’America ritrova, non del tutto esaurito, ancor oggi.” (p. 58)
Ma da dove deriva questo ruolo dell’Inghilterra, dal fabianesimo e – incontriamo per la prima volta uno dei punti centrali – dell’israelitismo inglese? Sono tutte domande lasciate in sospeso, con la speranza vengano risposte dal secondo volume.
Complotti II
Complotti I ci aveva lasciato con molte domande e vedendo il secondo volume viene da chiedersi se fosse stato progettato già durante la stesura del primo dato che questo si chiama “Complotti II. I fili invisibili del mondo. Europa Russia.” Il numerale viene spostato dal sottotitolo al titolo. In copertina stavolta compre una riproduzione di “Nemesi” di Dürer. Blondet, da grande narratore, inizia sempre dal particolare.
Addentrandoci nei dettagli della nascita dell’Unione Europea si scopre che il ‘68 è stato ideato e implementato dall’esterno (da forze atlantiche e europeiste) per piegare De Gaulle che all’Unione e al suo sgherro, Jean Monnet, si era da sempre opposto; una cortesia curiosa dal momento che tutti gli altri oppositori (tedeschi) erano stati molto più semplicemente fatti saltare in aria.
Dalla Germania si passa poi alla Russia parlando della quale – a parte alcune considerazioni economiche traballanti, ma meno folli del solito – ci sono passi bellissimi sullo spirito Russo e Stalin, che se fossero scritte in un italiano più stentato non sfigurerebbero tra i lavori dei nostri esperti di “geopolitica.”
Fin’ora c’erano stati suggerimenti a riguardo – vanno considerati tali le strane considerazioni dal tono heideggeriano sul popolo ebraico (“solo due popoli possono ‘generare l’Anticristo,’ la Russia e gli Ebrei, e sono precisamente quelli che possono sconfiggerlo, perché solo chi sa coagulare sa anche solvere.” p. 87), ma nel capitolo XIII arriva il primo grande afflato che sembra essere inequivocabilmente antisemita (vedremo dopo che l’antisemitismo, per Blondet, è una categoria riduttiva). Si fa la storia dell’Unione Sovietica e per ogni evento si cerca un ebreo, il più prominente possibile (Gelfand, Bronstein-Trotskij etc.) e lo si elegge a “vera mente” dentro a ogni nefandezza.
Il X capitolo è centrale per lo sviluppo di tutta la serie ed è oltretutto scritto in una prosa di rara bellezza che val la pena riportare (quasi) per intero:
“Le scoperte geografiche del Cinquecento spostarono i traffici sull’Atlantico; nel Mediterraneo divenuto un lago, solo Venezia si resse per secoli in un fastoso tramonto, che fu una squisita, lunghissima corruzione. Mentre le navi portoghesi, spagnole e britanniche conquistavano imperi del Nuovo Mondo, il Leone di San Marco sventolava nell’esiguo spazio dell’Adriatico le cui vele – incapaci di andar a bolina – dovevano ancora, come ai tempi di Roma, chiedere aiuto ai remi. Sappiamo che un’oligarchia chiusa e intrigante regnava su quell’arretratezza e su quello splendore.”
“Ma ignoriamo che quell’oligarchia poté essere definita un “impero invisibile”: un modello in cui personaggi senza volto, nella City o a Wall Street hanno identificato il prototipo di ogni potere elitario e segreto che pretenda di dominare il mondo con leve invisibili. […]”
“Dietro e a sostegno delle sue reti commerciali, la Serenissima seppe creare un sistema di informazioni riservate , di influenze politiche e di legami basati sul credito finanziario e sulla conoscenza di quello che avveniva nei luoghi più lontani […].”
“La nostra baluginante conoscenza dei fatti c’indurrebbe a credere che quella rete antica sia da secoli strappata, inoperante. Invece qualche filo di quella rete compare insospettatamente ai giorni nostri. Ci piacerebbe ricostruire, ad esempio, per quali segreti passaggi alcuni membri della famiglia dei Caboti (o Cabotti), passati nei secoli dall’Inghilterra alla Nuova Inghilterra e stabilitisi a Boston, abbiano dato origine a una dinastia dell’Establishment americano più chiuso e più stretto: i Cabot Lodge. […]” (p. 93 e sgg.)
con questi tratti metafisici, quasi sacrali o Borgesiani, Blondet finalmente ci introduce nel cuore della sua ideologia; c’è un unico filone, che scorre sotterraneo come un fiume carsico, per riemergere per i rapidi momenti in cui il nostro riesce ad individuarlo e presentarcelo:
“Per esempio, si può scoprire che nella pietà cristiana che Venezia ostentava nelle sue chiese e conventi, covarono umori gnostici e scismatici di origine orientale. Non sappiamo molto dell’umanista e benedettino Paolo Giustiniani, d’alta famiglia veneziana e amico del nobilissimo Gasparo Contarini, vescovo di Cividade dopo il 1536; tranne che la sua mistica cristiana doveva molto (troppo) ai monaci del Monte Athos, la cui ortodossia negava ferocemente quel passo del credo romano il quale asserisce che lo spirito santo “procede dal padre e dal figlio” (filioque procedit). La negazione del filioque tipica della chiesa greco ortodossa e di quella slava che ha il suo centro a Mosca, se non rinnega, almeno svaluta l’Incarnazione. Come conseguenza, acutizza l’antitesi tra il corpo e lo spirito. Sul piano dell’azione umana, chi nega il filioque tende a vedere il mondo di quaggiù come un’illusione desolata e non come un’occasione di bene; la sua azione sarà guidata da questo pessimismo segreto. Egli non crederà al progresso dell’uomo attingibile attraverso le opere. Il risultato finale sarà una tendenza morbosa all’immobilismo che giungerà fino al rifiuto del progresso tecnico e, in politica, all’idea che il mondo debba essere governato da pochi, scettici saggi. L’oligarchia contro la democrazia. Così fu Venezia. Così fu Bisanzio. Così fu (ed è) Mosca, “Terza Roma”: immobili e arretrate, eppure sottili e colte; dedite alla segretezza e al potere autocratico.
Fin dal basso medioevo, dunque, si accompagna alla fede cristiana una parte eretica che non crede nell’opera dell’uomo sulla terra, ma vede il mondo terreno con indifferenza, una vuota eternità priva di valore.
Coloro che non credono che Cristo sia venuto a redimere la nostra vita terrena, che non si sia mai fatto carne. Chi non crede che Dio si sia fatto uomo crede anche che la vita terrena sia priva di valore, questa accidia ha creato un’ideologia, diffusasi per secoli nelle classi dominanti, secondo cui non può esservi progresso per l’uomo, e l’umanità vada governata come si governa un gregge, mantenendo l’ordine e aspettando la fine dei tempi, se mai ci sarà.
È questo che rende il popolo ebraico un tanto saldo alleato della “nomenklatura.” È un disegno di cui in onestà non posso che ammirare la bellezza letteraria, è tutto quello che Dan Brown avrebbe voluto scrivere se solo avesse avuto l’acutezza di spirito necessaria per farlo.
Le pagine finali regalano alcune rivelazioni. I fondaci veneziani che controllavano le granaglie si son estesi fino ai giorni d’oggi, da Caboti di Venezia ai Cabot di Chicago, attraverso Leopold Luis-Dreyfus (trisavolo di Julia Louis-Dreyfus) impedendo ai cittadini americani di consumare le loro granaglie, tanto che “l’americano medio spese due miliardi di dollari in più nel solo ‘73, come diretta conseguenza degli aiuti all’URSS” (p. 118) dimostrando una capacità di spesa (o un tasso di inflazione) che per l’epoca non avrei sospettato. Nel capitolo finale scopriamo invece che Licio Gelli sarebbe stato coinvolto nell’omicidio di Olof Palme (si direbbe come esecutore, ma come sempre ci sono solo allusioni).
Complotti III
Il terzo libro è forse il più deludente, non ha una struttura integrata con gli altri due, e verrebbe il sospetto che sia stato pubblicato in seguito al successo dei primi due (la mia copia di Complotti I è la sesta edizione nel solo 1996, l’anno di uscita). Scopriamo che il ‘68 come venne creato (vedi Complotti II) così venne spento (sempre da Licio Gelli). A quanto pare dall’analisi dei titoli dell’Economist si leggono fatwe contro Salvo Lima e Aldo Moro, poi regolarmente uccisi (non è chiaro se i titoli servissero a comunicare la volontà omicida ai sicari o a pubblicizzare il mandante). Ci si perde in una serie di teorie apparentemente slegate tra loro, sarà quindi sufficiente fare un riassunto delle più notevoli: la farmacologia ha dimenticato la sacralità della manipolazione della natura ed è diventata una pratica in scivolamento sempre più rapido verso Satana, Tangentopoli fu un’operazione americana per liberarsi dei politici cattolici (ultimo baluardo contro lo gnosticismo orientale). Giorgio Napolitano fu un agente della finanza internazionale per neutralizzare l’anticapitalismo del PCI, così come l’Ulivo. A pagina 75 vengono nominati di passaggio, per la prima e ultima volta, gli Illuminati, senza dare nessuna spiegazione.
Gli ultimi due capitoli, delle considerazioni sulle nuove fascinazioni proto-cristiane dei cattolici (ordinati e non) e un report sul processo della Corte Internazionale dell’Aja a Dusan Tadic (sulla scia di “Heichmann in Jerusalem”) sembrano delle aggiunte posteriori. Il tono sinistro si perde completamente e rimangono solo due pezzi giornalistici, peraltro molto belli, che hanno – incredibilmente – un tono tra il conciliante e l’ottimista. Il mondo quindi non è condannato.
C’è, però, un grande assente in questa storia dei complotti: il Vaticano. Col Vaticano, viste le istituzioni segrete e misteriose, e la longevità e l’ambiguità dei loro fini, i complotti sono naturali se solo si ha la necessaria fantasia. Tuttavia in Blondet la Chiesa Cattolica non viene mai nominata. Questo perché – in uno slancio di fede e di ingenuità che è curioso ritrovare in questo gran maestro delle trame e dei segreti – la Chiesa Cattolica opera la volontà di Dio in Terra, dunque è infallibile agente del Bene, da secoli unico argine allo gnosticismo élitista.
Diceva Nelson Goodman che una fallacia logica è tale solo nella misura in cui ha la medesima forma di un argomento corretto, difatti se non assomigliasse a nessun ragionamento corretto non sarebbe una fallacia ma solo un nonsenso o un errore marchiano. Ma se qualcosa ha la stessa forma di un argomento valido allora è un argomento valido. Dunque le fallacie paiono non esistere.
Per Blondet vale la stessa cosa. Rispondendo all’appello della seconda di copertina del primo libro potremmo usare lo stesso principio per determinare cosa sia un complotto, un complotto è qualcosa che ha la stessa forma di una teoria storica ma non lo è, ma siamo sicuri che si possa avere la forma di un lavoro di Storia senza essere Storia? Che sia falsa e scriteriata non è abbastanza per una teoria per essere un detta complotto. Edward Gibbon e Jacob Burkhardt sono pieni di falsità e romanticismi, ma rimangono storici.
Dobbiamo forse arrenderci al fatto che Blondet sia uno storico tanto quanto Robert Darnton o Jacques Le Goff? Ovviamente no, in Blondet c’è qualcosa di diverso e assurdo. Ma in cosa consiste questa assurdità?
Le connessioni labili e tendenziose tra persone o enti in Complotti non sono peggiori di quelle che tesse ogni settimana Report (in cui, non a caso, lavorava Paolo Barnard). Il controllo dei media da parte delle élites che descrive Blondet è addirittura più plausibile e sfumato di quello che si trova in Manufacturing Consent di Chomsky e Herman. Le letture storiche contorte che si trovano nei libri sono in fondo molto più documentate e ragionevoli delle perversioni storiche e storiografiche della classe giornalistica italiana che troppo spesso arrivano (con inspiegabile successo) in libreria, da Gianpaolo Pansa in giù. Ciò non ostante tra questi l’unico paria complottista rimane Blondet.
Di tutti i peccati di cui si macchia Blondet si sono macchiati beniamini del “ceto medio riflessivo” (per usare un’espressione cara alla politologia italiana) in misura pari e talvolta maggiore, ma li accuseremmo al massimo di essere pessimi storici o pessimi giornalisti, ma non complottisti. Perché?
La spiegazione che mi sono dato è che in loro riconosciamo una parte politica, alla quale siamo pronti a dare ragione o torto; “Per forza gli argomenti di Tizio sono falsi e strampalati, come farebbe altrimenti a sostenere il Male?” “Quello che dice Caio è solo un’approssimazione, ma è nel giusto nel sostenere il Bene!”
Blondet è diverso non perché usi metodi diversi, ma perché non ha nessuno dalla sua parte, se ci fosse un giornale anti-manicheista o anti-càtaro con i suoi lettori forse avrebbe anche lui la sua schiera di sostenitori “moderati” e senza la stagnola in testa, ma questi giornali non esistono, e dunque nemmeno c’è nessuno disposto ad avallare le sue debolezze quanto altri sono pronti ad assecondare quelle di Travaglio, Ranucci o Belpietro.
Blondet non è peggiore di tutti questi, anzi ha una delle prose italiane migliori che abbia letto – specialmente per un giornalista. Blondet però è unico ed è anche da solo; così, disorientato, il lettore finisce per vederne tutte le storture che volentieri ignorava per combattere un nemico.
Dunque, cosa fare? Dobbiamo lasciarci andare in un deliquio scettico? Riconoscere che non esiste la Storia e non esistono i Complotti ma solo delle cose che siamo pronti a riconoscere vere? Non penso che sia necessario, dopotutto abbiano negato che esista una legge di demarcazione tra Storia e Complottistica, ma esistono pur sempre la buona e la cattiva Storia. Piuttosto, ogni volta che scopriremo qualcosa (un articolo, un libro, un post, una pagina Wikipedia) che ci da ragione, basterebbe chiedersi “Che cosa ne penserei se non volessi crederci?” Può sembrare una soluzione deludente, ma dopotutto “Libertà non è altro che l’inventario delle proprie catene.”
Macerata,
Giovedì 23 Gennaio 2025
Cesare Cherchi (Macerata, 1997) insegna alla facoltà di Filosofia dell’Università Carolina di Praga dove sta conseguendo il suo dottorato. Si occupa di logiche doxastiche, metafisica e semantica. Nel tempo che rimane si dedica agli scacchi e a ricerche biblio-teratologiche.

