L’aura non c’è: sulla poesia oggi, in breve (a proposito de Il metaverso di Gilda Policastro)
Di Emanuele Franceschetti
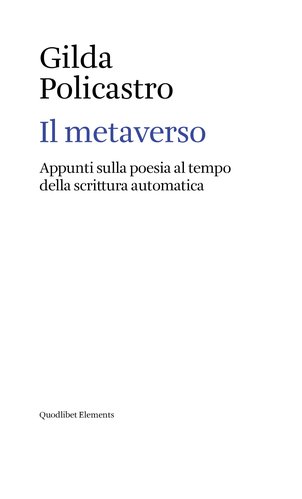 Edito a tre anni di distanza dal più corposo (in termini “progettuali” e dimensionali) L’ultima poesia (Mimesis, Milano-Udine, 2021), Il metaverso (Quodlibet, Macerata, 2024) prosegue l’indagine di Gilda Policastro su fenomeni, tendenze, problemi e discorsi della poesia contemporanea. Il volume, stavolta, è agevole e snello, in linea con la proposta della collana «Elements»: meno di centocinquanta pagine, fattura quasi tascabile, tendenzialmente parco di note a piè di pagina (incubo di saggisti, lettori ed editor) e dotato di una bibliografia finale a dir poco essenziale. Un sogno, insomma, per chiunque abbia vaghezza di immergersi senza eccessivi patemi nelle questioni poetiche odierne. Una sintesi del “senso” del libro – quadripartito, con ciascuna delle sezioni ulteriormente suddivisa in cinque o sei paragrafi – è chiarita nell’abstract finale (p. 141), e non mi sembra pertanto particolarmente meritorio riproporre qui un sunto del testo; né troppo utile può risultare qui apprezzarne lo stile avvertito e brillante, smaliziato e appuntito (ben noto a chi conosca la produzione critico-saggistica dell’autrice). “Utile”, invece, è proprio il testo in questione: al netto del probabile sospetto che l’idea dell’utilità rischia di portarsi dietro (in relazione alla poesia, poi…), vorrei soffermarmi proprio su questa qualità.
Edito a tre anni di distanza dal più corposo (in termini “progettuali” e dimensionali) L’ultima poesia (Mimesis, Milano-Udine, 2021), Il metaverso (Quodlibet, Macerata, 2024) prosegue l’indagine di Gilda Policastro su fenomeni, tendenze, problemi e discorsi della poesia contemporanea. Il volume, stavolta, è agevole e snello, in linea con la proposta della collana «Elements»: meno di centocinquanta pagine, fattura quasi tascabile, tendenzialmente parco di note a piè di pagina (incubo di saggisti, lettori ed editor) e dotato di una bibliografia finale a dir poco essenziale. Un sogno, insomma, per chiunque abbia vaghezza di immergersi senza eccessivi patemi nelle questioni poetiche odierne. Una sintesi del “senso” del libro – quadripartito, con ciascuna delle sezioni ulteriormente suddivisa in cinque o sei paragrafi – è chiarita nell’abstract finale (p. 141), e non mi sembra pertanto particolarmente meritorio riproporre qui un sunto del testo; né troppo utile può risultare qui apprezzarne lo stile avvertito e brillante, smaliziato e appuntito (ben noto a chi conosca la produzione critico-saggistica dell’autrice). “Utile”, invece, è proprio il testo in questione: al netto del probabile sospetto che l’idea dell’utilità rischia di portarsi dietro (in relazione alla poesia, poi…), vorrei soffermarmi proprio su questa qualità.
Può essere un’ammissione dolorosa, ma è anche ovvia e inevitabile: la poesia, oggi, è ancora per molti un’ “estranea cosa” (così Alberto Savinio definiva la musica, all’inizio degli anni Quaranta).[1] Doloroso è anche, per chi scrive qui, rendere oggetto di discussione considerazioni che possono risultare fruste e consunte a chi, invece, la poesia la frequenta e la maneggia quotidianamente, e non nel dopolavoro. È di larghissima circolazione la storiella (diffusa con infinite varianti, come gli aforismi di Jim Morrison) che vedrebbe la maggior parte dei discenti di qualsiasi ordine “non specializzato” (e non è neppure detto che, insomma…) incapace di nominare cinque poeti viventi: è una storiella tutt’altro che fittizia, però, che al di là del gusto per l’aneddoto dovrebbe porre (e porci) qualche problema. Come si può pensare che i nodi teorici, i discorsi ricorrenti e le questioni fondanti dell’universo poetico possano non risultare oscuri se è impossibile, in contesti a dir poco largamente alfabetizzati (Licei, Conservatori, Università) persino nominare qualche poeta vivente?
Non essendo l’eziologia della crisi culturale tra gli obiettivi di queste righe, tornerei subito sul libro di Policastro. L’autrice, che oltre a libri di poesia e romanzi, di lavori accademici (quelli lunghi, con molte note, con le bibliografie infinite) ne ha scritti parecchi, è riuscita a confezionare un testo che può davvero essere “utile” a molti. Ma non l’ha fatto rendendo dozzinale il discorso o banalizzando i punti nevralgici dell’indagine: bensì realizzando una buona sintesi tra vis affabulatoria, mordente narrativo, conoscenza diretta degli strumenti in possesso degli interlocutori circostanti (Policastro insegna in contesti e realtà diversi per orizzonte culturale e prospettive) e capacità di immaginare un itinerario interno accattivante, reso tale anche da una scelta smaliziata, astuta e precisa di argomenti (contesto presente e individui [prima parte]; temi [seconda parte]; forme [terza parte]; personaggi “notevoli” [quarta parte]) e soprattutto titoli (“I poeti sono vivi?”; “Canone, no grazie”; “Meno amore, più morte”; “Poesia tra le stelle”; “L’endecasillabo è morto”; “De Angelis e Insana: fine pena mai”, ecc.).
Policastro sa bene che, ancor prima di perimetrare lirica e ricerca, non-assertività e “espressivismo”, e occuparsi di installazioni, intermedialità, AI e pratiche performative, il vero problema (culturale ancor prima che strettamente poetico) potrebbe essere ancora discutere la sopravvivenza – e le condizioni e modalità di sopravvivenza – di un intero “genere”, senza dare nulla per scontato. Bisogna ancora chiederci (e spiegare) cos’è la poesia oggi, se esiste, come riconoscerla dai suoi falsi surrogati, chi è che la fa e che modelli adotta, dove si trova (la poesia, ma anche chi la fa), cosa può fare (la poesia) e cosa ha smesso di fare (e forse non ha mai fatto), che rapporti ha con le emozioni e con i fatti propri (tasto dolentissimo) e con la realtà e la storia, con le canzoni e con la lingua con cui parliamo tutti i giorni. Utilizzare Il metaverso e proporlo anche come strumento didattico-divulgativo, insomma, potrebbe facilitare in tal senso l’impresa, contribuendo forse a ridurre – anche per i lettori meno avvezzi e avvertiti al genere – il senso di estraneità che la scrittura in versi, per non dire di quella non in versi (ma sempre poetica) continua a portarsi dietro.
Policastro sa anche bene che l’aura, la poesia, l’ha persa da un bel po’: e che – rubo un’espressione che Fortini rivolgeva a Pasolini[2] – conviene far pace con l’idea che non ci sono più i Poeti (con la “p” grande), ma solo individui che scrivono poesie che vanno sottoposte, sempre fortinianamente, a necessaria verifica. Il difficile, mi sembra, è spiegare alla gente che la poesia può aver perso l’aura ma non ha smesso di essere uno dei modi più interessanti di mettere “in forma” e “in lingua” le cose, il mondo, la storia, gli altri: e che quindi continua a farlo anche oggi, seppur in forme e in modi molto diversi da ciò che potrebbe immaginare chi è fuori dalla bolla.
Con buona pace della «provocazione-profezia»[3] di Edoardo Sanguineti sul presunto «diluvio» dopo la stagione della neo-avanguardia, di poesia buona e valida se n’è fatta e se ne continua fare ancora molta. Ciò che però mi sembra fuori discussione (o sarebbe bene che lo fosse), e di cui Policastro si fa da sempre interprete, anche ed efficacemente nel Metaverso, è la necessità di “odiarla” un po’, questa poesia (per riprendere l’espressione di un fortunato e intelligente libro recente di Ben Lerner).[4] E cioè metterla in discussione, e magari alla berlina; storicizzarla e toglierla via dal museo e dal negozio d’antiquariato; strappare quelle venute male, se necessario; provare a dirla «con la bocca» (per usare un’espressione di Umberto Fiori),[5] o magari anche a metterla in musica (questo invece lo suggeriva Pound).[6] Decostruirla, prenderla a scossoni, parlarne anche fuori dalla bolla, raccontare in quanti modi diversi si può scrivere. Oltre che a far fuori l’aura, questo potrebbe essere utile a fare a meno del semplicistico poesia-non poesia di crociana memoria, nonché a familiarizzare ulteriormente con la complessità: della poesia e del reale.
______________________
[1] Alberto Savinio, Musica estranea cosa, «Parallelo», I/2, 1943, pp. 68-70.
[2] Cfr. Franco Fortini, Attraverso Pasolini, a cura di Vittorio Celotto e Bernardo De Luca, Quodlibet, Macerata, pp. 12-13.
[3] Così la definisce la stessa Policastro nella bandella de L’Ultima poesia.
[4] Ben Lerner, Odiare la poesia, Sellerio, Palermo, 2017.
[5] Umberto Fiori, Poeti con e senza bocca, in Scrivere con la voce. Canzone, Rock e Poesia, Unicopli, Milano, pp. 131-140.
[6] Ezra Pound, L’ABC del leggere, Garzanti, Milano, 2012, p. 57.

