Pietà
di Ilaria Palomba
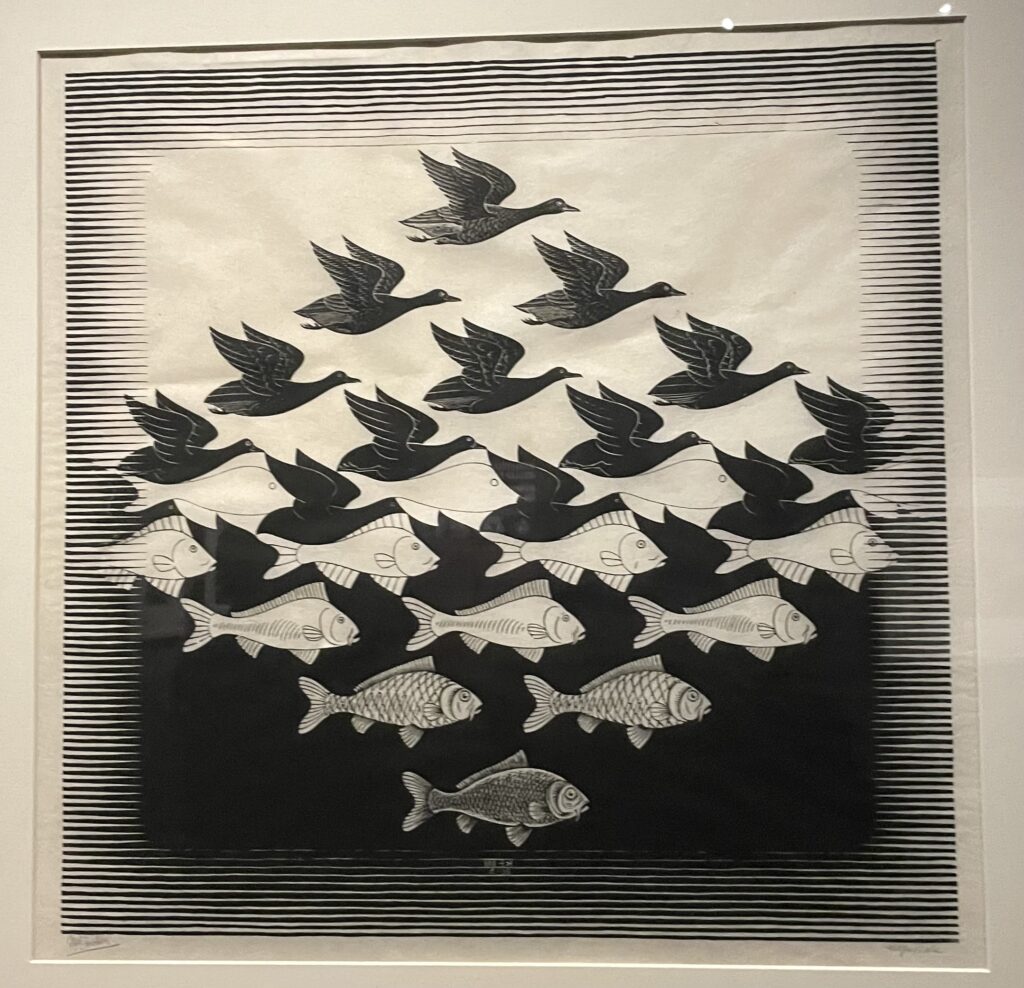
Nel violento, trafelato alternarsi di stati d’animo, cercando rifugio nelle Suite di Bach, telefona O. Quando le chiedo come stai, ride, giustamente. Dice che ha cambiato badante, che trascorre quasi tutto il tempo a letto, che la nuova l’accompagna solo quattro ore al giorno, che la presenza dei suoi per quanto salvifica è in fin dei conti snervante, che il suo amore virtuale prosegue, anche se nessuno dei due fa un passo per renderlo reale. O. ha trovato un soffio vitale anche nell’impossibilità di muoversi, nella piccola scoperta delle sensazioni recuperate. Truccarsi al mattino per mandare una fotografia all’uomo con cui la sentivo parlare ogni giorno in ospedale, curare l’alimentazione fin nei minimi dettagli per mantenere il corpo esile, fare il botox per ringiovanire. Piccole cose, dice, che ti danno la misura del senso di esserci ancora.
Sto cercando anch’io quel senso, dico.
Ma tu cammini, dice.
Lo so, scusami.
No, non devi scusarti.
Sì, invece.
C’è qualcosa su cui dovresti riflettere.
Cosa?
Sei certa di aver deciso consciamente?
Non saprei, ero stanca.
Sì, ma di cosa?
Non lo so, mi vergogno molto. Un paio di volte, sotto acido, molto prima dell’incidente, ho visto il mio corpo cadere dall’alto, poi in coma.
Non chiamarlo incidente.
Come dovrei chiamarlo?
Suicidio.
Tentativo di suicidio.
Non era un tentativo.
In che senso?
In rianimazione ne hai avuto un assaggio.
Ma era delirio, avevo un trauma cranico, ero sotto morfina.
Cosa sentivi?
La voce di un uomo.
E cosa diceva?
Che dovevo rinunciare al mio nome, o la vita o il mio nome, che questo era solo un passaggio, solo una delle quindicimila vite che mi spettavano, e che se l’avessi sprecata la successiva sarebbe stata identica.
Hai vissuto una breve incursione nello spirito, ma poi l’hai dimenticato. Hai compreso il significato della richiesta della voce? A cosa devi in realtà rinunciare?
Non lo so, all’ego forse, all’identità.
Dopo aver riattaccato mi torna quell’antico senso d’angoscia che in alcuni momenti accompagna le mie giornate. La porta è chiusa a chiave, sento le voci dei miei, che ormai tento in ogni modo di arginare. Ho perfino paura di attraversare il corridoio e raggiungere il bagno.
Cammino su via Appia il primo di novembre, con mia madre, scegliamo le verdure dal fruttivendolo, cercando di capire cosa mangiare e cosa no. Lascio a lei l’arbitrio dei gesti, come se per un anno e mezzo fossi stata assente. Cerco di osservarla con benevolenza, o almeno mi sforzo di farlo. Ci dividiamo le buste, prendo spinaci e kiwi, lei fagiolini, tocchetti di carote e zucchine. Poi entriamo in un negozio in cui eravamo state un anno fa, la negoziante non mi riconosce. Ero appena uscita dall’unità spinale, avevo il deambulatore, mi stancavo dopo pochi passi, sudavo e mi dolevano le ossa del bacino. Avevo capelli radi, incarnato terreo, corporatura lasca e gonfia per i farmaci. Ora sono un’altra, e mi felicita sapere non mi abbiano ricondotta a quell’essere amorfo che entrò un anno fa con il rollator e subito si abbandonò inerme sui cuscini all’ingresso. Scelgo delle magliette nere a righe, una traforata e una blu, la commessa mi indica un camerino. Dal camerino sento mia madre dire alla commessa: Si ricorda? L’anno scorso. È la prima volta che torna in un negozio da allora. Povera figlia. No, perché?, dice l’altra. Ho visto che porta un tutore, ha avuto un incidente? Mia madre rincara la dose, con il suo atteggiamento melenso e patetico, sciorina il repertorio dei sette mesi di ospedale, degli undici interventi, di modo che uscendo dal camerino, oltre a notare di essere tornata a calzare discretamente una quarantadue, mi accorgo dello sguardo compassionevole della commessa, e mi sento nuovamente freddata dalla violenza della pietà. Adesso va meglio, vero? Complimenti per i traguardi raggiunti, dice. Severa, la osservo e abbandono il negozio, mia madre resta lì con le magliette in braccio. Più tardi, a casa, le dirò di lasciarmi in pace. Al suo rimbrottare, seguono le becere ciance di mio padre, per cui: Non è mica colpa nostra, troppo bene ti è andata, e non ci hai mai neanche ringraziato. Così, stremata, ripensando alla loro presenza costante, al commento di ogni azione, alle code in bagno al mattino, al senso di colpa che mi hanno instillato per quel gesto di cui forse non avevo mai neppure supposto fossero in parte responsabili, agisco sconsideratamente fracassando un tavolinetto in legno all’ingresso e l’appendiabiti. Mio padre fa per colpirmi ma prima che lo faccia gli do un pugno in faccia e torco il polso a mia madre che tenta di fermarmi. Torno nella mia stanza, nel berciare indefesso della mente che non mi abbandona e si spande esiziale in ogni parte di me, fino a rigettarmi nell’insensatezza di ogni cosa, nella mia insignificanza, nel desiderio antico e sempiterno di abbandonare il mondo.
Questa e molte altre notti rinfocolate dall’insonnia, medito nuovamente di annientarmi, giunta ancora qui, nel deserto, nel deserto dell’affetto, del sentire, del giudicare. Non ho sentimenti che non siano spregevoli, la mia sola consapevolezza è di non essere quel prodigio da loro prefigurato, di non aderire all’ideale scolpito dalle aspettative di tutti, o forse solo dalle mie.
Una casa in mezzo al bosco, coperta da embrici, cerco riparo riconoscendo alla finestra il volto di una donna dai tratti velatamente nipponici, e di un uomo. Uno sconosciuto al pianoforte suona una melodia che interrompe bruscamente per ricominciare molte volte daccapo. Lo contemplano, seminudi, fradici. Dalla posizione in cui sono – una ladra che voglia arrampicarsi per entrare dalla finestra della mansarda – posso vederli fino alle clavicole. Sembra si siano spogliati poco prima che arrivassi. È una nudità familiare, sottende un’antica complicità, probabilmente antecedente al mio suicidio – ho smesso di usare la parola incidente grazie alla perentorietà di O. –, nudità da lenocinio di cui non posso essere artefice. Io sono l’estranea alla finestra, ma la casa è quella della mia infanzia, il Prima assoluto. Filze di biancheria intima pencolante e bagnata di pioggia nell’orto antistante il muro. Era bianco, quel muro, e rosse le tegole, sarebbe stata la casa disegnata da un bambino se non fosse stata un tempo la mia. Urlo e batto le mani ai vetri e lei, salace, pur guardando in mia direzione, finge di non sentirmi e non vedermi. Anche lui mi guarda ignorandomi; non si toccano, ma quelle nudità abbacinano spietate. Non posso più essere toccata, e neppure vista, scivolata oltre la linea di confine tra vivi e morti, tra abili e inabili. Resto a guardare le foglie roride, e la tempesta – il cielo iniettato di folgori – mi colpisce strappandomi la giacca.
Svegliarsi e non svegliarsi mai. Controllare il telefono, trovare i soliti messaggi, decidere di sparire. Come si prende la decisione di farlo? Come nel sogno, guardavo altri riuscire dove io avevo fallito, e andavo bendata tra le spade. Ero quella precisa carta degli arcani minori. Poi, sono stata risparmiata, ma continuano a lasciarmi fuori dalla porta di una casa che non mi appartiene più. Non chiedo perdono. Mio padre mi osserva senza parlare, mia madre alza le spalle: non ho chiesto perdono neanche a loro. Quella pietà non posso accettarla, così come la premura riservata ai malati, ai paria. Se non posso entrare nel mondo, combattere, sapere che giungerà un giorno il mio grande sì alla vita, allora voglio andarmene. Al culmine del pianto vado a prendere la cartella clinica della rianimazione del San Giovanni.
Orientamento diagnostico:
03/05/2022
Politrauma in caduta da grande altezza: ESA, PNX polmonare destro, emotorace destro con aree contusive polmonari, fratture costali multiple scomposte a destra, lacerazione segmenti epatici V-VI sottoposto a trattamento in radiologia interventistica, emoperitoneo, frattura da scoppio L2 con frammenti endocanalari, frattura pluriframmentaria del sacro, frattura scomposta branca ischiopubica destra e acetabolo, frattura processi trasversi L1L2L5S1-destra.
Referto:
03/05/2022
TC del collo senza MDC
TC cranio senza MDC
TC del bacino senza MDC
TC del torace senza e con MDC
TC addome superiore con e senza e con MDC
Esame eseguito prima e iniezione di mdc per via e.v.
Iperdensità dell’emiporzione sinistra del tenorio come per ESA.
Strutture mediane in asse.
IV ventricolo normale e in sede.
Spazi liquorali della volta e della base di ampiezza nei limiti.
Falda di PNX polmonare a destra che risale fino all’apicema con maggiore spessore in sede basale circa cm3 di diametro.
Modesta quota di emotorace a destra.
Ampie aree contusive polmonari nel lobo medio e inferiore a destra.
Fratture costali multiple scomposte a destra.
Lacerazione dei segmenti epatici V-VI con segni di spandimento attivo di mdc in fase arteriosa che si rifornisce nelle fasi più tardive.
Segni di emoperitoneo con quota ematica periepatica e nel Douglas.
Frattura da scoppio di L2 con frammenti ossei endocanalari coinvolgente lamine e peduncoli.
Frattura pluriframmentaria del sacro.
Frattura scomposta della branca ischio-pubica destra con piccoli spot attivi parasinfisi omolaterali e dell’acetabolo con coinvolgimento del pilastro anteriore.
Frattura dei processi trasversi di L1-L2-L5-S1 di destra.
Dal punto di vista scientifico non ha senso essere qui. Non oso più pronunciare molte parole, non ne trovo di adeguate. Nella cartella clinica dell’unità spinale era scritto: livello di lesione L2-B; paraplegia. B è quasi completa. Sono arrivata in unità spinale il 25 maggio in quelle condizioni. Sono uscita il 28 ottobre con il rollator, il livello della lesione era cambiato. Dovrei sempre riaprire quella cartella per rendermi conto. Perché io dimentico. Ritorno al punto di partenza. I libri accatastati. Il mandala sulla parete. Gli armadi e gli specchi. Il parquet. Lo sproloquiare del notiziario. Il rombo di un’auto. Pioggia. Dimentico di aver vissuto qui prima del suicidio. Di essere stata quasi anoressica. Di aver portato a casa amanti appena conosciuti per poi tornare ossessivamente a pensare a lui. Dimentico. Le mani, la lingua, il sesso. E di aver poi pensato alla punizione. Non sentirai mai più. Vogliono amputarti l’arto destro a partire dalla vagina. Resterai storpia. Di aver detto a un’infermiera: Vi prego, staccate tutto, non posso affrontarlo. Embolizzazioni. Trasfusioni. Dimentico. Cosa ci fai qui? Meriti questa seconda possibilità? A quali condizioni? Non pensare. Ora cammina. Non pensare. Non devi pensare.
Quello che accade dopo un suicidio, se si sopravvive, naturalmente, è che alcuni non ti considerano più tra i vivi, li spaventi, per loro sei comunque morto e devi costantemente affermare che esisti, è stucchevole, ma va fatto.


Credo che dire “Io” onestamente sia la cosa più difficile al mondo, e Ilaria ne è capace in un modo che ha del miracolo. La sua sincerità è intransigente, spudorata, integralista. E capita che, parlando di sé in questo modo ci spalanca visioni su questo mondo in cui noi tutti siamo immersi, ma non al suo grado di sensibilità. Nei suoi scritti il clima psicologico dell’epoca è portato a un’intensità che lo rende insopportabile, e al tempo stesso proprio per ciò c’è qualcosa che lo pulisce. In questo scritto ci sono due parti distinguibili ma pienamente integrate: il dialogo con O. -reso senza virgolette, per integrarlo nel flusso del testo, per non sottolinearne lo stacco- e una complessa melodia di ricordi e riflessioni, in cui le enunciazioni del dialogo iniziale vengono come messi alla prova della vita. Come spesso accade in Ilaria, le ultime battute portano a una chiusa sospesa ed estatica nella sua violenza, il cui effetto mi ricorda le ultime battute della Nona sinfonia di Mahler, col suo smaterializzarsi, svaporare in suoni sempre più acuti e lievi… “Pietà” è una prosa saldamente strutturata pur nel suo essere fluida, e realizza quell’arte di scarnificarsi che è tipica di Ilaria, fino al tabù supremo, l’anelito a realizzare il sè spogliandosi di sé.