Un tesoro (sperimentale) ritrovato
di Roberta Salardi
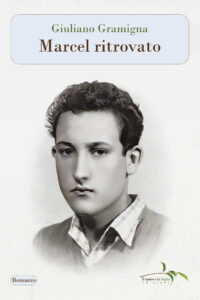
Giuliano Gramigna, Marcel ritrovato (Il ramo e la foglia, con una nota di Ezio Sinigaglia, Roma 2023, euro 17.)
“Passai portandomi dietro quel segnale di marrone e azzurro. Il mio cuore aveva accelerato, addirittura extrasistoli, ma era una specie di dilatazione euforica come quando ci si mette a correre, poi manca il fiato e ci si sente bene, si sta per scoppiare e ci si sente ancora meglio con energie intatte. Galoppavo a cavallo della mia nevrosi: sindromi spastiche dell’apparato digerente, neurosi splancnica, stipsi spastica, neurosi cardiaca e vasale, instabilità circolatoria, vertigini, distonie funzionali degli ipotesi, iperemesi, vertigini labirintali, mal di mare, affezioni del sistema nervoso extrapiramidale, colangiopatie, disfagie esofagee, vomito, acroasfissia, acroparesia, claudicazione intermittente (…) travaglio di parto eccetera, a cavallo non guarito ma in certo senso esultante. Anch’io avevo avuto quei capelli castani sulla fronte, la pelle nuova con la peluria bionda dietro le mandibole scampata al primo, ostinato rasoio; naturalmente senza rimpianto, però come mi erano piaciuti nei primi dieci, trenta secondi che li avevo incrociati. Neppure Marcello era sempre stato il manichino-a-successo del Tennis Club: per non dire niente altro, oltre le guance giovani, i muscoli elastici, l’aria di cuccioli, eccetera, c’erano state anche le speranze del ’45. Un momento di eccitazione non romantica ma proprio fisica, un’estasi corporale, una scossa elettrica data dalle cose, come inspirando nel momento che scrivo di me e di Marcello l’aria limpida, sottozero di Milano 8 gennaio 1967, dove sembra di stare quasi a Irkutsk.” (pag 266)
Nel romanzo circola l’aria libera, frizzante e innovativa degli anni Sessanta. Uno dei primi segnali che ci avvisano di trovarci di fronte a uno scrivente alla ricerca di un proprio stile fuori dalle convenzioni è lo scivolamento dalla terza alla prima persona; prima persona, quella del protagonista Bruno, dubitativa, inquieta e dispettosa.
La vita borghese, impiegatizia e affaristica di Milano, inquadrata nella prima parte del volume, verrà ben presto lasciata alle spalle dopo la rappresentazione di qualche cena e dialogo irritanti per il protagonista, il quale si accinge a scrivere un nuovo romanzo ma non sa ancora come. L’occasione di un viaggio a Parigi offertagli dalla necessità di aiutare un’amica amata in gioventù, il cui marito pare volatilizzatosi nella Ville Lumière, viene colta dal protagonista come chance per sbloccare la situazione penosa in cui pare impantanata la sua vita.
A Parigi nuove sensazioni ed emozioni danno subito al personaggio uno slancio inaspettato. La varietà linguistica e dialettale sperimentata nelle prime pagine si arricchisce dell’invenzione di neologismi italo-francesi (per esempio a pag 182: “buttechaumontando, menilmontandosi con un frémicourt, lafayettato, senza courcellare un montsouris”). Bruno precisa: “Uso diverse lingue ma non per colore locale: come Ennio ho due o tre cuori e cioè nessun cuore: meticcio al massimo, se mai ve ne furono…” (pag 259). La questione dell’identità molteplice, che s’intreccia a quella delle nevrosi, si rifrange in molte pagine del libro. È messa in evidenza da Ezio Sinigaglia nella sua ampia nota al testo, accanto alle preziose osservazioni sugli autori di riferimento, dichiarati e criptici. Sinigaglia fa presente che non solo Proust è il maestro che s’aggira come un fantasma nell’opera. Il protagonista si trova invischiato in un rapporto irrisolto col padre morto di recente e la sua condizione pare molto simile a quella dello Zeno di Svevo. A questo si potrebbe aggiungere che il gusto per il plurilinguismo, per i giochi verbali e per lo slittamento dalla terza alla prima persona era anche di Joyce.
Il libro che sta venendo fuori non sarà d’impianto prettamente sociologico o sentimentale, come sembrava nella prima parte, sempre più dissestato dai tic nevrotici del narratore, che giunge a curiosamente lamentare, anche dopo la full immersion nella stimolante Parigi, una sua insofferenza per la propria stessa scrittura: a pag 195 fa dell’autoironia quando dice che scappa dal foglio bianco e inventa continue fughe minime “da questo pensum (peso? vuoto?)”, dall’impegno di scrivere. Il centro sarà l’io, la sua complessità e inafferrabilità, con annesse e connesse le difficoltà dei rapporti, l’incertezza delle conoscenze, la fragilità delle situazioni e via di seguito con le tematiche care a tanti romanzi del Novecento. Non mancheranno episodi derivati dalla vita quotidiana né incontri con personaggi poco affascinanti e poco “romanzeschi”: “… il romanzo è una pompa aspirante, pompa tutto, tutto gli fa brodo” (pag 234).
In un capitolo che inizia già in modo singolare (con la lettera minuscola e con il periodo che prosegue dal capitolo precedente senza soluzione di continuità) si susseguono pagine a ritmo accelerato (pagg 256-259), in coincidenza con la visita a Versailles, fonte di una nuova emozione del tutto differente dalle precedenti, “semplice chimicamente e subito trasformata in conoscenza”. È allora che Bruno riesce finalmente a “calettare” dentro gli anni-vita gli anni-lettura, secondo il metodo proustiano descritto con mirabile sintesi alle pagine 187-188 (che citerò).
Disseminati un po’ dappertutto sono i riferimenti al maestro per eccellenza, a cominciare dal titolo e dal nome del personaggio amico, Marcel, sulle piste del quale ci si mette alla ricerca. Tra i maggiori riferimenti alla Recherche svettano, a mio parere, la decisione del protagonista di scrivere il romanzo al termine del libro, come avviene nel settimo dei sette volumi della Recherche, e una sintesi efficace di quale sia il significato essenziale della maggiore opera proustiana: “Nella sua dilatabilità infinita di calderone dove bollivano un po’ tutte le carote e sedani e fagioli e cotiche del reale, la Recherche gli era sembrata, probabilmente, l’ideale stampo interpretativo. Qui Bruno sentì quella scossa un po’ agra, mista di compiacimento e delusione tipica di quando si va vicino a una verità senza acchiapparla del tutto. Ma poi: interpretativo di che cosa? non semplicemente della vita o della letteratura ma piuttosto del modo di percepire e di organizzare la vita. La Recherche, a ben guardare, è una tecnica percettiva e strutturatrice: la sua grandezza sta tutta qui e sfido che deborda insieme vita e letteratura e lascia di stucco critici ed esteti. Un metodo per prendere coscienza di tutte le zone della realtà e ipotizzarne una struttura completa dove tutto si tiene (…) La méthode o techne proustiana è insieme parcellare e organica. Riconoscere alla Recherche questa natura di metodo (…) è il massimo elogio. (…) Insomma: dalla Recherche non si esce dicendo: vivrò così o: scriverò così, ma: ho tra le mani un esempio di sistema per percepire l’insieme dell’esistenza e rilevarne in ipotesi le strutture significanti” (pagg 187-188). Starà al lettore fare tesoro dei suggerimenti di Gramigna e dei suoi maestri per rendere migliore la qualità della sua vita.

