Intervista a Yasmina Melaouah: ritradurre “La peste” di Camus
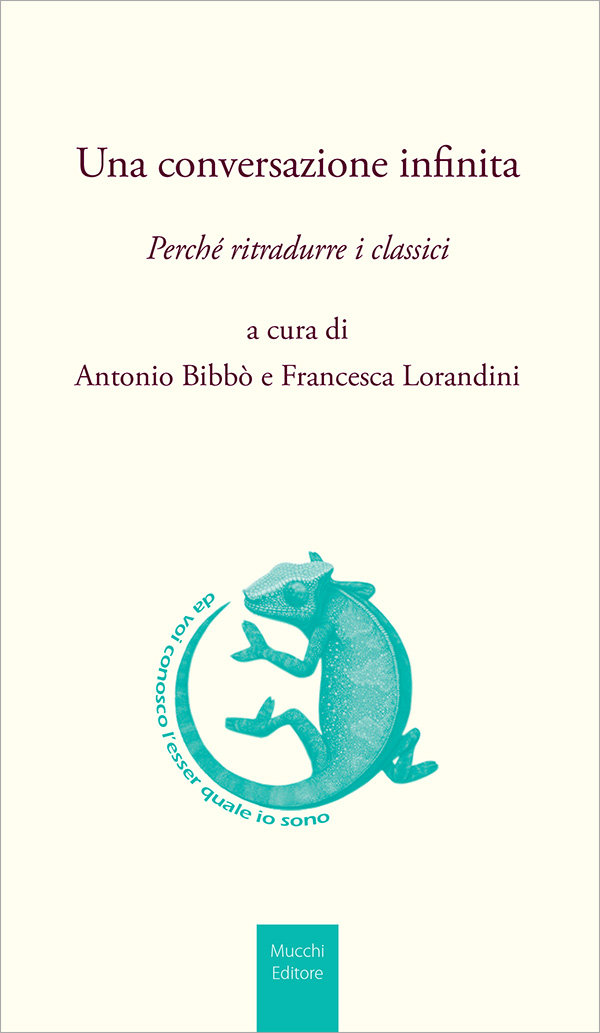
[È uscito per Mucchi il volume Una conversazione infinita. Perché ritradurre i classici, a cura di Antonio Bibbò e Francesca Lorandini, nella collana “Strumenti nuova serie” diretta da Antonio Lavieri: si tratta di una raccolta di contributi firmati da Andrea Binelli, Ilide Carmignani, Franca Cavagnoli, Claudia Demattè, Massimiliano De Villa, Giulia Giorgi, Yasmina Melaouah, Luca Morlino, Elisa Aurora Pantaleo e Giulio Sanseverino. Pubblico qui di seguito, a mo’ di anteprima, l’intervista di Sanseverino a Melaouah, a proposito della sua nuova traduzione di La peste di Camus. ot]
Sanseverino: Dal momento che risulta difficile preconizzare la frequenza temporale delle ritraduzioni, che non seguono una cadenza sistematica, partirei proprio con una domanda sul perché ritradurre La Peste oggi, considerando la necessità di una traduzione meno datata di quella del 1948.
Melaouah: Posto che non voglio neanche mettere la punta del piede sui massimi sistemi, sul perché si ritraducono i classici, mi domanderei piuttosto perché ritraduciamo. Io sono abbastanza renitente a quell’idea, che ormai mostra un po’ la corda, secondo cui i classici invecchiano e bisogna togliere la polvere. Proprio dopo aver lavorato a La Peste, che nel corso della mia vita avevo già incontrato spesso (a quindici anni la prima volta, nei panni di lettrice; poi laureandomi su Camus e in vari altri momenti successivi), mi sono resa conto che non siamo noi traduttori ad andare nel passato in veste di archeologi per dissotterrare, ma sono i grandi classici a trovarsi molto più avanti di noi e ad aspettarci, per così dire, nel futuro; bisogna rincorrerli. Capisco che possa sembrare solo un’immagine a effetto, ma ho davvero la sensazione che fra i vari traduttori che si susseguono sullo stesso testo è come se si instaurasse una specie di staffetta: ci passiamo il testimone, all’inseguimento di un testo che è più avanti di noi. Nel 2019 non eravamo ancora arrivati alla pandemia, eppure La Peste era già lì, per raccontarcela. Aprendo una parentesi personale, confesso che prima di ritradurlo io mi ero già paurosamente ritrovata in questo romanzo. Erano gli anni tra il 2015 e il 2017, in cui, soprattutto in Francia, la peste più virulenta era la cosiddetta peste verte, cioè il terrorismo islamico, per dirla in maniera un po’ rudimentale. Nell’estate del 2016 leggevo le pagine di Camus mentre i mezzi d’informazione raccontavano la strage della Promenade des Anglais di Nizza, avevano già raccontato Charlie Hebdo, e il Bataclan ancora prima. Sentivo che questa comunità di uomini, colpita nel romanzo dal flagello dell’epidemia, rappresentava anche una comunità sgomenta e spiazzata da un altro tipo di pestilenza (uso questa parola non a caso, perché sono proprio alcuni intellettuali algerini e altri politologi a parlare di peste verte come immagine del fanatismo islamico[1]). Quando poi siamo arrivati al 2020, ho sentito ancor più vivamente, senz’altro, come l’opera era capace di raccontarci la nostra pandemia. E tanto più confermava l’idea – poco nobile, scusate – che con i classici succede un po’ come quando ci si aspetta agli autogrill: noi lettori partiamo, con i nostri tempi, ma sono i classici ad aspettarci più avanti, e vanno raggiunti. Direi che proprio questa capacità di riformulare il mondo in una narrazione nuova, di essere testo aperto, è la dominante cruciale per un traduttore. La possibilità di continuare a dire diventa allora una bussola nel silenzio. La cosa che a me sta più a cuore quando traduco, infatti, è il non riempire mai i silenzi che un testo racchiude, non riempirli mai di un senso forzato che è frutto solo di una circostanza, di un’esperienza; come sarebbe stato, per esempio, riempire La Peste con la pandemia del 2020. A questo proposito è illuminante il saggio di Nicola Gardini[2] sull’importanza dei vuoti e delle lacune nei testi letterari. Lasciare che il testo parli vuol dire fare un passo indietro, fare economia testuale, togliere perché il lettore possa giocare la sua parte e portare il suo senso dentro a quei vuoti. Chissà che ogni tanto non possa servire anche come giustificazione per qualche dimenticanza! Riguardo a La Peste, oltretutto, ritengo che la prima traduzione di Beniamino Dal Fabbro meritasse davvero una ritraduzione – e non lo dico solo perché me ne sono occupata io. Mentre per la prima de L’Étranger a cura di Alberto Zevi poteva bastare qualche ritocco, quella di Dal Fabbro era invecchiata troppo, o forse era proprio nata male. Peraltro, lui era anche scrittore, poeta, pianista, pittore, di tutto e di più, e questo la dice lunga su come talvolta rischino di essere ingombranti quelle personalità eclettiche che si prestano anche, ma non principalmente, alla traduzione. Nel proteggere i silenzi, appunto, la traduzione del ’48 non fa un gran lavoro: Dal Fabbro interviene massicciamente sulla punteggiatura andando verso la normalizzazione (un tic di molti traduttori non consapevoli), per esempio fondendo molte frasi, cioè eliminando dei punti, quando proprio il punto fermo è un momento di silenzio. Continuare a toglierli ossessivamente, nella fattispecie sostituendoli con i punti e virgola, significa sottrarre al testo i suoi spazi.
S: Trovandosi davanti a un monumento letterario come La Peste, le scelte che si impongono a chi traduce si riducono sostanzialmente a due poli, con diversi gradienti nel mezzo: da un lato, prendere in considerazione, prima di avviare il lavoro, tutto o parte del bagaglio paratestuale che accompagna il romanzo (studi critici sull’opera, sull’autore, vicende bibliografiche, ricezione del testo originale, etc.); dall’altro, adottare quello che i New Critics chiamavano close reading, quindi isolare il testo da eventuali filtri esterni (storici, biografici, politici) per cercare di dar voce soltanto alle parole sulla pagina. Nel caso di una ritraduzione, a questo si aggiunge la presenza ineludibile, che la si interpelli o meno, delle traduzioni precedenti. Entrambi gli approcci comportano dei vantaggi, forse più lampanti nel primo caso, quello degli approfondimenti preliminari. In realtà anche una lettura ravvicinata e che si presume priva di influenze potrebbe mettere al riparo da quelle che Wimsatt e Beardsley definivano nei rispettivi saggi « intentional » e « affective fallacies »[3], ovvero, da un lato, evitare di sovrapporre ciò che dice il testo con le intenzioni del suo autore (supponendo che si possano intercettare) e, dall’altro, non riuscire a distinguere il testo in sé dagli effetti che esso produce sul lettore. Nel caso de La Peste, quale linea di condotta ha seguito? E come ha pensato la strategia di traduzione prima di iniziare il lavoro, anche rispetto alla prima traduzione?
M: Il guaio è che avevo già lavorato tanto su Camus alla fine degli studi universitari, per cui l’opzione “io e la pagina” era comunque impraticabile. Così ho letto il leggibile, esaurendo praticamente tutto ciò che ho trovato alla Bibliothèque nationale de France, a Parigi; con gran piacere, peraltro. Mi ha salvato e insieme frustrato, però, il fatto che in mezzo alla sconfinata bibliografia su Camus, tranne forse per L’Étranger, i testi che analizzano e trattano nello specifico la sua lingua e il suo stile sono pochissimi: ci si concentra piuttosto sulla sua figura di intellettuale, sui suoi temi. Questo mi ha aiutato nell’aprire una fase di faccia a faccia con la tenuta della parola sulla pagina, che poi è sempre l’approccio del traduttore: a un certo punto filtri e digerisci le letture, lasciandole fuori dalla porta.
S: Considerati i due atteggiamenti evocati prima, quale grado di disciplina occorre adottare per mettere tra parentesi il proprio bagaglio di conoscenze al fine di ascoltare il testo e, al contempo, rispettarne i silenzi?
M: Il traduttore è come se fosse, dicono i francesi, tra due casquettes. In prima battuta siamo lettori e, come tali, rispondendo al richiamo del testo letterario (più di quanto non accada con altri testi), portiamo il nostro processo interpretativo, riempiendo così i silenzi. Dopodiché togliamo la prima casquette e indossiamo quella d’autore – che si chiami autore in seconda, al quadrato o invisibile, poco importa. È a quel punto che va lasciato spazio affinché il nostro lettore, italiano, possa anche lui fare il gioco che abbiamo già fatto noi. Da qui forse tutte le derive in termini di nevrosi del traduttore, che è dilaniato tra i due ruoli. A me piace però lasciare che sia il lettore a fare la fatica di abitare quei silenzi. E occorre tanta disciplina, sì. Frequentando molti traduttori, un dato anche caratteriale lo ritrovo spesso: ci sono quelli a cui piace occupare la pagina, che vogliono lasciare in vista la propria autorialità; ad altri piace meno. Nel mio caso, mettermi al servizio dell’autore con tutta me stessa, fare un passo indietro, non mi sembra sminuisca il lavoro o lo renda di statuto secondario, perché in esso convoglio comunque le mie idiosincrasie. Poi noi traduttori siamo abituati ad essere funamboli tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, per cui rientra tra le nostre competenze la capacità di giostrarsi tra una parola apparentemente casuale ma che ritorna spesso, da un lato, e tutto ciò che sappiamo riguardo a quella parola dagli studi preliminari, dall’altro. È un equilibrio che si impara, o si spera di imparare, con il tempo.
S: Qualche anno fa, sulla rivista Tradurre, mi capitò di leggere un articolo[4] in cui parlava del suo primo incontro da lettrice con Camus, attraverso una certa reticella dorata. Oggi invece le chiedo qualcosa in più sul suo incontro con Camus da traduttrice, considerando anche la collaborazione con Bompiani. Com’è nata?
M: Devo dire che li ho un po’ tormentati quand’ero giovane, perché Camus evidentemente è l’uomo della mia vita, con tutto il rispetto per i congiunti! Innanzitutto mi sono laureata con una tesi su Camus. Quando nel 1984, curato dalla figlia Catherine Camus, esce in Francia Le premier homme (che secondo me tra l’altro è il suo romanzo più bello, ancora inedito nella sua valigetta al momento dell’incidente d’auto in cui perse la vita, nel gennaio 1960), io lo leggo immediatamente. Poi, con un candore ancora da ragazzina, prendo il telefono per chiamare Bompiani e dire: « Ho fatto la tesi su Camus e questo voglio tradurlo io. » Ricordo che la Sgarbi[5], carinissima peraltro, rispose che le faceva molto piacere ma che avevano già affidato la traduzione a Ettore Capriolo. Mollo il colpo, ma qualche anno più tardi, per l’edizione completa dei Classici Bompiani – che è un po’ la loro versione della Pléiade francese – mi viene affidata la revisione redazionale delle traduzioni che stavano per mandare in stampa. Si erano accorti che in alcuni testi c’erano molti errori di traduzione, anche marchiani, e quindi mi diedero tutta l’opera di Camus da rivedere rapidamente, in due mesi, per scovarli. Probabilmente perché ero giovane e un po’ sprovveduta, ma anche a causa dei tempi strettissimi, qualcosa di quegli errori è rimasto ancora, soprattutto ne Lo Straniero. Errori peraltro in parte riportati anche nella nuova traduzione; ma pazienza. Quindi un filo conduttore c’è sempre stato. In realtà, il mio sogno era di tradurre L’Étranger. Nel 2015 invece accetto la proposta di ritradurre La Peste, all’interno di una precisa politica di Bompiani: Beatrice Masini, l’attuale direttore editoriale, con una bella definizione la chiama “manutenzione del catalogo”, ossia una rivalutazione dello stato corrente e una revisione periodica di quelle traduzioni, spesso molto vecchie, che riguardano autori stranieri fondamentali per la casa editrice. Su loro richiesta, ad esempio, io ho riguardato la traduzione di Capriolo de Il primo uomo[6], e quella è una traduzione che sta ancora in piedi. Ci sono invece delle traduzioni in commercio che richiedono un rifacimento. In questa manutenzione un ruolo preponderante lo hanno soprattutto gli eredi e gli agenti che curano i diritti di Camus, puntigliosi e attenti al destino dei suoi testi in traduzione. A ogni ritraduzione di Camus, infatti, gli eredi chiedono il mio curriculum, anche se la traduzione precedente l’ho fatta due mesi prima. Persino sulla scelta dei titoli il loro peso conta: ad esempio, tra poco uscirà il carteggio Camus-Casarès e Bompiani aveva proposto di non usare semplicemente “Corrispondenza” nel titolo, ma gli eredi erano in disaccordo[7].
S: A proposito del lavoro su La Peste, può dirci qualcosa riguardo al rapporto con il testo, facendo magari qualche esempio a partire dall’incipit?
M: Come sempre gli incipit sono cruciali in quanto luoghi di ingresso per il lettore. Anche dal punto di vista editoriale, molto biecamente, nel momento in cui uno è in piedi in libreria a leggere le prime quattro righe di un libro, se non funzionano lo chiude e lo posa sullo scaffale. Ma non è questo il caso. Sulle prime righe de La Peste[8] io sono tornata decine di volte, per diversi motivi. Innanzitutto, quel « qui font le sujet de cette chronique » mi faceva diventare pazza. Per la soluzione « descritti » sono debitrice alla traduzione inglese (che avevo e ogni tanto consultavo), che riporta « described »[9]. Gli inglesi vanno via molto più disinvolti nel tradurre, alle volte fin troppo. In italiano non avevo voglia di appesantire con “che sono oggetto”, “che fanno oggetto”, anche perché molto più importanti ritenevo altri due elementi, su cui deve cadere il peso della lettura: le parole chronique e ordinaire. Il narratore usa subito la parola “cronaca”, sia perché erano cronache della peste quelle che Camus aveva letto come documentazione[10], sia perché la pone in antitesi alla parola “romanzo”: la cronaca è qualcosa di asciutto, neutro, anche un po’ noioso, simile a un verbale, a un resoconto dove non c’è ornamento, e quindi dove non si inganna. La Peste è la cronaca rigorosa di una comunità di uomini alle prese con il flagello. Il narratore, la cui identità si scoprirà solo alla fine, vuole dunque farsi il cronista di una città colpita da un flagello. Anche ordinaire creava problemi: non si parla solo di qualcosa di ordinario, ma di comunissimo, di grigio, comune nel senso di condiviso da tutta la comunità degli uomini, tema fondamentale dell’opera. Nell’incipit, il pasticcio per l’italiano era che il primo dei due « ordinaire » è un sostantivo, l’altro un aggettivo che non permetteva di conservare la stessa forma. Grazie a una di quelle intuizioni che arrivano durante le passeggiate, usare « fuori dal comune » e poi « comunissimo » mi era parsa una soluzione leggibile (per quanto io, della leggibilità, me ne infischi abbastanza) e che, nello stesso tempo, teneva insieme i sensi di ordinaire. Comunque credo che ci siano davvero delle parole chiave, in dialogo continuo. Più vado avanti, più cadono anche certe prese di posizione che avevo qualche anno fa a livello teorico (sull’essere una bermaniana di ferro, una sourcière). Più traduco e sprofondo nelle reti di parole, più diventano labili queste appartenenze categoriche. Per me ci sono piuttosto l’attenzione e l’ascolto alla pagina. Se essere una sourcière comporta un ascolto quanto più possibile scrupoloso della pagina e dei suoi silenzi, allora sono una sourcière, o forse una sorcière[11]! A volte dico ai miei studenti, lasciandoli molto frustrati, che le versioni finali saranno sempre “il meno peggio”: ciò che importa davvero, è la voce da ascoltare. Se l’ascolto è ben fatto, la traduzione sarà buona. Ma l’attenzione posta all’esito è sempre maggiore, specialmente nei giovani traduttori, che corrono verso l’italiano.
S: Su cosa le sembra di aver dovuto lavorare di più rispetto alla prima traduzione?
M: Una delle dimensioni che mi sembrava mancasse di più nella vecchia traduzione, ma che io trovo sotterranea al testo, è quella del pathos che viene fuori in alcune scene. Dal Fabbro aveva schiacciato molto il pedale dell’aspetto cronachistico, di noia e grigiore, anche talvolta appesantendolo. Tuttavia, la forza di questo romanzo è che, accanto al rigore della cronaca e al rifiuto dell’ornamento, ossia accanto alla voce dell’intera città, ci sono poi momenti in cui erompe la voce dei singoli, la sofferenza e il senso dell’esilio, cioè quella nostalgia delle felicità individuali che – adesso lo sappiamo bene – bisogna mettere da parte nei periodi di flagello, e che viene tenuta a bada ma non eliminata, all’interno del romanzo. Nelle righe conclusive[12], infatti, è come se l’emozione potesse finalmente emergere e, di conseguenza, il ritmo trova sintonia con il pathos. Ci sono alcuni momenti di vera e propria commozione, che credo colgano anche il lettore alla sprovvista, perché staccano rispetto al tono da verbale del romanzo. Stando lì a mettere in fila le parole, io ho sentito questa commozione fuoriuscire attraverso un senso davvero molto compiuto del ritmo; sul finale, appunto, come il fluire di una musica segreta, che chiude. È lì che mi è sembrato di dover lavorare maggiormente. Così pure in alcune scene delle parti interne, quando ad esempio il giornalista Rambert si aggira nella stazione vuota guardando i cartelli che invitano a una vita felice a Cannes o a Bandol: un’immagine che restituisce l’idea dell’esilio più di qualsiasi discorso già affrontato sull’esilio e sulla solitudine. Il ritmo è una bussola terribile, perché poco studiato per la prosa. Quindi bisogna un po’ navigare a vista, con il proprio metronomo interiore. Mi ricordo che alla mia primissima traduzione, un romanzo di Héctor Bianciotti, l’autore mi scrisse poi un biglietto molto carino, in cui diceva: «Madame, la cadence, c’est tout!».
_
Note
[1] Una definizione sintetica di peste verte si trova in Giniewski e Matteoli, Israël, les islamistes extrémistes et les démocraties occidentales, « Rivista di Studi Politici Internazionali », Vol. 71, No. 2, 2004, 231: « La “peste verte” désigne l’infime minorité des islamistes extrémistes qui se couvrent de la religion pour camoufler leurs buts politiques et tenter de justifier leurs activités criminelles sous le manteau du jihad, et dont l’opprobre rejaillit sur une majorité d’innocents. »
[2] Nicola Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, Einaudi, 2014.
[3] Inclusi nella raccolta The verbal icon: Studies in the meaning of poetry, in W. Wimsatt e M. Beardsley (a cura di), Lexington, University of Kentucky Press, 1954, 3-18.
[4] Y. Melaouah, La reticella dorata. Come sono diventata traduttrice, Rivista Tradurre, 15, 2018.
[5] Elisabetta Sgarbi, direttrice editoriale di Bompiani fino al 2015.
[6] Albert Camus, Il primo uomo, Milano, Bompiani, 1994.
[7] Il testo è stato infine pubblicato da Bompiani nel 2021 con il titolo Saremo leggeri. Corrispondenza (1944-1959).
[8] Per comodità di consultazione e confronto, riportiamo in nota l’incipit originale e le sue due traduzioni:
T0 : Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran. De l’avis général, ils n’y étaient pas à leur place, sortant un peu de l’ordinaire. À première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu’une préfecture française de la côte algérienne. (Camus, La peste, Gallimard, 1947, p. 11)
T1 : I singolari avvenimenti che dànno materia a questa cronaca si sono verificati nel 194… a Orano; per opinione generale, non vi erano al loro posto, uscendo un po’ dall’ordinario: a prima vista, infatti, Orano è una città delle solite, null’altro che una prefettura francese della costa algerina. (Camus, La peste, Bompiani, 1948, p. 5)
T2 : I singolari avvenimenti descritti in questa cronaca si sono prodotti nel 194. a Orano. Era opinione diffusa che capitassero nel luogo sbagliato, trattandosi di avvenimenti un po’ fuori dal comune. E Orano è invece, a prima vista, un posto comunissimo, una semplice prefettura francese della costa algerina. (Camus, La peste, Bompiani, 2017, p. 9)
[9] La prima traduzione statunitense è di Stuart Gilbert: The Plague, pubblicata nel 1948 da Alfred A. Knopf.
[10] Per un approfondimento sui documenti medici e storici da cui attinse l’autore, si rimanda a Marie-Thérèse Blondeau (1986, 1999) e Jacqueline Lévi-Valensi (1991, 1999).
[11] Cioè una strega, parola che in francese ha una pronuncia molto vicina a quella di sourcière.
[12] Che riportiamo di seguito: « Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. » (1947, p. 279).

