Skei razza Piave
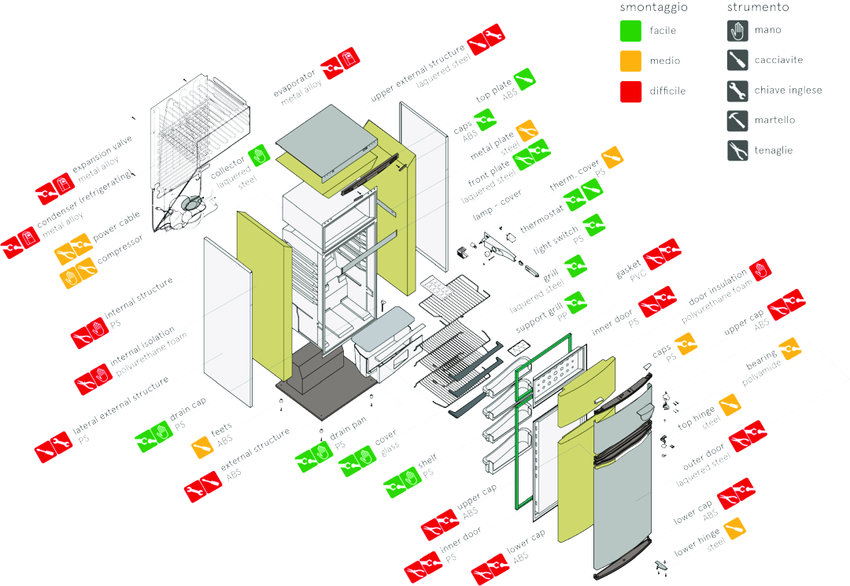
di Fabio Rodda
La catena fa sglang, sglang, sglang. Comincia con una sirena, un rumore aspro che risuona troppo a lungo nel capannone ancora silenzioso. Poi, si accendono gli ingranaggi ed è sglang, sglang, sglang che non smette più. Sglang, il colpo della pressa sulle lamiere: passano, sfilano sui rulli e arrivano alla postazione di Martino. Lui è quello che riempie di poliuretano espanso le due lamine di alluminio lisce e affamate di polimeri uretanici. Un fssshshhhhhh di getto che scivola tra i profili di estratto di bauxite ed ecco la schiena del frigo che arriva chez nous. Io e Manuel ci saltiamo sopra, i trapani ad aria compressa già caldi ben stretti in mano. Comincia la gara: due viti, un getto di colla calda ed ecco che si incastrano le pareti laterali. Giù dalla schiena e si gira attorno al bestione, a destra lui, a sinistra io in senso antiorario e ziuuff, ziuuff, ziuuuuffff: l’aria pressata spinge il rotore delle nostre pistole e la punta a croce stupra la testa dell’inserto di fissaggio fino a cacciarlo nella lamiera riempita di reticolato termoindurente. Venti minuti per finire lo scheletro. Al massimo. Natalino è lì che prende i tempi, segnerà in tabella la media: noi siamo la prima postazione dalla catena di produzione, noi siamo importanti, noi diamo il ritmo. E ziuuff, ziuufff, ziuuuuuuuffff: «quella non voleva entrare, la troia».
Ziuff, ziuff, ziuufffff e, ormai quasi dimenticato, soverchiato dagli sbuffi d’aria compressa, dallo stridore della ferraglia, dalle bestemmie della linea, lo sglang, sglang, sglang della pressa. La postazione punitiva. Ci mandano quelli a cui vogliono far passare la voglia: otto ore a tirar su e giù lamiere e abbassare il maglio da una tonnellata per farti capire qual è il tuo posto nel mondo: spazzatura eri, sei e rimarrai.
Ultimo balletto attorno al frigo industriale di cui già si intuisce la forma. Dobbiamo controllare che non ci siano buchi, fissaggi imperfetti, così poi il bestione potrà andare in qualche supermercato di merda a buttar freddo nelle sale enormi per vendere carne e pesce e verdura, potrà dare il suo contributo allo spreco energetico, aiutare ancora un po’ questo mondo marcito ad andarsene a puttane.
Sglang, sglang, sglang torna in primo piano, adesso che i trapani tacciono addormentati nella fondina legata al fianco. La tuta blu, il marchio bianco sul petto, vicino al cuore. Le scarpe antinfortunistiche con bande fluorescenti, che se finisci sotto qualche quintale di ferraglia in magazzino senza che nessuno se ne accorga, prima o poi le scarpe si vedranno e raccatteranno la poltiglia che eri tu. Finirai sul giornale: incidente fatale sul lavoro. Non operaio morto. Incidente. Il fatale, poi, è conseguenza ultima ma dell’incidente, mica colpa di qualcuno, magari della fabbrica. Magari di un padrone. Sglang sglang sglang, già tre mastodonti agganciati con le catene, sollevati a un metro da terra e spinti avanti in linea. Cibien, dalla postazione subito dopo la nostra, mi guarda torvo.
Una sirena troppo forte squarcia il ritmo della fabbrica: dieci minuti di pausa obbligata. Tutti fuori per far arieggiare il capannone. Nel cortile fa freddo, me ne sto appoggiato al muro e fumo la solita stizza nevrotica coi postumi della birra che salgono fino alla gola. Passa Martino, gli occhi rossi: si è separato dalla compagna un anno fa. La stronza non gli fa vedere la figlia più di una volta al mese. Perché non è un buon padre. Perché beve troppo. Domani è il compleanno della ragazzina: «la me ha domandà la tuta dell’Adidas per regalo. Ma la costa novanta euro. Mi ne ciape mili e doe al mese e ne passo ottocento per il mantenimento. Fae come? No li ho sti schei».
Martino, ingobbito nella sua vergogna, mi guarda di sotto in su, mentre il cielo denso e pesante sembra volerci avvolgere nel grigio di una metà mattina metallica: «te li presto io».
«No, vecio, grazie ma no pode. Non posso», scuote la testa l’orgoglio sprecato di Martino. Una vita come tante da ‘ste parti, fregata dalle ombre – sempre troppe e mai gustate, buttate giù in fretta per calmare qualcosa che preme appena dietro ai polmoni, sempre lì e ogni mattina, da sempre –, da sua moglie, che chissà perché aveva immaginato una vita da Instagram e non la faticaccia banale di una valle chiusa e triste; dalla fabbrica.
«Non è un problema, Martino. Non pago affitto. Non ho alimenti da smenarmi. Non mi cambia. Me li darai quando puoi».
Gli occhi tetri di un disonore antico – figlio del senso del peccato, della colpa di esser vivi e di non essere un ingranaggio perfetto e oliato come gli altri, la colpa di esser poveri di cui occorre vergognarsi, ce lo dice lo smartphone – annuiscono e spariscono.
Cibien fuma camminando in cerchio fra le tre panchine del cortiletto. Fa così tutte le mattine, per tutti i dieci minuti di pausa. Sono ventitré anni che è qui dentro. Non è più nemmeno un fantasma. Nessuno sa qual è il suo nome. Il cognome è Cibien. Lui è solo Cibien, per tutti.
Da qui si intravedono gli uffici, i colletti bianchi con le ridicole camicie a maniche corte seduti davanti ai computer che decidono quante ore lavoreremo, quanto ci pagheranno, quanta produzione dovremo fare. Dietro, montagne segate da cumuli di nubi quasi nere. Cibien mi passa davanti rientrando. Lo guardo. Lui si ferma, gli occhi sempre bassi: «oggi non più de dodese».
«Dodici? Lo sai che Natalino mi farà il culo, vero? Ne vuole diciotto a fine giornata». Cibien alza due fosse vuote a fissarmi disperato: «dodese. No ghe la fae pi».
«Va bene. Ok, Cibien, come dici tu».
Rientro e torno in postazione. Manuel mi guarda con aria interrogativa. La risposta ai suoi dubbi gli fa crollare le braccia come corpo senza vita: «Setu mat?»
«Cibien ha detto dodici».
«Cazzo me ciavelo di cosa ha detto Cibien?»
«Coglione, son sei mesi che lavori qua. Cibien ventitrè anni. Si fa quanto dice lui».
«Ma, Natalino al ne coperà; ci farà il culo».
«Natalino si faccia ammazzare».
Ziuff… ziuff… ziuff: i trapani girano più lenti. Sglang, sglang, sglang: il mucchio di lamiere farcite alle nostre spalle già cresce. A fine giornata sarà una pila da un metro e mezzo e non serviranno i conti dei colletti bianchi o il cronometro di Natalino per capire che siamo andati lenti. Troppo lenti. Due terzi della produzione dovuta. Domani mattina Natalino mi spaccherà.
«Dio Cristo, lo sai che doman ci mandano in pressa, vero? Almeno na settimana non ce la leva nessuno».
«Lo so, Manuel. Lo so».
Sglang, sglang, sglang senza tregua, senza fiato, senza pietà.
Ziuff… ziuff… ziuff. Con calma, con respiro.
Salto dentro il frigo, ci scrivo un porco da far tremare i campanili e sotto disegno il mio nome gigante. Cibien coprirà il tutto coi tubi di raffreddamento e la lamiera della seconda coibentazione. Li firmo sempre tutti i miei pezzi: mi piace pensare che un giorno un manutentore Coop o Esselunga aprirà un bestione che non funziona più e ci leggerà la mia signature alta mezzo metro. E, se era una giornata storta, anche un bel bestemmione a caratteri cubitali, che si sappia che ‘sto frigo è stato prodotto qua, sotto i monti. Frigo razza Piave.
Ziuff… ziuff… ziuff, ancora un po’ più piano. Manuel scuote la testa. Io guardo la pressa e già so dove starò settimana prossima. Cibien si volta e accenna una smorfia che può somigliare a un sorriso.

