Liguriana
di Marino Magliani
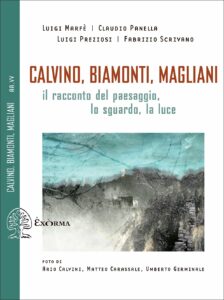
Quando Italo Calvino morì avevo venticinque anni e immagino di non averlo saputo, nel senso che non ricevevo notizie del genere, guardavo poco la televisione e non compravo giornali italiani. Avevo letto in maniera molto disordinata da ragazzo e da giovanotto, in giro per il mondo, le mie abitudini non erano cambiate, forse sapevo giusto che Calvino era ligure, di Sanremo, che era stato partigiano. Tutto lì. Ma scoprire che un grande scrittore italiano, forse il più grande del secolo, se ne fosse andato era quanto di più improbabile mi potesse capitare allora.
Era il settembre del 1985, quando Calvino morì, e io mi trovavo in Spagna ormai da alcuni anni, vivevo rigorosamente di notte e d’estate, spostandomi dal caldo della Costa Brava a quello dell’inverno canario o verso estati australi. Fin quando, non subito, con la fine delle isole non si concluse per forza anche quel genere di vita. Stanco di sole e di luna, desideravo più che altro fermarmi lungo qualche costa grigia del Nord Europa. A leggere, finalmente, e in seguito a decidere di scrivere.
Nel 1985 Francesco Biamonti aveva pubblicato solo L’Angelo di Avrigue e qualche racconto sparso negli anni Sessanta. Biamonti è morto nel 2001, autore di quattro romanzi, e io a quel punto ero già diventato padre, scrittore di poche cose nascoste e traduttore. Se è quindi molto naturale che non abbia fatto in tempo a conoscere personalmente Calvino (in realtà non sarebbe stato neanche così facile, non viveva più a Sanremo, ma si divideva tra soggiorni torinesi, romani e la sua casa toscana, tra le pinete, che è stata la sua ultima residenza), è invece abbastanza strano che io non abbia mai incontrato Biamonti. L’ho detto, traducevo e scrivevo da tempo, pubblicando libretti rigorosamente distribuiti tra Porto Maurizio e Oneglia, e tornavo in Liguria almeno un paio di volte all’anno. Lui negli anni Novanta viveva, come sempre, dove era nato e dove poi morì, a San Biagio della Cima, ai confini con la Francia. La rupe che guardava la sua campagna e la sua casa di paese distava un pugno di vallate dalla mia. Ci eravamo però sentiti al telefono, mia madre alla fine del millennio era molto fragile, e neanche per Francesco le cose andavano bene. Poco tempo prima che morisse ero riuscito a farlo invitare all’Istituto italiano di Amsterdam, poi non c’era stato più tempo.
Sulla diserzione, l’ossessione che popola i miei libri, Biamonti aveva letto un mio testo preistorico e forse, per dirmi che era ancora tutto molto acerbo o che non gli era piaciuto, mi fece notare semplicemente che alle diserzioni lui non era interessato, e mi chiese se io invece sì me ne intendessi. Ero un disertore, ammisi, come potevo non intendermene? E così, sollecitato dalle sue domande (ho il ricordo piuttosto vago di un uomo dalla voce calma e intelligente, un uomo curioso, desideroso di conoscere storie di vita, non uno di quelli che spiegava o si faceva spiegare il mondo, ma uno che amava ascoltare dinamiche), e una volta compreso che tra tutti lo affascinavano i racconti delle frontiere, devo avergli parlato a lungo dei miei confini privati, della tipologia delle mie diserzioni. In casa tenevano il telefono su un mobile, davanti alla finestra, la rugiada della campagna invernale brillava nel sole ligure. Sia chiaro, avevo sempre desiderato disertare, gli confessai, ed era la verità, tuttavia, quando davvero occorreva farlo, mi ero sempre tirato indietro. Da bambino avevo collezionato anni di collegio, una parte delle elementari a Nava, le medie a Mondovì, le estati a Entracque, la prima superiore nei Fratelli Maristi a Velletri. Insomma, le suore da bambino e da ragazzino i frati. Specialmente a Nava, mi facevo convincere dai professionisti de lla fuga, una vera attrazione: scappare di notte, attraversare i boschi, lungo paesi liguri e piemontesi (Nava, posta su una sella, circondata da montagne e fortini e pinete), addentrarci nel folto con le riserve nello zainetto. Le cose andavano preparate minuziosamente: la raccolta del cibo ad esempio ci vedeva col carrellino a sparecchiare i tavolini, sapevamo bene che le bambine lasciavano sul tavolo parecchio cibo, pezzi di pane, mezze mele. Rubavamo qualche bottiglia di quelle del latte e preparavamo una riserva d’acqua. Poi si aspettava una notte di luna. Ora che ci penso, il passeur di Biamonti in Vento largo non suggeriva altro: «Mandali su da me alla prima notte di luna».
Poi a una cert’ora sgusciava uno tra i lettini e veniva a svegliarmi (si scappava sempre in due o tre al massimo), mentre l’altro aspettava già fuori del collegio, oltre il piazzale di ghiaia, tra i pini. Ma io non dormivo. È ora, sentivo come una pugnalata. Non vengo. Come non vieni. Non vengo. In che senso, mi chiedeva irritato e sottovoce (le signorine che ci facevano la guardia dormivano dietro una tenda), in ginocchio. Io non lo vedevo, sentivo solo il suo alito e le domande tra i denti. Dai, c’è la luna, è tutto pronto. No, non vengo nel senso che non vengo. Il collega di non fughe strisciava via, non prima, almeno in un paio di occasioni, di avermi rifilato un cartone tra le costole.
Aspettavo qualche minuto per dargli il tempo di attraversare il piazzale di ghiaia, dovevano percorrerlo restando ai margini, i lampioni facevano chiaro come di giorno, poi mi alzavo e in punta di piedi andavo alla finestra a vedere il lavoro della luna sul costone, le pinete nere. Uscivano a un certo punto allo scoperto, in basso, lungo il tortuoso asfalto, a schiena bassa, la bisaccia gonfia, e dopo un po’ li perdevo, ora era o erano oltre il cancello, giù per la Nazionale. E io stavo lì, la testa inclinata da una parte, a sentirla – doveva capitare lo stesso a Degas, di pensare a Papillon in mezzo al mare, che stavolta ce l’aveva fatta – come un’occasione perduta. Il fatto è che Papillon non l’avevano ancora girato, e quanto a loro, i miei amici di fughe perdute, non ce la facevano mica, mai riusciti, e ancora oggi non so se assieme a me saremmo potuti giungere un po’ più lontano o persino in fondo a qualcosa, nella luna.
Nava, ci torno ancora ogni tanto, a cercare il bambino e salutare il luogo finale di Mario Novaro, secondo me, assieme a Giovanni Boine, il padre della poesia ligure.
Un giorno o due giorni più tardi, il mattino, la suora superiora riceveva la telefonata, e allora entrava nelle aule e faceva andare le classi alle vetrate. La camionetta dei carabinieri risaliva le curve e si fermava sulla ghiaia. Scendevano i miei colleghi mancati, uno o due, mani in tasca, bavero alto. Si pulivano il naso con la manica, tiravano su la faccia. Era tremendo e nello stesso tempo confortante sapere che non ce l’avevano fatta.
È passato tanto tempo, alcuni sono morti, ma troppo presto, ventenni, trentenni. Io per un po’ sono andato a vivere in fondo alle isole, di notte, sempre d’estate, sotto la luna, e poi sono giunto qui, sulla costa olandese. Qui la luna è la letteratura. Sono scappato a diciassette anni, dalle scuole pubbliche, ma non era mica scappare, non si scappa più se non sei scappato da bambino. Giravo la Norvegia, la Danimarca e un giorno sono tornato in Italia perché a breve mi sarebbe arrivata la cartolina e non volevo ancora essere cosa ero già definitivamente da tempo e sono, un disertore. La partenza per il servizio militare coincise con la malattia di mio padre. Gli avevano dato meno di un anno di vita, parecchio meno. La mia destinazione era Albenga, fanteria. Qualcuno mi disse di andare dai carabinieri e costoro mi mandarono al distretto. Al distretto mi fecero tornare con le notizie cliniche sulle condizioni di mio padre, le portai e compilammo la domanda di esonero. Dissero che tanti restavano a casa per esubero di leva, io almeno avevo un motivo serio. Dissero che non partivo e che a breve avrei ricevuto l’esonero. Ma l’esonero non giunse, mio padre peggiorava, e un giorno partii per Albenga. Il destino del disertore. Il capitano di Albenga disse che non dovevo partire, perché ero partito? Dissi va bene, allora mi dia lei l’esonero. Non poteva, disse, ora ero partito, ora mi dovevano dare il pre-congedo. Così compilai i formulari del pre-congedo, anche quello di un avvicinamento nella caserma di Diano Castello, in caso il pre-congedo avesse tardato qualche giorno in più.
Finito l’addestramento non tornai a casa, non mi avvicinarono neppure a Diano Castello, ma mi mandarono a Legnano. In pratica mi allontanarono di trecento chilometri, ero fante e ora dissero che ero bersagliere.
Era novembre e a maggio ero ancora soldato. Verso la fine del mese di maggio mi chiusero un paio di giorni in una cella nel carcere militare di Peschiera del Garda, poi mi ricoverarono nell’Ospedale militare di Baggio, reparto neuro. Quando giunsi a casa con una convalescenza di dieci giorni per gravi stati d’ansia e crisi depressive mio padre respirava con l’ossigeno, non gli parlai mai più. Morì dopo alcuni giorni. Io ero ancora soldato, ma ora non c’era fretta. Ricevetti altri giorni di convalescenza, me li davano nel reparto neuro dell’Ospedale militare di Sturla.
Tornato in caserma, il giorno prima di ritirare il congedo, o il giorno prima ancora, una di quelle sere lì, comunque, uscii dal cancello e non rientrai mai più in quella caserma.
Me ne andai anche dall’Italia, temendo che mi avrebbero cercato, lasciai l’Italia e mi fermai in Costa Brava e quando cominciò il freddo raggiunsi le isole calde, di fronte alla costa africana.
E così, ancora oggi, ogni volta che torno in Italia mi sembra di farlo da clandestino e quando me ne vado ho l’impressione di disertare di nuovo come la prima volta.
Questo scritto sta prendendo un po’ troppo una piega affollata di io e di Calvino e Biamonti non dico più nulla. È che se mi si chiede di commentare il mio paesaggio estremo, queste foto, un paesaggio senza io non va oltre la cartolina.
Siamo davvero cosa vediamo? Eppure un libro su Calvino e Biamonti e su di me non può che essere un libro sbilenco. Il paesaggio ligure di Biamonti – non ne conosco altri di suoi se non quello adriatico dell’Attesa sul mare, o il paesaggio della Provenza, che però assomiglia alla Liguria – è un invito a estrapolare il mare dal mare e incollarne il senso alle rocce, alle foglie, per dire che le cose in Liguria hanno quel tormento lì. Il paesaggio ligure di Calvino, specie quello di un libro dell’ultima parte della sua vita come La strada di San Giovanni, lo sento ben più vicino; del resto, che sciocchezza, la campagna di San Giovanni sta esattamente a metà strada tra la rupe di Biamonti e il mio carruggio di Prelà.
Cosa abbiamo in comune tutti e tre? A parte il fatto che abbiamo ereditato della terra e siamo stati figli di padri che «andavano in campagna» e ci chiedevano di seguirli per dar loro una mano, c’è in comune ben poco. Abbiamo dunque in comune il senso di colpa per non aver quasi mai dato una mano ai nostri padri in campagna? C’è questo e poco altro in comune? Di nuovo posso parlare solo per me, e ammettere che è un dolce senso di colpa quello che ti lascia addosso la diserzione. Quest’anno sono stato in America, prima in Florida e poi in California. Se mi avessero detto scegli tra una di quelle due coste e New York avrei scelto la costa, una qualsiasi, ma forse di più quella della Florida. Calvino invece si sentiva un new-yorchese a fondo. Mentre Biamonti amava la Provenza. Ecco, io, ad esempio, non ho niente contro la Provenza, ma mi ricorda troppo la terra interna delle spiagge che frequentavo da bambino perché mio padre faceva l’aiuto cuoco nei ristoranti di Saint Maxime e Saint Raphael. E mentre lui faticava io me ne stavo in spiaggia tutto il giorno a chiedere al mare perché non sapevo nuotare. Fuori posto non per la questione del mare, ma perché per la prima volta ero assente da quella zona interna che avevo imparato a chiamare Liguria. Era un fuori strano, di certo non era né la Liguria e né un fuori dentro un collegio. L’impressione della Costa Azzurra e della Provenza è quella di un pre-esilio. Di qualcosa di somigliante a un marsupio, ma esterno, se tutto questo fosse possibile. O forse solo l’oltre estremo ponente. Un Far West da varcare e di cui nutrirmi, come un litofago, individuando la roccia cosmica e amica, fino ad assorbirla, passarle attraverso… Ma in California e in Florida l’estremità è quella di un continente e la vivi molto più intensamente, dev’essere un po’ come la sentono i portoghesi. Si potrebbe parlare della differenza animale che c’è tra un ramarro ligure di grosse dimensioni e un’iguana.
Di sauri in Liguria se ne trova una specie tra le più grosse d’Europa. Si tratta della lucertola ocellata, si dice abiti volentieri a Pompeiana e sui Pirenei, nelle isole Baleari e in pochi altri luoghi, tra le pietre, nelle rughe delle montagne.
Ai piedi dei Pirenei è dove ha deciso di morire Walter Benjamin, dopo aver vissuto, qualche tempo prima, alle Baleari, e per ben tre volte aver trascorso lunghi soggiorni a Sanremo (non così distante da Pompeiana). Così, un giorno, ho deciso che lei, la lucertola ocellata e Benjamin avrebbero potuto conoscersi e popolare le pagine di un mio romanzo.
Il protagonista è un bambino che gioca al pallone in un carruggio in discesa di Sanremo, nei pressi della ferrovia. Il pallone rotola e finisce oltre i binari, il bambino vuole recuperarlo, ma non deve disubbidire all’ordine della madre: non si attraversano i binari.
Allora non gli resta altro da fare che incamminarsi accanto alle rotaie, per trovarne la fine.
Avrei voluto tentare di scrivere questo romanzo come se fosse stato di Calvino. Del resto l’idea è stata proprio sua, di Calvino: era ragazzo e ne aveva parlato agli amici, forse ai tempi in cui con gli amici si confessano i progetti letterari. Lui, ragazzo prima della guerra, senza sapere che la Sanremo della sua gioventù finita la guerra sarebbe sparita, disse che avrebbe voluto raccontare la storia di un bambino che diventa vecchio lungo i binari cercandone la fine, ma senza trovarla, fin quando, certo che i binari sono infiniti – forse anche quelli tronchi –, gli sarà chiaro che il pallone è irrecuperabile e allora tornerà a Sanremo. Ma Calvino questa storia non la scrisse e io ho pensato che qualcuno l’avrebbe potuta scrivere, come gli autori di questo libro e di queste fotografie hanno provato a leggere tra le pietre rotte di tre scrittori così diversi tra loro e nello stesso tempo provenienti dalla stessa terra.
IJmuiden, 5 marzo 2023
NdR Questo testo di Marino Magliani chiude il volume, edito di recente da Exorma, “Calvino, Biamonti, Magliani, il racconto del paesaggio, lo sguardo, la luce” con testi di Luigi Marfè, Claudio Panella, Luigi Preziosi e Fabrizio Scrivano

