Nanga Parbat
di Orso Tosco
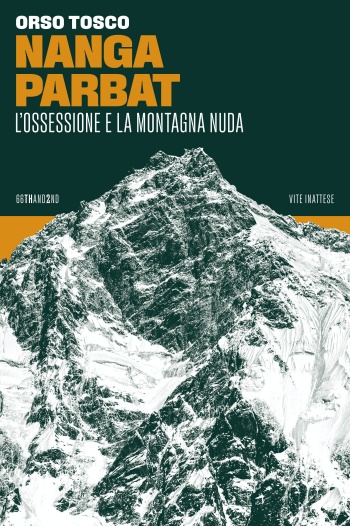
La sfida è soltanto per gli altri.
Per chi resta in attesa, aspettando impaziente le novità, controllando ansiosamente il meteo, scrutando la roccia e i ghiacci con il binocolo.
La sfida è nelle parole di chi sta per partire e di chi riesce a tornare.
Ma una volta che ci si trova lassù non esiste più alcuna sfida.
C’è qualcosa di molto più prezioso in ballo, qualcosa la cui importanza supera di gran lunga qualsiasi gara e primato da raggiungere: ci sono lo spazio e il tempo, e ci sono uomini e donne che provano a sfuggire a entrambi. Consapevoli che nessun luogo da solo può regalarci una condizione tanto innaturale, privilegiata e terrificante, non le vette degli Ottomila, non lo spazio più remoto, ma soltanto un gesto. Il gesto, puro e definitivo, quello che continuamente spinge a rischiare la propria vita e altrettanto costantemente la salva.
Bisogna immaginare una linea perfetta, tracciata mediante una lunghissima successione di plotoni d’esecuzione scansati all’ultimo secondo, quando le traiettorie mortali sembrano sul punto di ferire e uccidere. E poi bisogna immaginare quella linea capace di uno sforzo se possibile ancora maggiore, bisogna immaginarla danzare, saltare da un punto all’altro, vittima e al tempo stesso complice di ogni soffio di vento, di ogni crepa nella roccia, di ogni raggio di luce riflesso dal ghiaccio verso l’alto, come a voler sfidare i consigli della ragionevolezza, supremo oltraggio alla virtù dell’obbedienza racchiusa nella legge di gravità.
Ogni gesto deve essere feroce e materno, ragionato e viscerale. Ogni muscolo, ogni porzione di tendine e ogni lembo di pelle, l’intera estensione del fiato e lo sguardo, il coraggio, la stupidità, e qualsiasi altra qualità si possieda o si creda di possedere: tutto è chiamato a partecipare e a superare il proprio limite, metro dopo metro, minuto dopo minuto.
Come una sfida che si rinnova ad ogni battito del cuore. Più che una sfida.
Questa è l’avventura magica e mortale dell’alpinismo. Questo è l’incantesimo che unisce chi decide che la parte più importante, la parte più veritiera della propria esistenza deve svolgersi lassù, nel regno dell’intensità assoluta. Un luogo chiaramente inadatto, inospitale, che non ci prevede e non ci vuole, e che proprio per questo regala, a chi è in grado di esplorarlo, la sensazione di essere sfuggito al gioco del mondo o, forse, di aver trascorso qualche istante all’interno del suo cuore nascosto.
Quando negli anni Cinquanta l’Università di Harvard offrì a John Cage la possibilità di visitare una camera anecoica, costruita in modo da ricreare al suo interno il silenzio assoluto, il geniale compositore statunitense colse al volo l’occasione. Ma il risultato di quell’esperienza si rivelò decisamente diverso da quello che Cage si sarebbe potuto aspettare. Invece del silenzio più puro, Cage riferì al tecnico che seguiva quel progetto come da subito si fossero palesati due suoni ben distinti, uno caratterizzato da una tonalità alta, l’altro da una tonalità bassa.
«Quella alta è prodotta dal sistema nervoso in funzione,» spiegò il tecnico «quella bassa dal flusso sanguigno». Questa esperienza portò Cage a fare i conti con l’impossibilità del silenzio assoluto e lo ispirò nella composizione di 4’33, una delle sue creazioni più celebri, in cui gli esecutori sono chiamati dalla partitura a non suonare i propri strumenti, lasciando che sia il suono prodotto dall’ambiente circostante a diventare esso stesso opera d’arte, la vera composizione. Ma a giudicare dai resoconti degli alpinisti, specialmente coloro i quali prediligono le salite in solitaria, viene da pensare che Cage abbia cercato il silenzio assoluto non tanto nel luogo sbagliato – la camera anecoica è acusticamente perfetta per il suo scopo – quanto piuttosto con la «predisposizione» errata. Per ottenere il silenzio assoluto sono necessari elementi che poco hanno a che fare con l’acustica: elementi come la fatica, il gelo, il pericolo, l’esaltazione e la disperazione, il vento, la linea del vuoto, la precarietà del ghiaccio.
Generalmente non è descrivendo il raggiungimento della vetta che agli alpinisti capita di citare il silenzio, quanto piuttosto nel resoconto dell’ascesa o della discesa, ovvero nei momenti più intensi e delicati: è allora che il silenzio assoluto fa capolino. E non viene prodotto dalla negazione di qualsiasi spettro acustico, bensì dalla tensione – insostenibile eppure in qualche modo sostenuta – racchiusa in quei gesti che per non diventare mortali esigono perfezione assoluta.
Osservando e ripercorrendo le imprese degli esploratori e degli alpinisti, è normale se non inevitabile domandarsi cosa li spinga a rischiare la vita arrampicandosi su pareti di roccia e ghiaccio. Cosa li spinga a cercare nuove vie o a ripercorrere quelle più esigenti, a trascorrere giorni e notti in situazioni estreme. Alcuni affermano che è il risultato dell’amore per la libertà e per l’assoluto, il desiderio di vivere una natura meno depredata. Altri, malevoli, sostengono che si tratti di un’ossessione fomentata da una forma smisurata di arroganza e ambizione, che spinge a esaltare la vita in una forma assurda, mettendola a repentaglio in modo apparentemente gratuito.
Come spesso accade, ogni risposta è sbagliata o parziale, ma nondimeno ospita al proprio interno un frammento di verità. Si può ben dire che la montagna, e la sua indagine più spericolata, l’alpinismo estremo, siano capaci di stregare indissolubilmente uomini e donne ai quali, in cambio, concedono momenti in cui la vita è più accesa, più intensa.
Al pari dei mistici, i cui occhi segnati dal bagliore passeggero della grazia inseguono la sua scia in un mondo di ombre, gli esploratori delle vie più impervie, dopo aver assaporato porzioni di vita al di fuori del tempo e dello spazio, le ricercano con l’ostinazione concessa soltanto agli amanti.
L’ossessione, infatti, è la forma d’amore più pura. La meno ragionevole, la più invivibile, ma anche l’unica in grado di modificare esistenze apparentemente consolidate in un battito di ciglia. E come tutte le forme d’amore più pure, è così intensa da risultare contagiosa.
Immaginiamo quindi la grande alpinista Alison Hargreaves mentre scala la parete nord dell’Eiger, il monte svizzero con cui tutti i grandi scalatori si sono cimentati, e immaginiamola incinta di sei mesi. Ai più una scena di questo tipo rischia di fare paura, persino orrore. Si tratta di una persona non soltanto disposta a rischiare la propria vita, ma pronta a mettere a repentaglio persino quella del proprio figlio non ancora venuto al mondo. Questa è una possibile, ragionevole chiave di lettura. Ma, trattandosi di una storia d’amore e di ossessione, è anche la risposta errata.
Abbiamo a che fare con una grande alpinista, la prima donna ad aver scalato il monte Everest in solitaria e senza l’ausilio di bombole d’ossigeno, e dunque sarebbe sbagliato percepirla come una persona che sta mettendo a rischio la propria vita mentre tenta di farsi strada lungo la ripida e insidiosa parete nord dell’Eiger; al contrario, dovremmo immaginare Alison come una creatura nel proprio ambiente ideale, intenta a compiere una serie di gesti impegnativi e perfetti, puri e decisivi, gli unici che possono consentirle di ottenere quella vita più pura e intensa che tutti quelli come lei inseguono.
E c’è forse qualcosa di più bello, e alto, che immaginare di poter condividere questa magia insieme a chi già abita il nostro corpo? Soltanto un’alpinista in gravidanza può sperimentare una sensazione del genere, e soltanto il figlio di una alpinista potrebbe tentare di decifrarne le conseguenze.
A noi, dall’esterno, resta soltanto da analizzare i dati in nostro possesso. Possiamo leggere la vita di Tom Ballard, il bambino che Alison portava in grembo quel giorno, come già iniziata ancor prima di emettere il primo vagito nella sala d’ospedale.
Già, ma la vita di Tom era iniziata, o forse era segnata? Come va interpretato quel gesto di amore e condivisione compiuto da Alison Hargreaves? È stato il regalo più grande, o al contrario una imposizione – come a voler tracciare la linea da percorrere non soltanto per sé stessa, ma anche per suo figlio?
Nuovamente, la risposta non può che comprendere entrambe le possibilità, e forse molte altre ancora. Questo non perché sia più semplice rifugiarsi nella vaghezza, ma poiché ha ragione Saba, quando afferma che «d’amore non esistono peccati, esistono soltanto peccati contro l’amore» per poi concludere aggiungendo: «e questi no, non li perdoneranno».
Noi non siamo giudici, a noi non spetta perdonare o condannare nessuno, però possiamo, dobbiamo permetterci di affermare che quella decisione di Alison Hargreaves di scalare la parete nord dell’Eiger con il figlio Tom in grembo non fu un peccato contro l’amore.
Fu un gesto d’amore.
E se ogni gesto d’amore è anche e soprattutto un gesto generatore, allora è una condanna alla finitezza, contiene inscritta all’interno un’avvisaglia della propria stessa fine. Non si dona l’amore, e quindi la vita, senza imporre anche la morte. Soltanto ciò che resta protetto nel nulla precedente e successivo alla vita possiede il diritto a preservarsi fuori dal tempo, in uno dei tanti infiniti possibili.
E chissà se Alison Hargreaves avrà mai avuto occasione di leggere i ricordi di Jung, e in special modo quel passaggio in cui il capo indiano pueblo di Taos gli domanda: «Non pensi che tutta la vita venga dalle montagne?». Probabilmente no, e probabilmente non ne ha avuto bisogno. Quella stessa verità deve averla intuita da sola, studiando il profilo e la composizione delle montagne, e meravigliandosi per come fossero in grado di far convivere qualità eterne e immutabili insieme a mutamenti repentini e incessanti.
Forse Alison ha perfino avvertito una strana forma di sorellanza con quelle creature aliene, molto più antiche del linguaggio, e potrebbe aver concluso che, nonostante la loro infinita pericolosità e un’apparente indifferenza, non esistesse luogo migliore per cercare rifugio dalla dittatura del tempo. Dove, se non all’interno di una montagna, dormono per secoli i Sette Dormienti di Efeso e i santi musulmani?
Nonostante il pericolo incessante e l’ambiente inospitale, la montagna rappresenta una figura che genera e protegge la vita. Ma gli alpinisti o, per meglio dire, gli esploratori non si accontentano di contemplarla. Loro salgono dove è quasi impossibile salire, o strisciano e penzolano quando non è possibile camminare, si appendono dove non c’è quasi altro che vuoto e oltre quel vuoto si lanciano, quando i ponti sono crollati e il ghiaccio precipita a strapiombo come il verso lontano degli animali, che mai e poi mai azzarderebbero quelle altezze assassine in cui l’ossigeno diventa rarefatto, vago come un sogno incomprensibile e crudelmente necessario.
I protagonisti di questa storia non sono martiri e nemmeno suicidi, tuttavia ricercano l’asprezza della montagna, hanno bisogno di percorrerla rischiando, di attraversarla sfruttando passaggi in cui l’esplorazione e la violazione si intrecciano e si confondono.
«Conquistatori dell’inutile»: questa la celebre definizione che Lionel Terray diede degli alpinisti, e quindi di sé stesso, essendo a sua volta uno dei più grandi alpinisti di sempre. Ed è una definizione che fa subito pensare alla filosofia zen, alla cui base c’è il culto dell’azione inutile. Ma se nello zen viene coltivato l’agire senza alcuna intenzione, l’alpinismo – il tipo particolare di esplorazione di cui l’alpinismo si occupa – poggia invece sempre su di una intenzione. Nasce dall’intenzione. Gli alpinisti, come i giocatori di biliardo arrivati all’ultimo colpo, sono chiamati ad annunciare i loro azzardi in anticipo. Prima dell’avventatezza e del coraggio vi è lo studio, la preparazione. Prima del contatto con roccia e corde, le dita sfogliano fotografie e mappe. Tutti i nodi ancorati e tutti i dadi inseriti nelle fessure della pietra hanno origini lontane, si nutrono dei tentativi riusciti e dei fallimenti che li hanno preceduti, per poi andare oltre, per poi superarli grazie a sangue nuovo, che porta con sé nuove intuizioni e nuove visioni. E in alcuni casi, inevitabilmente, nuovi sbagli, nuove lezioni che si pagano con la vita.
C’è una montagna che più di tutte le altre esercita un’attrazione irresistibile sugli alpinisti, nonostante la drammatica facilità con cui vi si rischia la morte. Quella montagna è il Nanga Parbat.
La Montagna Nuda, la Montagna Mangiauomini, la Montagna del Diavolo.
È lei la vera protagonista di questa storia, la calamita che fa convergere su di sé storie che hanno origini geografiche e temporali distanti tra loro.
Nanga Parbat. Ragione di vita e ragione di morte. Un miraggio di 8126 metri di roccia e ghiaccio nel Kashmir, in Pakistan. Il luogo in cui Tom Ballard finisce di ripercorrere quella linea tracciata per lui da sua madre trentuno anni prima, trovando la morte in compagnia di Simone Nardi sullo sperone Mummery.
Per provare a raccontare la storia di Tom, per ripercorrere la sua esistenza la cui scarsa durata è compensata da una intensità fuori dal comune, abbiamo tuttavia bisogno di uno slancio, dobbiamo prendere una lunga rincorsa e tornare indietro nel tempo. Ad Albert Mummery e alla sua epoca, la fine dell’Ottocento. E ancor più precisamente alla sua ultima spedizione, quella del 1895, che finì per legare indissolubilmente il nome di questo alpinista e gentiluomo inglese allo sperone su cui, centoventiquattro anni dopo, Tom Ballard e Simone Nardi perderanno la vita.
NdR Questo testo è il prologo del libro di Orso Tosco Nanga Parbat, pubblicato di recente da 66THAND2ND

