“Privati di Napoli. La città contesa tra beni comuni e privatizzazioni”. Introduzione
[Per Castelvecchi è appena uscito Privati di Napoli. La città contesa tra beni comuni e privatizzazioni di Alessandra Caputi e Anna Fava, prefazione di Tomaso Montanari. Ne pubblico l’introduzione. ot]
di Alessandra Caputi e Anna Fava
Nella città di Napoli convivono, fianco a fianco, modelli urbani molto diversi tra loro. Le aree situate a Occidente e a Oriente hanno le sembianze spettrali di una città postindustriale che non è ancora riuscita a ripensare la propria identità. Una parte molto estesa del territorio è gravemente compromessa sotto il profilo ambientale, urbanistico e sanitario: le attività industriali hanno lasciato alle proprie spalle macerie e inquinamento. Circa un decimo dell’intero comune, che si estende su una superficie di 11.900 ettari, rientra tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche. Le aree contaminate occupano complessivamente un’area di oltre 1.200 ettari: zone deindustrializzate mai risanate, discariche abbandonate al degrado ambientale, aree di sacrificio che languono nell’attesa di una nuova speculazione. Tutto ciò che non è funzionale al profitto resta immobile, recintato, si tramuta in rovine. Nel centro storico, invece, la recente accelerazione dell’industria turistica, avvenuta a seguito dell’avvento di piattaforme digitali per le case-vacanza come Airbnb e Booking, ha innescato un rapido processo di estrazione di valore economico. La persistenza di forme di vita tradizionali e l’assenza di marcati processi di gentrificazione hanno reso appetibili le case del centro, da sempre abitate da un mix sociale che comprende anche le fasce sociali economicamente più fragili; grazie ai prezzi più bassi rispetto ad altri quartieri della città, esse sono diventate l’infrastruttura chiave di una crescita turistica incentrata sulla ricerca di esperienze “autentiche”. Ciò ha innescato un incremento dei valori immobiliari, che, a sua volta, ha aumentato la rendita, attirando maggiori investimenti.
Anche il patrimonio culturale della città, ormai associato «al disimpegno e al divertimento»[1], è considerato unicamente come strumento di marketing territoriale. Dalla concessione di piazza Plebiscito a Ferrero per la festa della Nutella, alla promozione pubblicitaria di un fantomatico “brand Napoli” per attirare flussi turistici, fino alla recente, pericolosa idea di affidare il patrimonio culturale alla gestione di una fondazione, il patrimonio è adoperato come attrattore turistico. Il binomio “cultura-turismo”, cioè “cultura-economia”, ha soppiantato quello “cultura-cittadinanza”, in un clima di accondiscendenza acritica, in cui chi osa contestare è tacciato di arretratezza e ostilità al progresso. In pochi continuano a ribadire la funzione civile e politica della cultura e la centralità del pubblico.
Interrogarsi sullo stato del patrimonio e sulla sua funzione, sullo stato dell’ambiente, dei servizi pubblici, del verde, della città e dei suoi quartieri significa interrogarsi sullo stato della democrazia. È con questo spirito che qui cercheremo di tratteggiare le vicende di alcuni quartieri di Napoli e del suo patrimonio ambientale e culturale, con l’intento di fornire spunti utili per un’indagine ad ampio raggio che tocchi questioni relative a debito pubblico e dismissioni, scommesse finanziarie e commissariamenti, mancate bonifiche, turistificazione del centro cittadino e privatizzazione delle acque marine: processi accomunati da un’idea di spazio urbano come luogo chiave della produzione biopolitica del capitalismo contemporaneo. A questo modello, in cui a disegnare la forma delle nostre città è la mano invisibile del mercato, esiste un’alternativa. Negli ultimi anni, nella città di Napoli sono sorti nuovi movimenti di partecipazione civica legati al movimento per i beni comuni, iniziato a Roma con l’occupazione del Teatro Valle. Sulla scia dell’esperienza romana, i protagonisti di quella napoletana hanno rivendicato come bene comune, insieme all’acqua pubblica, anche una parte del patrimonio comunale dismesso o semiprivatizzato, creando spazi di mutualismo, condivisione e autogoverno aperti all’intera città, funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali. Una congiuntura politica favorevole ha consentito di istituzionalizzare questo processo in seno al pubblico, creando, negli interstizi di una macchina politica troppo spesso autoreferenziale e incapace di comprendere le energie vive della città, processi avanzati di «democrazia di prossimità»[2](face to face democracy, come la definisce Murray Bookchin). La nascita di beni comuni, consulte, assemblee pubbliche, osservatori civici ha irrorato il tessuto democratico di linfa vitale. Queste nuove istituzioni hanno segnato la riscoperta di un valore dell’urbano che si oppone al modello capitalistico del profitto e alla governance neoliberale fondata sull’individualismo competitivo[3]. Esse, al contrario, rappresentano una manifestazione concreta dell’idea di bene comune come fondamento della vita collettiva, della democrazia, dell’uguaglianza, della cultura, della libertà[4]. Un’idea che dovrebbe riprendere a guidarci e a illuminare le nostre città.
Note
[1] Tomaso Montanari, A cosa serve Michelangelo, Einaudi, 2011, pp. 8-10.
[2] Mauro Pinto, Luca Recano, Ugo Rossi, New institutions and the politics of the interstices. Experimenting with a face-to-face democracy in Naples, «Urban Studies», anteprima online sul sito journals.sagepub.com, 1° maggio 2022 (https://bit.ly/3IMGNNb).
[3] Ugo Rossi, Il centro storico di Napoli e il valore urbano conteso: Turistificazione, beni comuni, innovazione, in Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano (Padova, settembre 2021), pp. 4-5.
[4] Salvatore Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Einaudi, 2012.
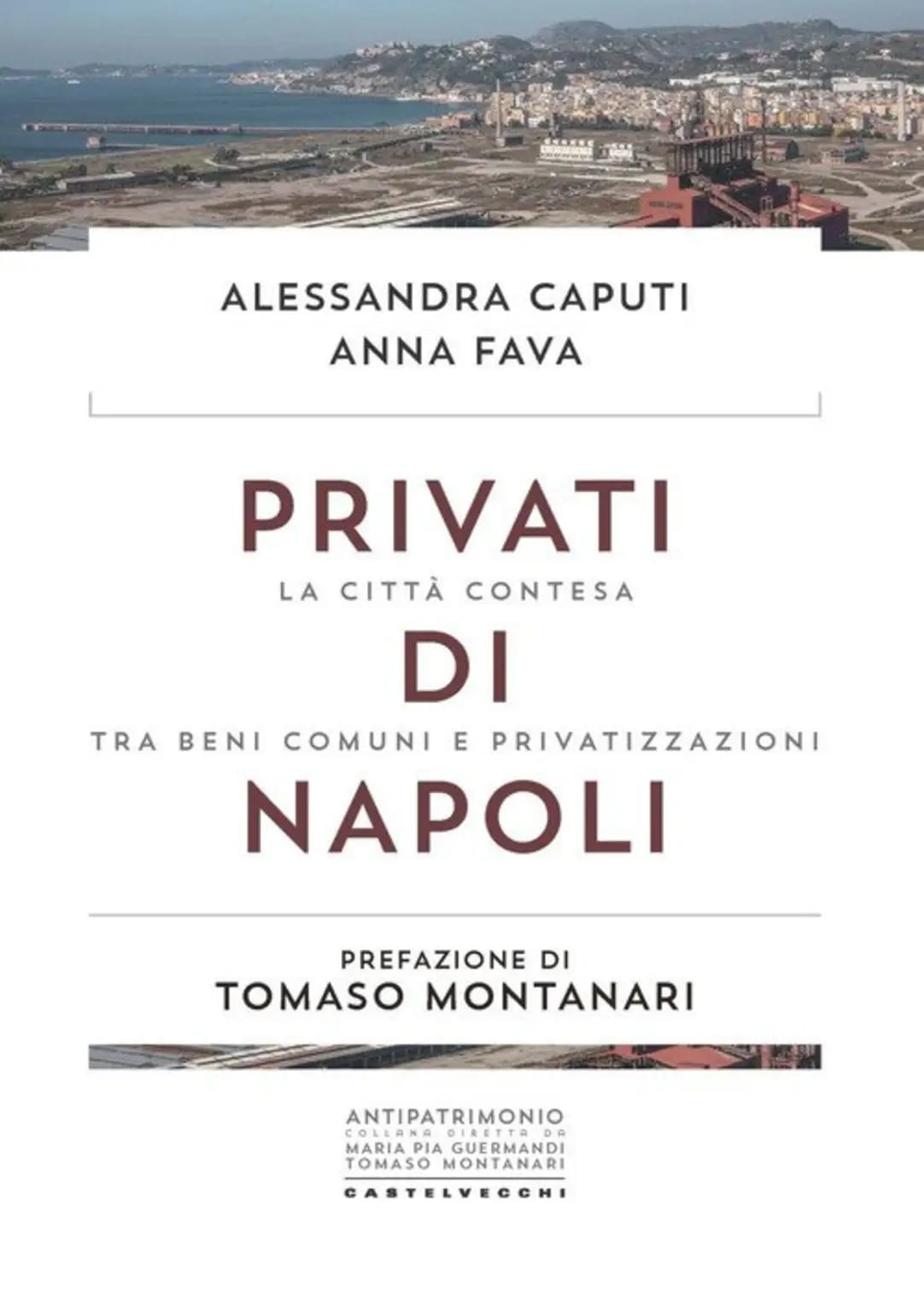
I commenti a questo post sono chiusi


Anche se a qualcuno può non piacere, l’individualismo competitivo è l’unica soluzione per progredire davvero ed il libero mercato è l’unica molla che può riqualificare un territorio insieme ad una rigorosa applicazione del codice penale, spesso assente per falso buonismo. La dimostrazione sta proprio nelle aree degradate che tali restano perché in Italia spesso è impossibile investire confidando in un giusto profitto. I modelli da seguire a mio avviso non sono le occupazioni proletarie di Roma bensì Paesi come gli Emirati Arabi o, per restare in Europa, il Principato di Monaco. In quei posti, guarda caso, il degrado non esiste!