Al cospetto dell’angelo. Tre libri su Benjamin
di Ludovico Cantisani
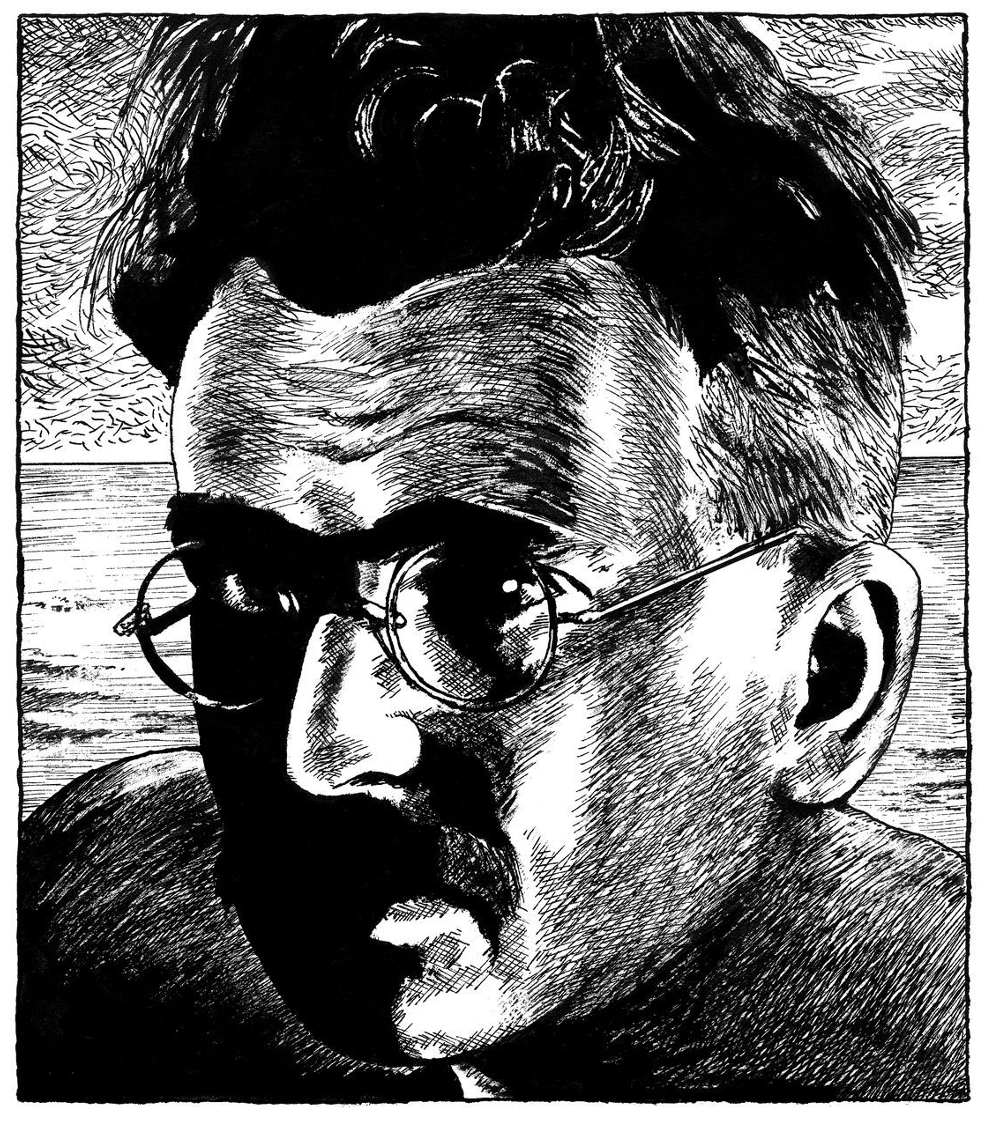
Nato nel 1892 a Berlino e morto nel 1941 lungo la frontiera spagnola, Walter Benjamin è un pensatore unico, e per parecchi motivi diversi: uno fra i tanti, la straordinaria molteplicità dei suoi scritti, al tempo stesso kafkianamente inconclusi e frammentariamente densissimi. Addentrandosi nella costellazione Benjamin non si tarda ad avvertire la sensazione che i passaggi più fertili, i movimenti più folgoranti del suo pensiero, si trovano soprattutto nelle note a piè di pagina, negli appunti mai ordinati, nelle intuizioni lasciate a latere della sua corrispondenza privata. Il suo carteggio con Gershom Scholem, pubblicato in Italia da Adelphi sotto il titolo di Archivio e camera oscura, ha le carte in regola per essere uno dei più begli epistolari del secolo scorso, certo il più rappresentativo dello stato della cultura ebraica nell’imminenza del nazismo.
Non può essere una coincidenza se, nell’ultimo periodo, Walter Benjamin è tornato “di moda”, con un profluvio di nuove pubblicazioni e trattazioni come non se ne vedevano da anni. A differenza che per Carl Schmitt, questa congiuntura si può spiegare solo in parte con l’avvento del Coronavirus: vero è che una delle più profonde intuizioni di Benjamin sancisce così, “che tutto vada avanti come prima è la vera catastrofe”, e giustamente la si è rievocata nei primi mesi di lockdown; ma se il fantasma di Schmitt è stato esplicitamente e surrettiziamente ripreso anche per contrastare le dinamiche da “stato di eccezione” rese necessarie della pandemia, il mormorio di Benjamin, su Benjamin è meno retorico, più laterale, liminare, ben più fecondo delle polemiche televisive dell’intellettuale contestatario di turno. Per non farci mancare nulla, ai primi di novembre al Teatro India di Roma è andato in scena anche uno spettacolo ispirato a Benjamin, L’angelo della storia di Sotterraneo, piacevolmente frammentario, monadistico.
C’è una Benjamin reinassance, o questo Privatdenker non era mai scomparso dai nostri scaffali, dal nostro orizzonte mentale? Fatto sta che solo nell’ultimo anno, in Italia ci sono state tre notevoli pubblicazioni critiche sul meno sistematico dei pensatori tedeschi: il Dossier Benjamin del grande teorico americano Frederic Jameson, edito da Treccani Libri; la riedizione, a cura di Ombre Corte, del Segnalatore d’incendio di Michael Löwy, incentrato sulle Tesi sul concetto di Storia; e il terzo volume del Manifesto Incerto di Frédéric Pajak, Ezra Pound chiuso in gabbia, la morte di Walter Benjamin, memorabile ripercussione della storia del pensiero europeo del secolo scorso che intreccia testo e disegno, la cui pubblicazione in Italia è in corso d’opera presso L’orma.
Perché Benjamin si presta così drasticamente alla (meta-)letteratura critica? Evidentemente perché la sua filosofia – ma è giusto chiamarla così? – tuttora appare come un discorso spezzato, con cui si fa forte la tentazione di riprendere il dialogo. In vita, Benjamin in fondo non ha mai scritto un libro propriamente detto, un vero volume a sé stante – ancor più paradossale quindi il profluvio di pubblicazioni, accademiche o divulgative, sul suo conto. Tutti e tre questi libri su Benjamin colpiscono per la loro notevole originalità di lettura – e ciascuno dei tre elegge un prisma diverso, un sentiero autonomo lungo cui incamminarsi per affrontare le curiose architetture del pensiero benjaminiano. Come scrive il curatore Massimo Palma nella presentazione del Dossier Benjamin, “in pochi, prima di Jameson, hanno davvero visto in Benjamin un teorico rigoroso, acuto, inquieto, di quell’interrogativo aperto che oggi chiamiamo democrazia”.
***
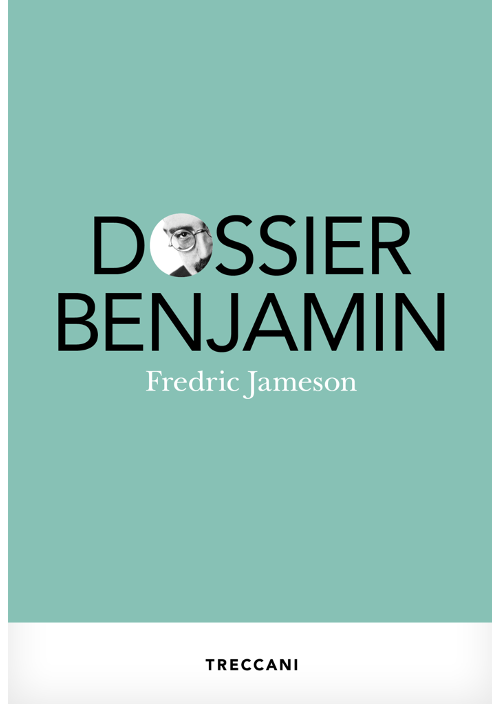
In una vita vissuta tutta all’ombra della nomadismo e della catastrofe, sotto l’insegna dei vari totalitarismi che si affacciavano in Europa, inseguendo per decenni il fantasma di una fuga impossibile verso terre promesse come gli Stati Uniti o l’Israele sionista, Walter Benjamin appare tuttora come uno dei più lucidi analisti e critici di quella democrazia occidentale che nemmeno fece in tempo a vedere, sorta in un mondo reduce dal nazismo e dal comunismo, ma non dal capitalismo. “L’individualismo borghese sembra raggiungere il suo apogeo con la scomparsa degli individui stessi”, rimarca Jameson nel suo Dossier parlando (anche) per Benjamin. L’attenzione del pensatore tedesco per le metropoli non si limita alla sola, notoria Parigi dei passages: “Berlino può essere raccontata solo attraverso i suoi oggetti, una città spettrale che può essere davvero vista solo ricorrendo alla prospettiva del bambino”; e Napoli, che Benjamin visitò assieme ad Asja Lacis e a Theodor Adorno, appare ai suoi occhi come incarnazione di una “vita pre-borghese, giustapposta alla vita post-borghese della Mosca sovietica”.
Nel suo Dossier, Jameson cerca di smarcarsi da alcune categorie critiche fin troppo applicate alla prosa e al pensiero di Benjamin, o perlomeno di coglierle attraverso prospettive inedite. La concezione stessa di Benjamin come flâneur, concetto ripreso, a detta di Jameson erroneamente, dall’immaginario baudelairiano, si lega fino in fondo alla sua biografia, alla forte miopia che affliggeva il filosofo, costringendolo a scrutare le cose da molto vicino – un tratto, evidenzia Jameson, che lo accomunava a Nietzsche e anche a Joyce. Jameson invita inoltre a fare molta attenzione nell’affibiare a Benjamin l’etichetta di modernista, perché i termini come “moderno”, “modernità” o “modernismo” erano da lui ripresi soprattutto dalla letteratura di Baudelaire, da lui più volte indagata. “Benjamin possedeva senz’altro quel tratto tipico della feticizzazione modernista di tutto il che è nuovo, e lo sperimentalismo lo interessava molto”, rimarca Jameson, “ma la sua ostilità per l’estetica e l’estetizzazione gli precludevano quello che convenzionalmente consideriamo essere stato il telos del modernismo, così come lo troviamo in sequenze che vanno da Manet e gli impressionisti fino a Cézanne, da Mallarmé o Pound fino a Olson o Ashbey”.
Più che ad una estetizzazione, nella sua personalissima idea di rivoluzione culturale Benjamin puntava a una vera e propria politicizzazione, e non solo dell’arte, ma della vita tout court: bisogna rileggere bene il saggio sull’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, suggerisce lo studioso… E proprio partendo dall’idea più celebre di quel saggio benjaminiano, la perdita dell’aura provocato dall’avvento del cinema e delle altre forme di arte “industriale”, Jameson cerca di trovare alternative e nuove vie in “momenti come quelli dei festival del cinema, che recuperano le molteplicità del cinema internazionale e mettono in mostra i prodotti di industrie cinematografiche minori, potrebbero senz’altro essere i luoghi dove esiste un’aura di tipo nuovo”.
“Benjamin ha cercato di usare la storia per trovare una soluzione alla storia”, è questa la chiastica conclusione di Jameson, che conclude il suo saggio ricordando il finale beffardo del Dottor Stranamore kubrickiano. Lo stesso Angelus Novus di Klee, eletto a Benjamin a suo personalissimo angelo della Storia, si fa portavoce di una chiliastica, paradossale apocalisse salvifica: “sarebbe un errore concludere che le ali dell’angelo, aperte come un ombrello rotto rovesciato dai venti di una bufera, stiano a significare ‘la fine della storia’. L’immagine, piuttosto, esprime l’esperienza della sconfitta, ponendo domande senza risposta su quale sarebbe il modo giusto di ricevere l’emozione messianica, ovvero la speranza”. La salvezza c’è per gli altri, non per noi, mormorava Kafka, echeggiava Benjamin.
***
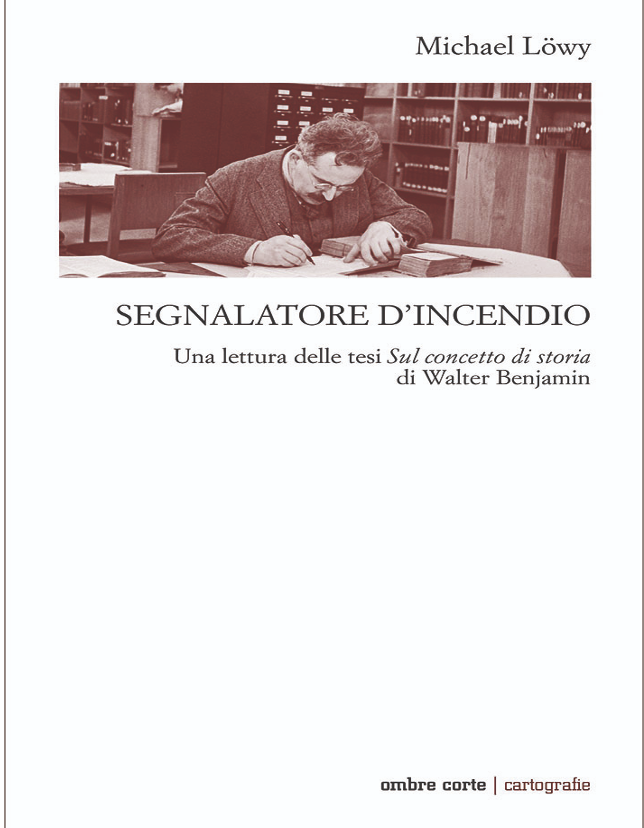
Non per nulla è (anche) un kafkiano, l’autore di Segnalatore d’incendio, altro saggio benjaminiano recentemente portato in Italia da OmbreCorte, un editore che peraltro sin dal nome si fa all’immaginario del pensatore tedesco e, nello specifico, a una raccolta dei suoi scritti di fine anni venti. Franco-brasiliano, classe 1936, Michael Löwy è uno dei più originali sociologi della Sinistra contemporanea. Oltre che di Benjamin, al quale aveva dedicato in passato la raccolta di scritti La rivoluzione è il freno di emergenza, e di Max Weber, Löwy si è cimentato anche con la figura di Franz Kafka sognatore ribelle (elèuthera, 2014), una delle più originali interpretazioni recenti dell’immaginario dello scrittore praghese, a sua volta debitrice della pionieristica lettura che di Kafka aveva dato Benjamin ad appena dieci anni dalla morte dell’autore de Il Castello. Una prevedibile costellazione, per dirla con Benjamin.
La scuola materialistica, rappresentata da Brecht, definisce Benjamin un marxista che si esprime per metafore. La scuola teologica, rappresentata da Gershom Scholem, vede in Benjamin un teologo cifrato, in cui il marxismo è mero linguaggio, mai contenuto. La scuola della contraddizione, propugnata da Habermas, soprattutto, ritiene che Benjamin tentò e fallì nel conciliare ebraismo e marxismo, materialismo e messianesimo: dittici di un’incompatibilità radicale. Di fronte a queste tre, grandi linee critico-interpretative del pensiero di Benjamin, Michael Löwy propone una quarta via, affermando che Benjamin fu in maniera unica e coerente un marxista e un teologo, un Giano bifronte, con un volto rivolto a Mosca, l’altro indirizzato verso Gerusalemme.
Segnalatore d’incendio di Löwy, che trae il suo titolo da un passaggio di Strada a senso unico, si articola come un lungo commentario delle Tesi sul concetto di storia. Una prima sorpresa c’è già nelle prime pagine, quando Löwy rivela di aver scoperto, tra gli appunti inediti di Gershom Scholem custoditi presso l’Università ebraica di Gerusalemme, delle analoghe Tesi sul concetto di giustizia mai pubblicate, redatte da Scholem e datate tra il 1919 e il 1925, che rappresentarono un’indubbia influenza, a detta di Löwy, sull’ultimo testo che Benjamin scrisse, in fuga dal nazismo due decenni più tardi.
Mosso dalla convinzione che “i concetti di Benjamin non sono astrazioni metafisiche, ma si riferiscono a esperienze storiche concrete”, Löwy non esita a illustrare e ad accostare alcuni passaggi delle Tesi benjaminiane a specifici momenti della storia recente del Sud America, fino a vagheggiare un’influenza del pensatore tedesco sulla Teologia della Liberazione. La quindicesima delle Tesi di Benjamin ricordava che, durante la Rivoluzione di luglio 1830, “avvenne che in più punti di Parigi, indipendentemente e contemporaneamente, si sparò contro gli orologi dei campanili”, agli occhi di Benjamin simbolo di una deflagrazione, apocalittica e grandiosa, del tempo lineare, con la sua vuota omogeneità. Ecco, ci fa sapere Löwy, quando in Brasile il governo istituì delle celebrazioni ufficiali per festeggiare il cinquecentesimo anniversario della “scoperta” del paese da parte dei conquistador portoghesi, con tanto di maxi-orologio per fare il countdown sponsorizzato da una rete televisiva locale, un gruppo di indigeni tirò le frecce contro il quadrante. Molto più dei dati statistici relativi alle pubblicazioni accademiche o editoriali sul filosofo, sono questi episodi a confermare la ferrea attualità di Benjamin. E, per inciso, non si riflette mai abbastanza sulle assonanze tra le concezioni della storia propugnate in contemporanea da Benjamin e da Marc Bloch, e sull’influenza che lo stesso Benjamin potrebbe aver avuto su certi modelli a venire di storiografie “minoritarie”, capeggiati, almeno in Italia, dalla ricerca di Carlo Ginzburg.
Dei tre interpreti benjaminiani di cui stiamo parlando Löwy è sicuramente il più politico, politicizzato, ma la sua lettura di Benjamin, che a raggiera dalle Tesi sul concetto di storia arriva a sfiorare grossomodo tutti i punti salienti dell’opera omnia del pensatore, è di una chiarezza cristallina, che fa luce anche su risvolti poco considerati del pensiero del tedesco. Löwy, che giustamente evidenzia anche l’influenza del Romanticismo tedesco su Benjamin, ci fa scoprire anche le riflessioni di Benjamin sull’Anticristo, ovviamente da lui identificato, negli ultimi anni della sua vita, con il Terzo Reich nazista. “In un momento di supremo pericolo si presenta una costellazione di salvezza che collega il presente al passato. Un passato in cui brilla, malgrado tutto, nell’oscura notte del fascismo trionfante, la stella della speranza, la stella messianica della redenzione, la scintilla dell’insurrezione rivoluzionaria”. Così Löwy parafrasa il concetto benjaminiano di costellazione: il passato che salva il presente e consente il futuro, senza alcun vezzo dialettico, in nome di una speranza che scardina il presente.
***
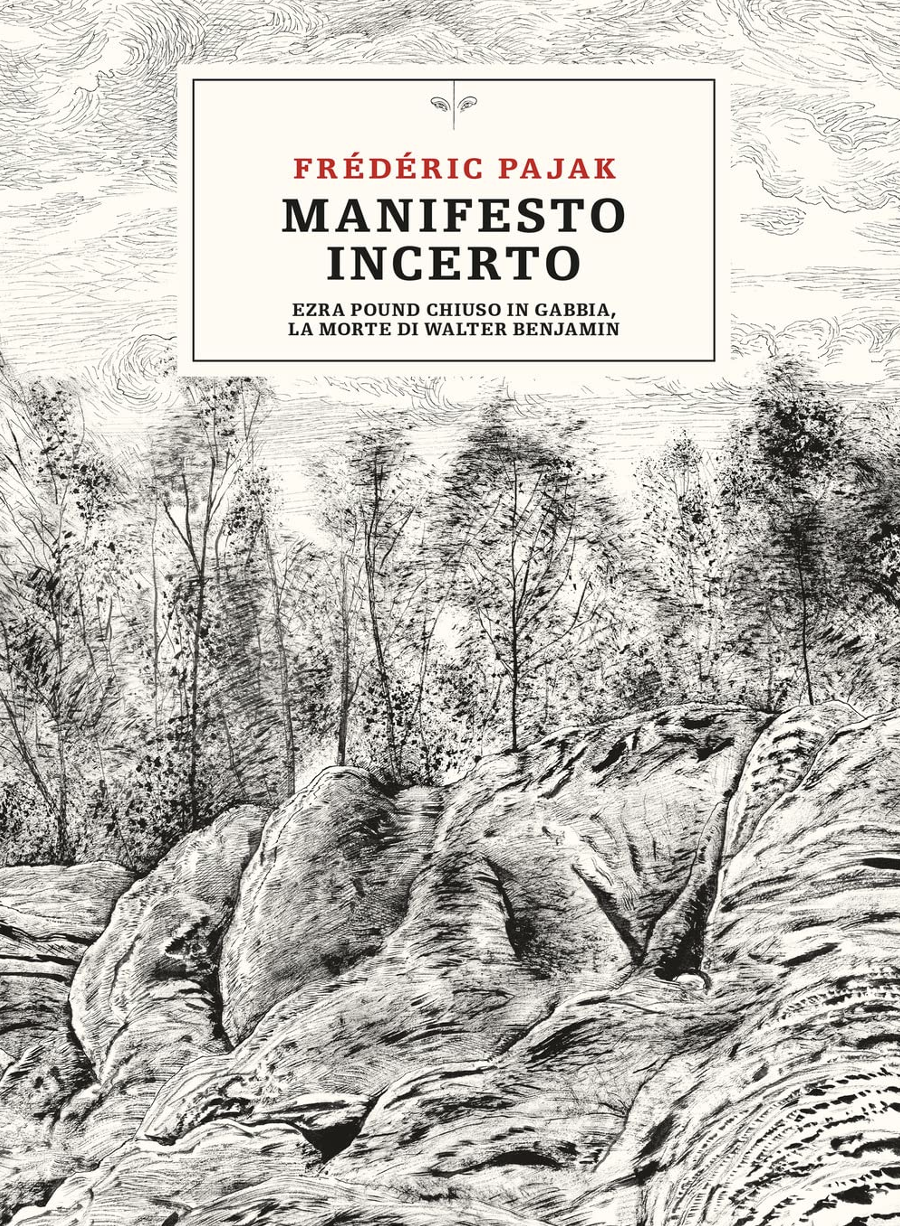
“Noi siamo, nostro malgrado, gli eredi delle ideologie del Novecento. Ne siamo gli ospiti inebetiti, languiamo nel rifiuto delle loro illusioni ancora tiepide. Non vogliamo accogliere nulla di questi convincimenti marci, perché conosciamo benissimo la devastazione che hanno generato”. Dietro queste parole, che Frédérick Pajak colloca al centro del suo terzo Manifesto Incerto, riecheggia l’antico detto nietzschiano: è difficile essere eredi. “L’ideologia moderna nega di essere un’ideologia. Si sforza di apparire sgombra di qualsiasi carattere ideologico, e riesce a fingerlo davvero. Contrariamente al cristianesimo e ai totalitarismi, si esonera da squilli di tromba e terrori. Non si costringe né a pregare né a tacere. Si insinua ovunque, in ogni minuscola cosa”. Rispetto al secolo scorso, al di là della secolarizzazione e del crollo delle ideologie, c’è un essenziale cambiamento di prospettiva temporale. “Il futuro: ricordiamoci che le ideologie del Novecento hanno provato in ogni modo ad accantonare il presente per dimenticarsi nella promessa di un futuro necessariamente migliore, necessariamente radioso. Oggi il futuro è prima di tutto una minaccia, un mondo malvagio e pericoloso che dobbiamo rimuovere. E per far ciò basta gettarlo nell’oblio. Una volta dimenticato il futuro allora si potrà dimenticare anche il passato”.
Manifesto Incerto di Frédérick Pajak è un polittico di difficile collocazione: Emanuele Trevi ha definito la serie come “una delle imprese artistiche più originali e illuminanti del nostro tempo”, il Nouvel Observateur l’ha salutata come l’invenzione o reinvenzione del “saggio grafico”. Annunciata come “l’impresa letteraria di una vita”, l’intreccio di esistenze, parole, schegge autobiografiche ed immagini di grandi figure dell’arte e del pensiero del XIX e del XX secolo, già i due precedenti volumi di Manifesto Incerto editi in Italia da L’orma vedevano Benjamin tra i massimi protagonisti: il primo si (sotto-)titolava Con Walter Benjamin, sognatore sprofondato nel paesaggio, e prendeva le mosse da un viaggio di Benjamin ad Ibiza; il secondo Sotto il cielo di Parigi con Nadja, André Breton, Walter Benjamin, e rievoca, fra le altre cose, l’esilio parigino di Benjamin e il suo rimpianto della Parigi dell’Ottocento, da lui definita “capitale del XIX secolo”.
Manifesto Incerto. Ezra Pound chiuso in gabbia, la morte di Walter Benjamin, il terzo numero di questa fantomatica rubrica, procede nella carrellata novecentesca di Pajak a passo serrato, introducendosi nei due decenni più rovinosi di tutta la storia occidentale. I due principali fantasmi evocati, il poeta che sprofondò volontariamente nel nazismo e il filosofo che ne fu barbaramente risucchiato, si intrecciano nuovamente con riferimenti autobiografici di Pajak, e con riflessioni generiche come quella riportata di sopra.
Il ritratto di Benjamin che traccia la penna di Pajak non può fare a meno di evidenziare le paradossalità di cui furono imbottiti i suoi ultimi anni. Testimoniò un compagno di prigionia, che aveva conosciuto il pensatore quando, subito dopo lo scoppio delle ostilità tra la Francie il Terzo Reich, l’apolide Benjamin era finito in un campo di internamento per rifugiati: “mai la tragicità del conflitto tra pensiero e azione mi è parsa così chiara come in quell’uomo che, da marxista, cercava esattamente di realizzarne l’unione, e mai ho visto fallire altrettanto dolorosamente un metodo che, nella sua amabile ignoranza della vita, credeva di poter cambiare la realtà, quando invece si limitava a interpretarla e inseguirla zoppicante”. Con fare accorato eppure ironico, Pajak racconta così episodi al margine del grottesco, come la fallimentare fuga di Benjamin e dello psichiatra Fritz Fränkel che, corrompendo le guardie portuali, avevano provato a travestirsi da marinai per imbarcarsi su un cargo diretto oltreoceano, per poi essere immediatamente intercettati dalla polizia francese. Altrettanto paradossali furono gli eventi che seguirono alla morte di Benjamin, avvelenatosi con una forte dose di morfina sulla frontiera franco-spagnola: il filosofo, morto dopo ventiquattr’ore di agonia, viene sepolto secondo il rito cattolico e il feretro viene addirittura accompagnato da una processione di monaci; per conservare la sua salma venne affittato un loculo per cinque anni, ma quando Hannah Arendt si recò al cimitero di Portbou subito dopo la guerra scoprì che il corpo dell’amico era stato quasi sicuramente gettato in una fossa comune poco tempo dopo l’inumazione.
Ad accompagnare il racconto che Manifesto Incerto fa degli ultimi anni di vita di Benjamin, intervellato da un’altrettanto grottesca ricapitolazione della vita di Pound dall’infanzia fino all’arresto a Rapallo e al trasferimento forzato in America, ci sono i disegni di Pajak. Disegni che si intrecciano alle parole, disegni che le affiancano senza mai illustrarle, disegni che ci portano congiuntamente nel vivo delle sensibilità di Benjamin e di Pajak, disegni che ci disperdono, anche, che tentano l’azzardo di farci vivere in una soggettiva quasi filmica la concitata fuga di Benjamin e dei suoi compagni lungo i Pirenei, nei meandri di una natura splendida e assassina. Ma Benjamin stesso non si era mai affidato unicamente alle parole, nel suo percorso di letterato, continui punti di fuga si erano intersecati nella sua produzione concettuale, inducendolo a rivolgersi ora verso il teatro, ora verso l’arte contemporanea, ora verso la musica, ora verso la mistica, quel linguaggio che annulla il linguaggio. Da una commistione di tutte queste diverse discipline, filosofia e teologia in testa, nacque quella che, per parafrasare Hillman, di Benjamin rimase l’ultima immagine: un angelo in fuga, un angelo sconvolto, un angelo di troppo, sorto in Europa nel cuore del Novecento quando i cieli ne erano già vuoti.
***

Dipinto nel 1920 da Paul Klee, l’Angelus Novus venne acquistato l’anno successivo da Benjamin, che da questo acquerello, poco più di uno schizzo, non si separò mai, nemmeno al momento della fuga verso la Spagna e un’impossibile America. Quasi non c’è bisogno di ripercorrere la vertiginosa lettura che Benjamin stesso ne diede nella nona delle sue Tesi: “c’è un concetto di Klee che si chiama Angelus Novus. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie, e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso è questa bufera”.
Con questa scheggia delle Tesi, Benjamin all’improvviso resuscita un’ultima propagine di testo sacro nel cuore del XX secolo. Testo sacro, sacralizzante, autosacralizzantesi – la IX Tesi sul concetto di storia è tutte queste cose insieme, un vero e proprio teologumeno. Dei due amici, Scholem era, sulla carta, l’unico credente e praticante, eppure è Benjamin, non senza porgli omaggio con una citazione iniziale, a resuscitare in ultimo fuoco un imprevedibile tono da profeta ebraico, che ha concesso al suo goffo suicidio i tratti misterici del martirio. Come spesso capita, a scatenargli quest’incredibile visione era bastato poco: un abbozzo, quasi una parodia di angelo, tracciato con fare volutamente infantile o primitivo da Klee, inconsapevole che di tutta la sua produzione proprio questo schizzo sarebbe stato eletto al rango di icona sacra.
“L’angelo è immobile. Ha ali troppo magre per poter volare. Il suo viso non è rivolto al passato, ma con ogni evidenza al presente. Guarda di sbieco, con un’espressione inquieta, quasi impaurito”, è l’ecfrasi di Frédéric Pajak, che di disegni se ne intende. “La bocca aperta esprime spavento. Sta forse dicendo qualcosa? Oppure grida? Se proprio dovessi corredare il dipinto di una spiegazione, allora al contrario di Benjamin direi che è l’angelo del presente, fragile e interdetto. Non sta dando le spalle al futuro, ma al passato, un passato vuoto quanto il resto del quadro”. Benjamin, che aveva sempre saputo trarre una forza rivoluzionaria dalla nostalgia del passato, tutt’a un tratto ne scoprirebbe la violenta vacuità. “L’angelo è solo e smarrito, pietrificato da una temporalità sospesa che si chiama presente, e che non può contemplare né dal cielo né dalla terra: di terra e cielo non v’è traccia”. Dei tre saggi che stiamo indagando su Benjamin, è proprio il terzo Manifesto Incerto di Pajak a consegnarci la lettura più coraggiosa dell’Angelus Novus, coraggiosa proprio perché ne denuncia l’arbitrarietà, ne contesta la sacralizzazione ad Angelo della Storia. Non dimenticheremo la puntualità politica del Segnalatore d’incendio di Michael Löwy, né l’ampiezza ermeneutica del Dossier Benjamin di Frederic Jameson, eppure forse è proprio l’antiaccademico, eclettico Pajak quello che più a fondo è penetrato nello spirito di Benjamin – fino a ribaltarlo, fino a contestarlo, fino a disegnarlo, innalzando Benjamin a simbolo della modernità proprio come Benjamin aveva fatto con lo schizzo di Klee eletto ad allegoria della Storia, perché il sottinteso del Manifesto Incerto sembra proprio questo, identificare la modernità di Benjamin nella sua frammentarietà, nella sua confusione, nella sua capacità di prevedere il disastro e nella sua incapacità di prevenirlo.
***

“L’espressione ‘in certo modo’ è il segno di un’opinione che si sta formando”, scrisse una volta Gershom Scholem. “Da nessuno l’ho udita usare così spesso come Benjamin”. Molte cose si potrebbero scrivere ancora su Walter Benjamin, sul suo stile visionario ed esoterico, sul linguaggio biblico ma a tratti anche paganeggiante, e difficilmente potrebbero superare, in profondità, questo rilievo mosso da quello che fu l’amico di tutta una vita – l’equivalente di Brod per Kafka, se vogliamo. In fondo, in certo modo, Benjamin è un critico che si nasconde dietro gli autori di cui tratta, per lui Kafka stesso era, testuali parole, un “angelo infermiere”, non un oggetto di studi, Benjamin è sempre vittima e campione di un nascondimento che della sua personalissima interpretazione dell’identità ebraica rappresentò un punto fermo e martellante. Benjamin, che pure ambiva ad essere il più grande critico letterario tedesco dei suoi tempi, aveva sempre obbedito a una certa concezione di cinosi autoriale: “se scrivo in un tedesco migliore della maggior parte degli scrittori della mia generazione”, si legge in diversi passi del suo epistolario, “lo devo alla ventennale ottemperanza a un’unica piccola regola. Suona così: mai usare la parola ‘io’, tranne che nelle lettere” – uniche eccezioni, l’incompiuto dittico autobiografico della Cronaca e dell’Infanzia Berlinesi.
Un ulteriore elemento che colpisce della figura filosofica e letteraria di Walter Benjamin è la drastica corrispondenza tra il suo percorso, si scrittore e di uomo, e quello di due degli autori su cui più intensamente aveva rivolto la sua attenzione, Baudelaire e Kafka per l’appunto. Come Baudelaire, per tutto il corso della sua vita letterari e soprattutto negli ultimi, fagocitati anni Benjamin fu costretto alla letteratura d’occasione, scrivendo alcuni dei suoi testi più incisivi proprio su argomenti assegnatigli a mo’ di commissione, verso i quali non aveva particolari interessi. Con Kafka c’è condiviso l’aspetto più doloroso del lascito benjaminiano, solo che, invece di un solo Max Brod, la fortuna postuma di Benjamin fu merito di un nutrito gruppo di esecutori testamentari contraddittori, che solo per diplomazia riuscirono nella non facile impresa di superare ogni potenziale fonte di conflitto. Theodor Adorno, un tempo suo “discepolo” al di fuori di qualsivoglia vincolo accademico, e il già citato Gershom Scholem, amico di una vita e corrispondente fisso delle sue missive, furono senza dubbio tra i maggiori responsabili della collocazione di Benjamin a classico del pensiero del novecento, non meno di Hannah Arendt e Max Horkheimer. Più defilato Bertolt Brecht, con cui pure Benjamin aveva intessuto un sodalizio prezioso, nell’ultimo decennio della sua vita.
Questi tre libri su Benjamin ci confermano ancora una volta che Benjamin seppe coniugare illuminismo e mito come nessuno aveva fatto prima di lui – e come nessuno sapé replicare. La Scuola di Francoforte, che pure mai nascose il debito nei confronti di Benjamin e senza la quale oggettivamente il suo nome sarebbe rimasto confinato in una schiera assai minima di talmudisti brechtiani, criticò separatamente l’una e l’altra cosa. Negli otto decenni che ci separano dalla morte di Benjamin, tanto il mito quanto, e ancor più, l’illuminismo sono scomparsi; e in questa crisi congiunta del simbolo e della ragione solo un benjaminiano del calibro di Roberto Calasso ha saputo descrivere, a parole, l’inafferrabilità del reale. “La sensazione più precisa e più acuta, per chi vive in questo momento, è di non sapere dove ogni giorno sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte con maggiore evidenza che ci si trova nell’Innominabile Attuale”. Era il 2017, il libro si intitolava, non per nulla, L’Innominabile Attuale, ed era attraversato da parte a parte dal fantasma di Benjamin. Da allora, il mondo si è fatto ancor più frammentario, confusionario e convulso, e il Covid ha rintuzzato l’attualità delle riflessioni di Benjamin sulla catastrofe. Ma “solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza”, continua a ripeterci Benjamin. Non è mai troppo tardi per scoprire, indietro tutta, un senso cifrato alla Storia, un senso che, a mo’ di messia, solo dagli uomini potrà essere evocato, solo dagli uomini già è stato pianto.
I commenti a questo post sono chiusi


“Una prima sorpresa c’è già nelle prime pagine, quando Löwy rivela di aver scoperto, tra gli appunti inediti di Gershom Scholem custoditi presso l’Università ebraica di Gerusalemme, delle analoghe Tesi sul concetto di giustizia mai pubblicate, redatte da Scholem e datate tra il 1919 e il 1925, che rappresentarono un’indubbia influenza, a detta di Löwy, sull’ultimo testo che Benjamin scrisse, in fuga dal nazismo due decenni più tardi.”
Sarebbe buona cosa che le case editrici, nel ripubblicare un libro, lo riaggiornassero, o perlomeno si riaggiornasse chi ne scrive una recensione. Sulla “prima sorpresa”: Le tesi sul concetto di giustizia di Scholem sono state pubblicate anni or sono. Peraltro è anche abbastanza dubbio che abbiano avuto un’influenza su Benjamin.