La Provenza e Giono: bonheur, malheur
di Carlo Grande
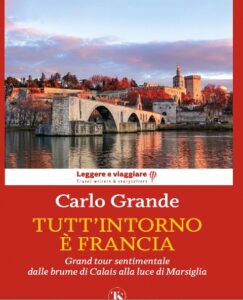 La Provenza sa di Alpi e di roccia, è aspra e dolce nello stesso tempo. È lavanda, querce e mele cotogne, sempre a metà strada fra tragedia e luce, come disse Izzo di Marsiglia.
La Provenza sa di Alpi e di roccia, è aspra e dolce nello stesso tempo. È lavanda, querce e mele cotogne, sempre a metà strada fra tragedia e luce, come disse Izzo di Marsiglia.
Al pari della Sicilia e della Langa, la Provenza è contadina, pietrosa, sa essere dura. Conosce il candore e le cattiverie dei contadini di Pagnol, attaccati alla terra e alle sorgenti. Ha la perfidia e la grandezza di Jean de Florette e Manon des sources, film magistrali con Yves Montand, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu ed Emmanuelle Béart.
Tutta la Provenza è bagliore e ombra, è equilibrio sopra e sotto la follia.
A Manosque faccio tappa: è la città di Jean Giono, lo splendido autore pacifista e anarchico di origine e carattere piemontese, canavesano, accademico Goncourt che scrisse tra gli altri L’Ussaro sul tetto e L’uomo che piantava gli alberi.
Giono rivive nel paesaggio della Valchiusella, dove nacque Pietro Antonio, il nonno carbonaro che partecipò ai moti del marzo 1821 e poi, fuggendo una condanna a morte, riparò in Francia, arruolandosi nella Legione Straniera. Jean non lo conobbe (morì nel 1854), ma grazie ai ricordi del padre Jean Antoine (calzolaio con il ritratto di Voltaire e la Bibbia nel cassetto), fu il modello per Angelo Pardi, straordinario protagonista della trilogia che comincia con l’Ussaro e prosegue con Una pazza felicità e Angelo.
Giono nutrì profonda tenerezza per il Piemonte: «La felicità – scrisse – mi viene appena sento fremere un pioppo piemontese, o fischiare una marmotta, o i passi del vento degli alti pascoli del Viso, lo sgranellare del pietrame sotto i piedi del camoscio, o il grido dell’aquila».
Manosque è una cittadina che ho amato, nella casa di una zia dove abbiamo trascorso cene di Natale serene, passeggiando tra i negozi e la campagna, chiacchierando e mangiando alla marsigliese, alla provenzale.
Esplorando le vie medievali, entrai nel Centre Giono e scoprii L’uomo che piantava gli alberi, pochi fogli ormai datati che parlavano tra l’altro di «bianche querce» nei boschi; traduzione del 1958, un po’ antiquata e inesatta, perché Quercus alba è una specie a sé stante. Il racconto era talmente bello che sperai di ritradurlo per un piccolo editore. Chiamai Gallimard, risposero che un importante editore italiano aveva già comprato tutto Giono. Il racconto uscì per Salani di Luigi Spagnol, vendette molto ed è ancora oggi un cult. Pochi anni dopo Luigi – affinità elettive? – avrebbe pubblicato il mio romanzo La via dei lupi.
Al Parais, la casa di Giono – non lontana da quella degli zii, sul fianco sud del Mont d’Or, la collina con in cima la vecchia torre – andai a intervistare per L’Indice la vedova Elise e la figlia Sylvie, nel centenario della nascita dello scrittore.
Le rivedo: Elise Giono (98 anni) esce dal cono di luce dell’abatjour e sporgendosi dalla poltrona batte il dito ossuto sul bordo del tavolo: «Vivo qui dal 1930, ho passato giorni e giorni in questa cucina, ho scritto a macchina tutte le opere di mio marito».
Per un istante la gatta Violette sgrana gli occhi verdi. La vedova di Giono ricordava bene le serate trascorse con il marito a correggere manoscritti. Al suo fianco la figlia Sylvie, un’esistenza dedicata al padre.
La Francia ormai lo omaggia da grande scrittore quale è (amato da Malraux e Henry Miller), in Italia non ha ancora avuto la meritata fortuna. Gli fanno torto l’angusta etichetta di scrittore regionalista e “provenzale” e le ingiuste accuse di collaborazionismo.
Molti devono ancora scoprire le stupende pagine del poeta e scrittore “contadino”, che dal padre e dal nonno ereditò la mistica rivoluzionaria.
Giono anarchico e pacifista, lirico e panteista: è un mâitre à penser che in anticipo sui tempi ha toccato temi attualissimi, l’ecologia, la ribellione ai bisogni artificiali del consumismo, l’istinto di sfuggire allo spirito gregario, all’asfissia della civiltà di massa.
Non sognava idilli campestri: «Non sono un nemico della tecnica, sono nemico delle forme moderne con cui viene impiegata la tecnica» diceva. Intuì il pericolo dei mulini bianchi (meglio quello di Daudet, a Fontvieille) e del turismo “pittoresco”, dei paesaggi alla moda, lanciati «come un profumo, un tweed, un ballo, una marca di whisky» dagli uffici del turismo, da «commercianti oculati e avidi». Sapeva che la bellezza «è legata a un filo. Non c’è nulla di più facile che distruggere un’armonia, basta una falsa nota… qualche traliccio giudiziosamente piazzato».
Negli anni ’50 e ’60 vide l’Alta Provenza, terra di Pan e di Virgilio, spopolarsi e vacillare sotto i primi colpi dello «sviluppo», della «civiltà, del denaro». Un giorno Greta e gli ecologisti leggeranno tutto Giono, le sue pagine sulla felicità, sul bonheur, cui ha dedicato la vita e la poetica: «Bisogna seminare la gioia, radicarla e fare in modo che sia come un prato fertile, con milioni di radici».
«Mio marito voleva che tutto il mondo fosse felice – diceva Elise Giono –. Eravamo felici quando andavamo in Italia, la terra dei suoi avi. Amava soprattutto Torino. Milano gli piaceva meno. Troppo grande». Fu amico di Luigi Bàccolo, cui è intitolata la biblioteca civica di Savigliano. Giravano per la città, nessuno si accorse (va sempre così) che erano due grandi.
Secondo Giono il segreto della felicità è nella vita a contatto con la natura, nell’umiltà del lavoro disinteressato e nella generosità: lo scrive nello splendido L’uomo che piantava gli alberi, storia di un vecchio contadino simbolo della cocciutaggine e della speranza provenzale. Vive solo, in una landa desolata e passa quarant’anni a seminare alberi. Cento querce al giorno, finché il deserto diventa foresta e la foresta riporta l’acqua e la gioia di vivere.
Dallo studio al Parais, la sua casa sulla collina di Manosque, ho apprezzato la celebre vista sui tetti antichi della città, sui quali corre l’ussaro Angelo per sfuggire al colera e al linciaggio dei concittadini. Davanti alle onde di coppi rosa oggi torreggia un condominio moderno: per Giono, spirito solitario e contemplativo che passò gran parte della vita passeggiando al bordo del minuscolo canale, godendo il sole e l’acqua, fu un brutto colpo; non ci poteva far nulla, girò la scrivania dall’altra parte e volse le spalle alla finestra, guardò la collina.
Finì in prigione due volte. Dal 1937 al ’39 aveva più volte esaltato l’obiezione di coscienza e lo sciopero, criticava l’ideale di patria, alla base della guerra: «Io – scrive in Jean le Bleu – quando vedo un fiume dico “fiume”; quando vedo un albero dico “albero”; non dico mai “Francia”». La sua è una critica radicale contro l’autorità: «In verità non c’è che la solitudine… Bisogna distruggere i partiti e i capi… Il capo, il dittatore, l’eletto, la guida, l’uomo di acciaio, eccolo!». Nel ’39 Giono strappa alcuni manifesti di chiamata alle armi. È troppo. Viene imprigionato nel forte Saint-Nicolas, a Marsiglia, sarà liberato grazie all’intervento di André Gide e, si dice, della regina madre del Belgio.
Alla Liberazione, il “comunista” Giono viene ancora arrestato con l’accusa di aver collaborato con il regime filo-nazista di Vichy. Nega, viene prosciolto dopo qualche mese. Anche in quei momenti Sylvie lo ricorda sereno: «Lo chiamavano il “console giudeo” per il bene che faceva agli ebrei. Li aiutò, li nutrì. La verità è che non aveva nessun partito. Noi bambine non abbiamo potuto renderci conto dell’angoscia che provava. Si è sempre fatto in quattro per rassicurarci. Diceva che tutto si può aggiustare. Quando fece la prima guerra mondiale mandò 400 lettere ad amici e parenti, fece tutte le grandi battaglie, da Verdun alla Somme».
«Nello zaino – rivela la moglie – teneva La certosa di Parma di Stendhal, suo nume letterario. Alla fine di ogni giornata i compagni scommettevano se l’avesse ancora nel sacco. Ce l’aveva eccome. Avrebbe perso il fucile ma non Stendhal».
La prima guerra mondiale lasciò in lui ferite profonde: «Non mi vergogno – scrive in Rifiuto d’obbedienza – ma a ben vedere quello che facevo era una vigliaccheria… Non ho avuto il coraggio di disertare. Non ho che una sola scusa: ero giovane… In guerra ho paura, ho sempre paura, me la faccio addosso. Perché è stupida, perché è inutile».
Lo accusarono di essere reazionario per la sua filosofia naturalista, contrapposta alla civiltà moderna, espressa ne Le vere ricchezze, nella trilogia della Presentazione di Pan e nell’utopia aristocratica del Contadour, altipiano dove lo scrittore si insediò nel 1935 con 40 compagni. Esperienza che durerà sei anni, lasciando un penoso strascico di equivoci. Sylvie: «Era un gruppo di amici, venivano dalla città, sentivano il bisogno di respirare, di leggere, di ascoltare la natura. Mio padre non era un guru, disse subito che la ricerca della felicità è un fatto personale e non di gruppo, ciascuno percorre quella strada da solo».
Eppure, scrisse Giono, «molti si presero terribilmente sul serio». «L’ha raccontato – disse Sylvie – nel romanzo Que ma joie demeure: è la storia di un uomo che cerca di portare un po’ di serenità in un villaggio contadino, fra gente abbruttita dal lavoro e dalla routine. Ma alla fine è costretto ad arrendersi. Mio padre era un po’ naif, ma non ingenuo. Sapeva bene che anche l’eccesso di bontà può diventare mostruoso. Credeva nella parola, pensava che potesse fermare la guerra. Un semplicismo forse sconcertante, ma credeva nell’amicizia. Tutti lo abbandonarono, anche i concittadini. L’Ussaro è stato una specie di vendetta: li ha fatti morire di colera».
Sulla collina di Manosque – mi raccontò lo zio Michel – lo ricordano ancora passeggiare, con l’inseparabile giacca di renna, fermarsi con i gomiti sulla rete di un giardino, a parlare per ore di nomi e parentele di questo e di quello, chiedere dettagli su amori, odi, litigi. Propellente per la sua fantasia. Adorava il cinema, diffidava degli elettrodomestici. Profetico, nella carestia di umano e nella deprivazione sensoriale che ci affligge.
NdR: questo passo è tratto dal libro di Carlo Grande “Tutt’intorno è Francia. Gran tour sentimentale dalle brume di Calais alla luce di Marsiglia”, edito di recente da TS Edizioni

