Quattro romanzi: Tanizaki, Camilleri, Slimani, Evison
di Gianni Biondillo
 Jun’ichirō Tanizaki, La gatta, Shōsō e le due donne, Neri Pozza, 2020, 125 pagine, traduzione di Gianluca Coci
Jun’ichirō Tanizaki, La gatta, Shōsō e le due donne, Neri Pozza, 2020, 125 pagine, traduzione di Gianluca Coci
Per amore si accetta qualsiasi cosa: dormire in posizioni scomode sul tatami, avere un compagno, Shōsō, infantile e senza nerbo, accettare il suo ronfare rumoroso e la sua passione di dar da mangiare dei pescetti direttamente dalla bocca alla piccola Lily, un’indolente gatta di tipo “europeo”. E per amore si è pronti ad ogni tipo di vendetta, come quella che ha orchestrato Shinako, dopo che il marito l’ha lasciata per un’altra donna, Fukuko, più bella e più agiata di lei.
E la vendetta è davvero subdola. Shinako implora la sua contendente di lasciarle almeno il gatto, unico ricordo di un passato felice. A Fukuko non pare vero liberarsi di quella gattina viziata, fonte di attenzioni fin troppo ossessive del marito, per averlo tutto per lei. E così, all’inconsapevole Lily, tocca traslocare.
Per amore si può fare qualsiasi cosa: prendere una bici dal primo che passa, cucinare a casa di uno sconosciuto, passare ore al freddo e all’umido, pur di vedere anche solo per un istante la protagonista delle proprie passioni. Che per Shōsō non è né la prima moglie né l’attuale compagna. Un amore così puro, senza doppi fini, oltre le convenzioni sociali o i biechi interessi economici, non poteva essere che per Lily. Al punto che Shōsō, vigliacco di natura, è pronto ad ogni ribellione pur di rivederla.
La gatta, Shōsō e le due donne è tutto qui. Un libro con una storia piccola, persino ridicola. Ma quanto si sarà divertito a scriverla Jun’ichirō Tanizaki? Sia lode al romanziere giapponese capace di raccontarci un legame sentimentale e ossessivo che può crearsi solo fra un essere umano e un gatto. Non un gatto qualsiasi, ovviamente, ma l’emblema stesso, il correlativo oggettivo del sentimento folle e illogico che è l’amore: Lily, centro del vortice impetuoso dei sentimenti e perciò unico punto immobile e indifferente di questa storia.
*
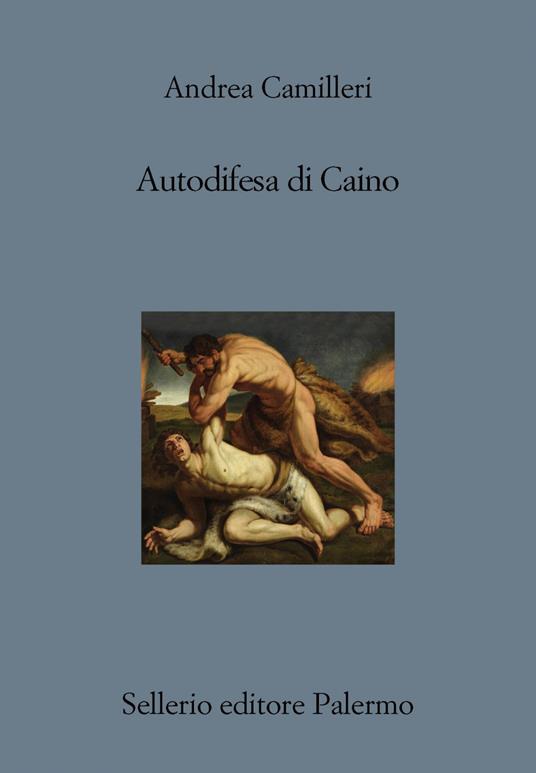 Andrea Camilleri, Autodifesa di Caino, Sellerio editore, 2019, 81 pagine
Andrea Camilleri, Autodifesa di Caino, Sellerio editore, 2019, 81 pagine
Fa specie pensare che questo sia il primo libro pubblicato da Andrea Camilleri dopo la sua morte. Ma conoscendone la straordinaria prolificità sono certo che non sarà, fortunatamente per noi, l’ultimo. Detto ciò, viene fin troppo naturale immaginarlo come un lascito, un testamento. Non sono d’accordo. Autodifesa di Caino è, nei fatti, un testo minore nella sua produzione. Poco più di un gioco, dove il vecchio maestro, dopo l’esperienza alle terme di Caracalla della Conversazione su Tiresia, voleva replicare il piacere di raccontare una storia con la sua voce, a teatro. Abbiamo perso l’occasione, non ci resta che immaginarlo, magari augurandoci che qualche coraggioso, prima o poi, metta davvero in scena questo monologo, seguendo fedelmente le indicazioni previste nel testo.
Che di copione si tratta, insomma. Di qualcosa che va visto e ascoltato, prima ancora che letto. A parlare è Caino stesso, a prima vista il simbolo del male dell’umanità, ma ascoltando le sue ragioni, forse il più umano degli umani, consapevole degli errori fatti, orgoglioso delle conquiste realizzate dopo il tragico fratricidio. Ché, non dimentichiamolo, siamo tutti figli di Caino, l’inventore delle città e dell’arte, non di Abele, colpevole (come da citazione di Elie Wiesel riproposta dall’autore) di indifferenza. Non basta essere buoni, occorre essere solidali, vuole dirci il vecchio maestro. Camilleri lo fa con una lingua all’apparenza semplice, colloquiale ma in realtà colma di dotte citazioni (dai testi sacri a Dario Fo), riproponendo anche in questa sua ultima opera i suoi temi più cari: il piacere incolpevole della carnalità, il gusto del paradosso, l’umanità come speranza collettiva. Dal mito, insomma, si può solo imparare. Nessuno tocchi Caino.
*
 Leïla Slimani, Il diavolo è nei dettagli, Rizzoli, 58 pag., 2020, traduzione di Elena Cappellini
Leïla Slimani, Il diavolo è nei dettagli, Rizzoli, 58 pag., 2020, traduzione di Elena Cappellini
Un difetto? Troppo breve. Resto sempre dell’idea che le rivoluzioni si facciano con i pamphlet e non con le enciclopedie ma qualche pagina in più non avrebbe di certo stonato in questa raccolta di scritti di Leïla Slimani. Anche perché i temi toccati ne Il diavolo è nei dettagli sono così cogenti (e cocenti) che l’esiguità del testo potrebbe indurre a leggerlo di fretta, in un batter d’occhio (d’altronde sono pagine ben cesellate e di facile approccio). E sarebbe un peccato. Fra racconti, apologhi, ricordi d’infanzia, articoli d’attualità, i sei testi di questo libello affondano come uno stiletto nel ventre molle della nostra contemporaneità, chiedendoci di prendere posizione. Slimani lo fa, senza indugio. Scrittrice marocchina, più francese degli stessi francesi, ricorda a tutti noi su quali valori l’Occidente non può trattare.
Ogni fanatismo deve essere bandito, perché ogni intolleranza esclude in partenza ogni dialogo, ogni conquista sociale, ogni emancipazione. Accettare, per quieto vivere, le piccole o grandi intolleranze dei fanatici – su tutti quelli religiosi, dogmatici, pieni di odio nei confronti della cultura – significa perdere di giorno in giorno posizione. Subire, lasciar correre, su certi argomenti nevralgici della vita sociale è immorale. Quindi non resilienza ma resistenza.
Scorgere anche nel minimo dettaglio la presenza dell’intolleranza è il primo dovere di ogni intellettuale che meriti questo appellativo, cioè colui che ha gli strumenti per descrivere e denunciare ogni deriva autoritaria. Ma allo stesso tempo, nel patto che ogni democrazia ha firmato con i sui cittadini, ognuno deve fare la sua parte, senza demandare. Questo scrive Slimani, raccontando con chiarezza, senza borie, da scrittrice autentica qual è.
*
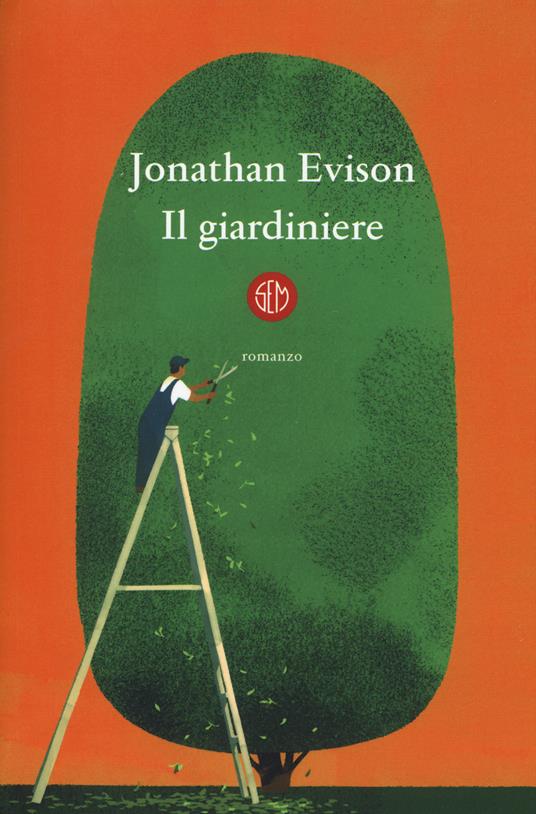 Jonathan Evison, Il giardiniere, 332 pag., Sem, 2020, traduzione di Marta Salaroli
Jonathan Evison, Il giardiniere, 332 pag., Sem, 2020, traduzione di Marta Salaroli
Mike Muñoz è uno di noi: ha una vita mediocre e un futuro che si prospetta altrettanto mediocre. È un ragazzo di ventitré anni con un padre alcolista che lo ha abbandonato presto, una madre che si barcamena con fatica di lavoretto in lavoretto, un coinquilino – amante della madre – che passa il tempo a suonare il basso e fumare erba, un fratello ciccione e disabile, un amico d’infanzia razzista e sessista. Nulla è dalla parte di Mike. È un mezzosangue messicano, timido con le ragazze, che vive in un posto anonimo degli Stati Uniti (Suquamish, Washington), in un paesaggio anomico fatto di parcheggi, ipermercati, pub.
Messo così il romanzo di Jonathan Evison parrebbe una tragedia. Ma l’autore ha regalato al suo personaggio una passione: l’arte topiaria. Mike è un giardiniere appassionato, capace di trasformare ogni cespuglio in una scultura spettacolare. Non ostante le frustrazioni di una condizione sociale che lo rigetta di continuo nella precarietà – niente lavoro, niente soldi, niente futuro – Mike ad ogni caduta, ad ogni rinuncia, è pronto a rialzarsi e a ripartire come un vecchio lupo di mare, abbastanza disincantato e allo stesso tempo abbastanza illuso dalla vita.
Il giardiniere è scritto in prima persona, seguendo il racconto direttamente dalla voce di Mike che non lesina disavventure, delusioni cocenti, situazioni imbarazzanti, raccontate con ironia e disincanto. Niente di davvero romanzesco, sia chiaro. La stessa trama del libro si sposta di poco, non ha colpi di scena memorabili. In fondo Evison lo sa, la vita è vita, non è un film. È una lotta continua fra il mondo che ha deciso dove devi stare per sempre e i sogni che ti chiedono di fuggire, o quanto meno spostarti da quella condanna, anche di poco, anche solo abbastanza per sentirti temporaneamente felice.
*
(pubblicati precedentemente su Cooperazione nel 2020)

