L’affaire Moro
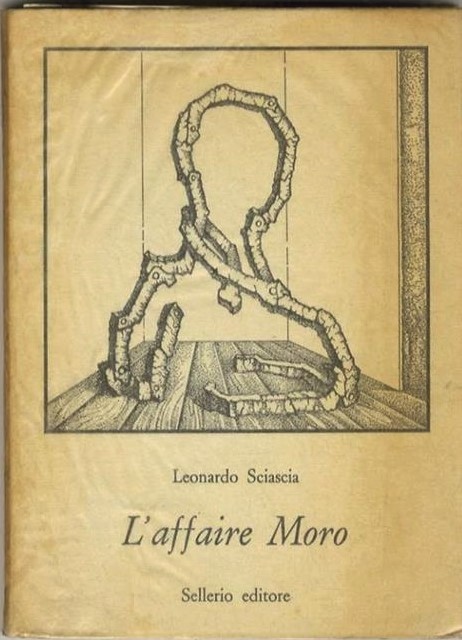 una rilettura di Venceslav Soroczynski di Leonardo Sciascia, L’affaire Moro
una rilettura di Venceslav Soroczynski di Leonardo Sciascia, L’affaire Moro
Aldo Moro fu rapito il 16 marzo e assassinato il 9 maggio. Già il 24 agosto, in meno di quattro mesi, Sciascia consegnava della vicenda un dipinto chiaro e definito, denso e puntellato di fatti. Aveva raccolto lettere, resoconti, articoli di giornale, voci, elementi forse in-provabili (le intuizioni lo sono, ma dobbiamo ignorare le intuizioni degli intellettuali?), ma certo non improbabili, che formavano un quadro dai colori accecanti come in un’opera fauve, o come nella stagione del terrorismo italiano.
Mi perdonino il fantasma di Sciascia, e i superstiti di Moro, se tocco l’argomento da un luogo di vacanza. Il motivo è puramente (o impuramente) personale: quel bisogno di gravità che mi prende ogni anno in riva al mare. Ma, letto oggi, su una sdraio in Sicilia, questo pamphlet fa sudare freddo. Perché l’Affaire Moro è studiato in una particolare declinazione, che non è la ricostruzione dei fatti, dei moventi e degli effetti, ma il punto di vista di un uomo, un prigioniero condannato a morte. Tale Moro si sentì, a opera dei brigatisti, ma anche a causa dei suoi colleghi di partito, della Chiesa, dello Stato. Solo la sua famiglia lo rivoleva indietro e chiamò a raccolta coloro che potevano salvarlo. Che però non sentirono, o fecero finta di non sentire, o non fecero neppure finta. E restarono muti, o biascicarono reazioni e rimedi non all’altezza delle istituzioni. Di nessuna istituzione, per blanda che fosse: una ASD di provincia avrebbe avuto più dignità, più coraggio e, al contempo, più pietà per il suo presidente.
Presidente che, nel momento in cui fu rapito, aveva un impegno: stava andando in Parlamento a votare le fiducia in un governo sostenuto dal PCI. E, secondo Sciascia, “Il punto di consistenza del dramma, la ragione per cui a Moro si deve in riconoscimento la morte sta appunto in questo: che è stato l’artefice del ritorno, dopo trent’anni, del Partito Comunista nella maggioranza di governo”. La sottrazione di Moro al teatro politico doveva dunque evitare lo sconvolgimento interno e internazionale che sarebbe derivato dalla presenza dei comunisti alla guida di un paese aderente al Patto Atlantico.
Immobilizzare il quadro politico, dunque. E Moro, nelle sue lettere dalla “prigione del popolo”, accusa la DC proprio di immobilismo, un immobilismo che assume ogni giorno di più i tratti della rigidità. Rigidità che pare non ascrivibile al disorientamento, ma a un calcolo o, addirittura, a una pressione esterna: “Vi è forse, nel tener duro contro di me, una indicazione americana e tedesca?”, scrive Moro nella lettera del 10 aprile. Per comprendere l’enormità della domanda, si pensi che chi la pose immaginava che sarebbe stata pubblicata da tutte le testate – e, infatti, lo fu. E si pensi che, man mano che le fine si avvicinava, ogni sua parola poteva rubricarsi asintoticamente a una dichiarazione resa in punto di morte.
Sciascia, però, non rigira il dito: testimonia quanto deve, quanto è necessario all’inquadramento dei fatti e dei sentimenti dell’uomo Aldo Moro. Il saggio dell’autore siciliano ci rende conto dell’insistente appello del prigioniero a chi può salvarlo, affinché lo salvi. Di questo, è pieno il libro; questo, a me lettore attuale e cittadino di ritorno, sembra essere il portato morale di maggior rilievo della vicenda: l’invocazione a cedere alle richieste dei brigatisti, che restituirebbero il rapito in cambio di alcuni loro compagni detenuti in carcere. Moro ricorda ai suoi colleghi democristiani che lo scambio di prigionieri non è fatto eccezionale ed è pratica esperita già in altre occasioni. E chiede che tale rimedio venga adottato anche in suo favore. E lo dice in più missive, con parole sempre più allarmanti, temendo la morte, vedendola avvicinarsi, comprendendo che quello è il suo futuro, se non riuscirà a scalfire la rigidità dello Stato.
E si spinge, nella lettera alla DC del 27 aprile, a “convocare per data conveniente e urgente il Consiglio Nazionale avendo per oggetto il tema circa i modi per rimuovere gl’impedimenti del suo Presidente”. Un’idea geniale che, oltre a costituire prova della sua intelligenza e lucidità, dimostra che gli anni di piombo sono la trama poco credibile di una storia che nel nostro Paese è realmente accaduta. Così come le stesse lettere di Moro sarebbero letteratura, se non fossero soprattutto prova di indegnità dei destinatari. Egli scrive della necessità che di lui ha il partito, il Paese, i suoi cari soprattutto. E che per questo sarebbe necessario cedere al ricatto dei terroristi.
Eppure, mentre leggevo e provavo vergogna nei confronti dei turisti stranieri che mi sapevano cittadino di quella Repubblica che non volle indietro quell’uomo, il mio pensiero era che io, al posto suo, avrei, più egoisticamente, urlato solo voglio vivere! E forse – l’ho sognato in una notte che ha separato due giorni di lettura delle pagine più drammatiche – avrei perfino riferito pubblicamente i segreti più inascoltabili, o avrei brandito questa minaccia, pur di farmi riscattare. Ma Moro no: tacque. Forse non conosceva fatti delicati? O, forse, fu davvero, e semplicemente, uno statista, quale, con parola già però sacrificale, lo definirono, dopo il rapimento, i suoi colleghi di partito?
E allora l’Affaire Moro ci dice cosa si sia dimostrata essere l’Italia: non una nazione, ma qualcosa che sta fra alcune linee di confine e certa pessima letteratura. “Lasciata (…) alla letteratura la verità, la verità (…) sembrò generata dalla letteratura”, scrive Sciascia. La penisola evidentemente non è solo ricca di arte, ma è essa stessa una forma d’arte e, nelle opere d’arte – si sa – si mente, si uccide, si deruba, si tradisce, poiché la solidità della trama viene prima di tutto. E non ci si deve annoiare. E, lo vedete anche voi oggi: non ci si annoia. E ci vuole sempre il morto, che paga per tutti. E colui che viene sacrificato è, fra l’altro, “il meno implicato di tutti”, come di Moro scrisse Pasolini (in “Il vuoto del potere” ovvero “l’articolo delle lucciole”, Corriere della Sera, 1° febbraio 1975). Ma il verbo sacrificare forse non delimita a sufficienza l’azione, o la somma di azioni che Sciascia, in esergo, sospetta, citando violentemente Canetti: “La frase più mostruosa di tutte: qualcuno è morto «al momento giusto»” (in La provincia dell’uomo: quaderni di appunti 1942-1972, 1973).
Poi, dopo quella morte, tutti sembrarono orrendamente sollevati (questo nel libro non c’è: è idea mia), come quando muore un familiare per una malattia contro la quale non si poteva fare nulla, o per la quale il costo delle cure era troppo alto. Perché di questo parve trattarsi. E, come in ogni misera sceneggiatura di una serie di serie b, si trovò la scusa: la ragione ufficiale del sacrificio fu il rispetto verso le famiglie degli uomini della scorta, uccisi nel rapimento: non sarebbe stato giusto trattare con gli assassini di cinque servitori dello Stato. E, con questa motivazione, se ne lasciò assassinare un sesto.
Quel sesto uomo che aveva creduto nella pietà, nella giustizia, nell’equità, nell’amicizia, nell’applicazione di alcuni principi che oggi chiamiamo valori senza sapere quanto valgono. E ci aveva creduto talmente tanto da ricordarli ai potenti con un candore che assunse i tratti della fiaba, non immaginando che l’esito della fiaba italiana non è mai il lieto fine, ma il risultato di un calcolo costi-benefici.
Questo libretto, in 150 paginette scritte in grosso, fa emergere un Paese nel quale la tragedia si consuma senza dramma, in cui il giallo è complessissimo, eppure si sa sin dall’inizio chi sarà la vittima e chi è il colpevole. Colpevole che forse non ha un nome perché non è un uomo, ma è un sistema, un conglomerato di abitudini, complicità, necessità, ragion di stato, lentezze, inefficienze, i quali, però, tutti assieme, funzionano benissimo per raggiungere l’obiettivo di qualcun altro.
Un Paese, insomma, nel quale tutto è possibile, nel bene e nel male. Tesi utile a innescare una lettura critica della Storia e, forse, del presente: se si è lasciato uccidere Moro, forse si lascerà uccidere chiunque, per un interesse superiore. Ma anche questo nel libro non c’è: è un’idea mia, però io sono in riva al mare: la temperatura è altissima, il sole deforma la vista e, forse, anche i miei pensieri.

