Una lettera di Niccolò Machiavelli sull’«amore»
di Niccolò Machiavelli
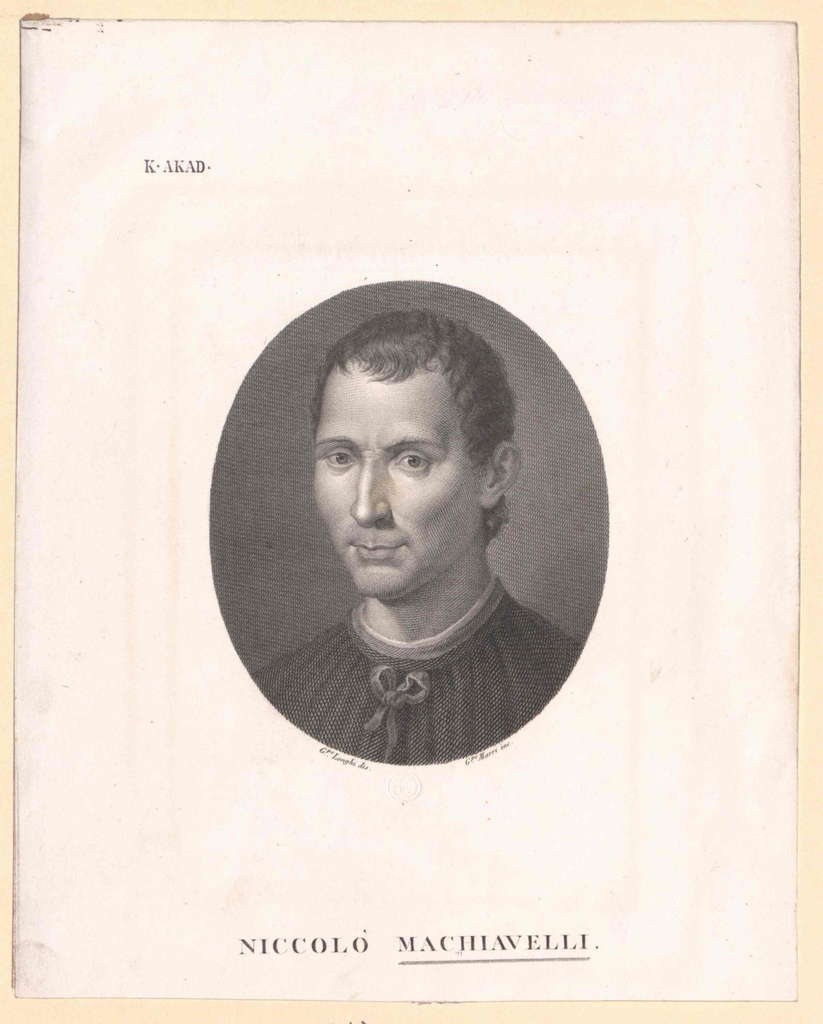
{Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un estratto dalle Lettere di Niccolò Machiavelli, Salerno editrice, nell’edizione diretta e coordinata da Francesco Bausi. Il volume raccoglie, in tre tomi, il carteggio privato di Niccolò Machiavelli, comprendente 82 lettere sue e 272 missive di corrispondenti. Si tratta di testi che apportano un contributo determinante per la conoscenza della biografia, della personalità e della cultura di Machiavelli, oltre che della storia fiorentina e italiana nel primo quarto del XVI secolo.
L’estratto che segue è la lettera di Machiavelli a Francesco Vettori del 25 febbraio 1514. Spiega Francesco Bausi nella nota introduttiva: «A suggello di [una] sezione comico-erotica del carteggio col Vettori, che occupa due mesi tondi (dal 24 dicembre 1513 al 25 febbraio 1514), M. gli invia un’epistola occupata pressoché per intero da una gustosa “novella” che ha per protagonisti i due comuni amici Giuliano Brancacci e Filippo Casavecchia […]. Su un piano più generale questa lettera non fa che sviluppare e concludere l’argomento delle precedenti, confermando con l’efficacia di un vero e proprio exemplum il loro assunto fondamentale, vale a dire l’ipocrisia, l’inutilità e l’innaturalità tanto di qualunque contrapposizione ad excludendum fra amore etero- ed omosessuale, quanto – come si ripete, alla fine, anche qui – delle remore morali e sociali che frenano il libero dispiegarsi della passione erotica. […] Pezzo di bravura superlativo del M. “comico”, la «metamorfosi» del Brancacci si colloca a pieno titolo fra le sue più riuscite prove letterarie. Con la Favola di Belfagor, con la novelletta della vecchia veronese […] e con la Mandragola, essa condivide i temi, specialmente a lui cari e congeniali, dell’inganno, del travestimento, del doppio e dello scambio di persona».
Il testo è riportato senza le note critiche dei curatori: per quelle rimandiamo al volume originale.}
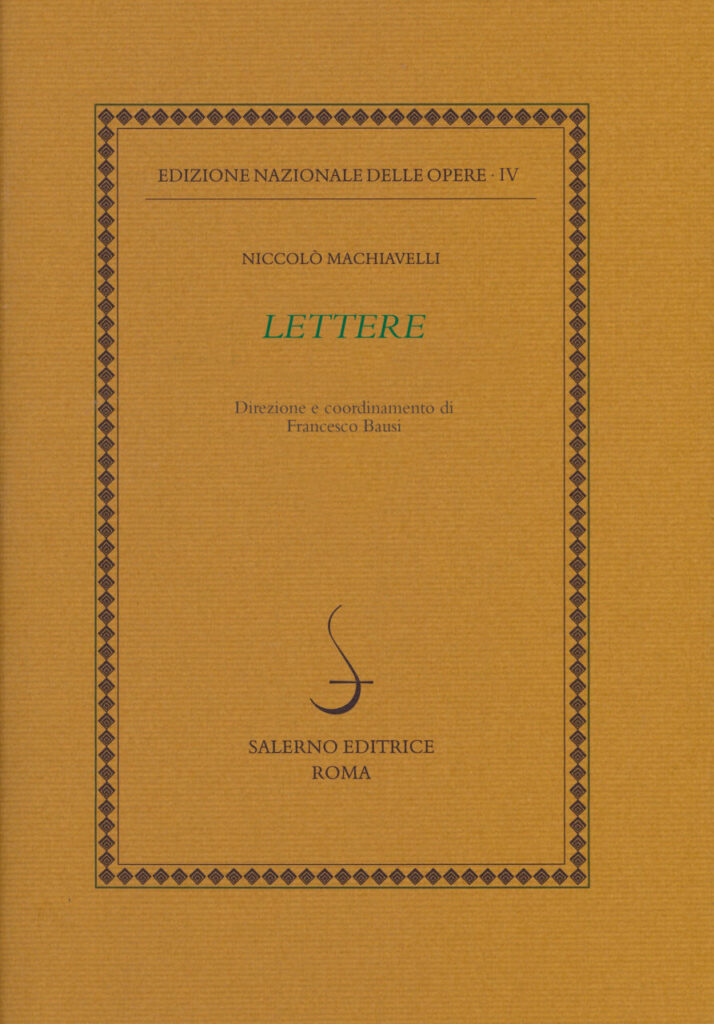
***
Magnifico oratori Florentino Francisco Vettorio apud Summum Pontificem suo observandissimo. Rome
Magnifico oratore, io ebbi una vostra lettera dell’altra settimana, e sono indugiatomi ad ora a farvi risposta, perché io desideravo intendere meglio il vero di una novella che io vi scriverrò qui dappiè; poi risponderò alle parti della vostra convenientemente. Egli è accaduto una cosa gentile, ovvero, a chiamarla per il suo diritto nome, una metamorfosi ridicola e degna di essere notata nelle antiche carte; e perché io non voglio che personasi possa dolere di me, ve la narrerò sotto parabole ascose.
Giuliano Brancacci, verbigrazia, vago di andare alla macchia, una sera infra l’altre ne’ passati giorni, sonata l’avemaria della sera, veggendo il tempo tinto, trarre vento e piovegginare un poco (tutti segni da credere che ogni uccello aspetti), tornato a casa si cacciò in piedi un paio di scarpette grosse, cinsesi un carnaiuolo, tolse un frugnuolo, una campanella al braccio e una buona ramata. Passò il ponte alla Carraia, e per la via del Conte de’ Mozzi ne venne a Santa Trinita, e entrato in Borgo Santo Appostolo andò un pezzo serpeggiando per quei chiasci che lo mettono in mezzo; e non trovando uccelli che lo aspettassino, si volse dal vostro battiloro e sotto la Parte Guelfa attraversò Mercato, e per Calimala Francesca si ridusse sotto il Tetto de’ Pisani, dove guardando tritamente tutti quei ripostigli trovò un tordellino, il quale con la ramata, con il lume e con la campanella fu fermo da lui, e con arte fu condotto da lui nel fondo del burrone, sotto la spelonca dove alloggiava il Panzano; e quello intrattenendo e trovatogli la vena larga e piú volte baciatogliene, gli risquittí dua penne della coda, e infine, secondo che gli piú dicono, se lo messe nel carnaiuolo di drieto.
Ma perché il temporale mi sforza a sbucare di sotto coverta, e le parabole non bastano, e questa metafora piú non mi serve, volle intendere il Brancaccio chi costui fosse; il quale gli disse, verbigrazia, essere Michele, nipote di Consiglio Costi. Disse allora il Brancaccio: «Sia col buono anno, tu sei figliuolo di uno uomo dabbene, e se tu sarai savio, tu hai trovata la ventura tua: sappi che io sono Filippo da Casavecchia, e fo bottega nel tal lato; e perché io non ho danari meco, o tu vieni o tu mandi domattina a bottega, e io ti satisfarò». Venuta la mattina, Michele, che era piú presto cattivo che dappoco, mandò un zana a Filippo con una polizza, richiedendoli il debito e ricordandoli l’obbligo; al quale Filippo fece un tristo viso, dicendo: «Chi è costui? O che vuole? Io non ho che fare seco; digli che venga a me». Donde che, ritornato il zana a Michele e narratogli la cosa, non si sbigottí di niente il fanciullo, ma animosamente andato a trovare Filippo, gli rimproverò i benefici ricevuti, e li concluse che se lui non aveva rispetto ad ingannarlo, egli non arebbe rispetto a vituperarlo; tale che, parendo a Filippo essere impacciato, lo tirò drento in bottega e li disse: «Michele, tu sei stato ingannato; io sono uno uomo molto costumato, e non attendo a queste tristizie; sí che egli è meglio pensare come e’ s’abbi a ritrovare questo inganno, e che chi ha ricevuto piacere da te ti ristori, che entrare per questa via, e senza tuo utile vituperare me. Però farai a mio modo; andra’tene a casa, e torna domani a me, e io ti dirò quello a che arò pensato». Partissi il fanciullo tutto confuso; pure, avendo a ritornare, restò paziente. E rimasto Filippo solo, era angustiato dalla novità della cosa, e, scarso di partiti, fluttuava come il mare di Pisa quando una libecciata gli soffia nel forame; per che e’ diceva: «Se io mi sto cheto, e contento Michele con un fiorino, io divento una sua vignuola, fommi suo debitore, confesso il peccato, e di innocente divento reo; se io niego senza trovare il vero della cosa, io ho a stare al paragone di un fanciullo, hommi a giustificare seco, ho a giustificare gli altri, tutti i torti fieno i mia; se io cerco di trovarne il vero, io ne ho a dare carico a qualcuno, potrei non mi apporre, farò questa inimicizia, e con tutto questo non sarò giustificato».
E stando in questa ansietà, per manco tristo partito prese l’ultimo; e fugli in tanto favorevole la fortuna, che la prima mira che pose, la pose al vero brocco, e pensò che il Brancaccio gli avesse fatto questa villania, pensando che egli era macchiaiuolo, e che altre volte gli aveva fatto delle natte, quando lo botò a’ Servi. E andò in su questo a trovare Alberto Lotti, verbigrazia, e narratoli il caso e déttoli l’oppenione sua, e pregatolo avesse a sé Michele, che era suo parente, vedesse se poteva riscontrare questa cosa. Giudicò Alberto, come pratico e intendente, che Filippo avesse buono occhio, e, promessoli la sua opera francamente, mandò per Michele, e abburattatolo un pezzo, li venne a questa conclusione: «Darebbet’egli il cuore, se tu sentissi favellare costui che ha detto di essere Filippo, di riconoscerlo alla boce?». A che il fanciullo replicato di sí, lo menò seco in Santo Ilario, dove e’ sapeva il Brancaccio si riparava, e faccendogli spalle, avendo veduto il Brancaccio che si sedeva fra un monte di brigate a dir novelle, fece che il fanciullo se gli accostò tanto, che l’udí parlare; e girandosegli intorno, veggendolo il Brancaccio, tutto cambiato se li levò dinanzi: donde a ciascuno la cosa parse chiara, di modo che Filippo è rimaso tutto scarico, e il Brancaccio vituperato. E in Firenze in questo carnasciale non si è detto altro, se non: «Se’ tu il Brancaccio, o se’ il Casa?»; «et fuit in toto notissima fabula celo». Io credo che abbiate aúto per altre mani questo avviso; pure io ve l’ho voluto dire piú particulare, perché mi pare cosí mio obbligo.
Alla vostra io non ho che dirvi, se non che seguitiate l’amore totis habenis; e quel piacere che voi piglierete oggi, voi non lo arete a pigliare domani; e se la cosa sta come voi me l’avete scritta, io ho piú invidia a voi che al re di Inghilterra. Priegovi seguitiate la vostra stella, e non ne lasciate andare un iota per cosa del mondo, perché io credo, credetti e crederrò sempre che sia vero quello che dice il Boccaccio, che gli è meglio fare e pentirsi, che non fare e pentirsi.
Addí 25 di febbraio.
Niccolò Machiavelli in Firenze

