Annie Ernaux e “Le jeune homme”
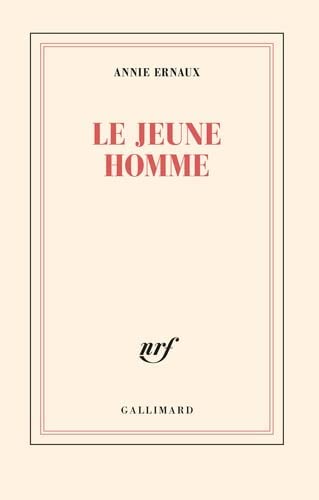
di Ornella Tajani
Le roman est impossible.
A. E.
Annie Ernaux conferma il suo talento in ogni testo che scrive, anche nell’ultimo Le jeune homme, apparso in Francia a maggio per Gallimard: il racconto della passione per un ragazzo di vent’anni, nel momento in cui lei era già una scrittrice cinquantenne, diventa una sorta di dispositivo immaginifico della memoria, sia sul piano dell’esperienza, sia su quello della scrittura. I mesi trascorsi con A. scorrono per l’autrice sopra una sorta di nastro di Krapp: tutto è già stato vissuto, le strade di Rouen in cui passeggia con lui sono le stesse che percorreva quando era una studentessa di lettere; l’ospedale dirimpetto all’appartamento in cui fanno l’amore è quello in cui era stata ricoverata in seguito al tentativo di aborto clandestino raccontato in L’événement.
Questo è senz’altro uno dei punti di forza di Ernaux: ogni nuovo testo è un tassello di una medesima opera più grande, unitaria, un’auto-socio-biografia che racconta il suo percorso di donna, di intellettuale, e nel farlo dipinge sullo sfondo l’affresco di un’epoca e uno spazio attraversati dalla lotta di classe.
Le storie di Ernaux non sono mai soltanto ciò che sembrano: ogni episodio travalica i confini del vissuto e produce riflessione, discorso. È questo uno dei sensi dell’esergo: «Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues». L’idea della scrittura come compimento e (ri)significazione insegue un’elaborazione che aggira il percorso psicanalitico e ripercorre le tracce di esempi letterari classici: se proustianamente il ricordo è una forma di passione, per l’autrice la passione è già una forma di scrittura, e qui di ricordo. A questo proposito, l’incipit può trarre in inganno e sulle prime apparire stucchevole: «Souvent j’ai fait l’amour pour m’obliger à écrire», ma a ben guardare si rivela una provocazione; l’amore, anche fisico, è sempre per Ernaux il motore di un’analisi introspettiva che si spinge ben oltre la relazione di volta in volta narrata. Qui il ragazzo amato rappresenta «le passé incorporé», e, più avanti, è visto da lei come la propria stessa morte: «il était ma mort» (il giovane amante come incarnazione della propria morte è, peraltro, una figura tipica nell’opera di Jean Cocteau).
Quasi tutto il senso del racconto è racchiuso in ciò che A. dice nel momento in cui vede una foto di lei da giovane, al tempo in cui l’autrice aveva la sua stessa età: «cette photo-là, elle me fait de la tristesse» – frase emblematica di una dolorosa impossibilità, ma che ben suggerisce il gigantesco déjà-vu (déjà-vécu) che è al centro di questo piccolo libro.


