Quattro romanzi: Nunez, Svensson, Grossman, Kloeble
di Gianni Biondillo
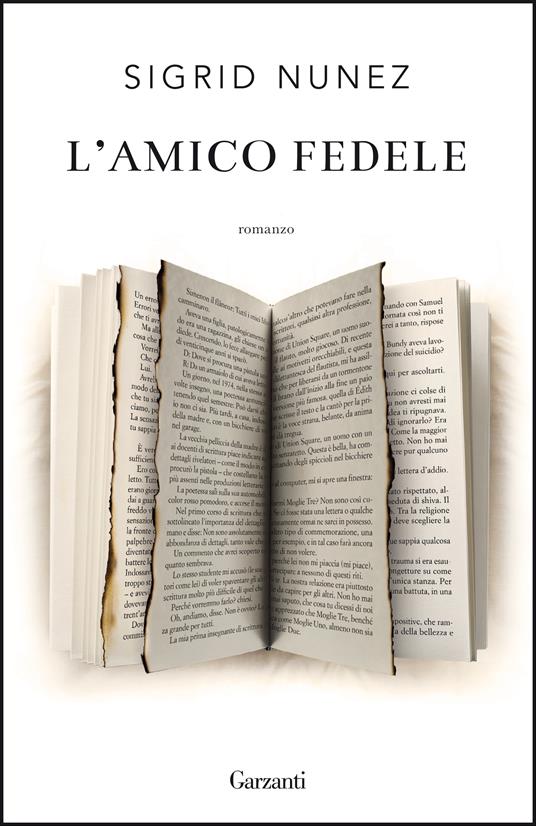 Sigrid Nunez, L’amico fedele, Garzanti, 220 pagine, traduzione di Stefano Beretta
Sigrid Nunez, L’amico fedele, Garzanti, 220 pagine, traduzione di Stefano Beretta
Lei insegna scrittura creativa all’Università. È americana, ceto medio, colta, ha un romanzo che deve scrivere e una sempre maggiore intolleranza per i suoi studenti che appaiono interessati solo al successo e non innamorati, come lo era lei da studentessa, dei dolori romantici che la letteratura produce. Da giovane aveva avuto come docente uno scrittore affascinante e coltissimo. Il suo mentore. Che ora si è suicidato, lasciandole in eredità un alano, anziano, enorme, dal nome altisonante: Apollo.
Chi è L’amico fedele del titolo del romanzo di Sigrid Nunez? È lo scrittore a cui si rivolge l’io narrante (aderente all’autrice in modo imbarazzante)? È il cane taciturno, distaccato, che la protagonista doveva tenere solo per qualche settimana prima di trovargli una sistemazione? A chi dà del tu per davvero la narratrice?
Romanzo che è anche metaromanzo, questo della Nunez. Libro che parla di libri, costellato di un’inifinità di citazioni, criptiche od esplicite, che spaziano sull’intero canone occidentale. Ogni pensiero della narratrice ha già avuto qualcuno che lo ha espresso meglio. Capisco come un libro così possa aver entusiasmato la critica americana: finalmente un romanzo dove, nei fatti, non succede niente. Dove l’indagine è tutta interiore e allo stesso tempo letteraria. Una specie di rivalsa della scrittura sulla trama.
A chi parla la narratrice? Di che parla? Di amicizia, il più nobile dei sentimenti umani. L’amicizia perduta con l’amico scrittore. L’amicizia nata con Apollo, ancora più sublime e commovente. E il romanzo in fondo non è altro che una lunghissima seduta psicanalitica (molto newyorkese e letteraria) della protagonista che non ha mai accettato la perdita dell’amico, preparandosi alla perdita inevitabile del cane ormai anziano. Una lunga lettera d’addio, a ben vedere. Il suo modo di superare il lutto attraverso la letteratura.
*
 Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta
Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta
Mai avrei immaginato nella vita di entusiasmarmi leggendo un libro che parla di anguille. Potenza della letteratura, capace di rendere ogni argomento un mistero da sondare. Ché Patrik Svensson mica ha scritto semplicemente un libro sulle anguille. Non è un saggio, questo, non è un romanzo, non è neppure un memoir. È un oggetto narrativo indefinibile.
Nel segno dell’anguilla è un libro che parla di passioni e di ossessioni. La passione per la pesca delle anguille del padre e del piccolo Patrik che lo segue nelle notti insonni creando col genitore un legame indicibile (non si dicono praticamente nulla, le poche cose che scambiano riguardano la pesca) e indissolubile. L’ossessione crescente per il misterioso animale che Patrik confessa di non mangiare neppure, trovandolo troppo grasso e saporito. E l’ossessione dell’intera cultura dell’Occidente, che ha dovuto scontrarsi con questo animale curioso, inventando attorno a lui, di secolo in secolo, mitologie e leggende. E poi, alternando capitoli di storia personale a capitoli su scienziati, filosofi, poeti che si sono interessati al mistero dell’anguilla, osserviamo la crescita del narratore, la sua maturità, analoga a quella della scienza che nei secoli – da Aristotele a Spallanzani, da Freud a Schmidt – ha cercato di avvicinarsi al mistero insondabile di questo animale che non sembra neppure un pesce, che nasce in un mare leggendario per attraversare gli oceani e vivere nei fondi limacciosi di rivoli d’acque dolci dell’Europa.
Infine, in parallelo alla fine imminente del padre malato, la fine di una specie animale che esiste da milioni di anni, per colpa dei cambiamenti climatici e dell’intervento umano. Il tempo è l’altro grande tema di questo libro. E l’eternità. Che forse le anguille conoscono e che Svensson cerca di capire osservandole, con passione e ossessione.
*
 David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni
David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni
Vera compie novant’anni. Quale migliore occasione per festeggiarla, attorniata da tutta la sua famiglia e dai suoi affettuosi conoscenti del kibbutz? L’esistenza di Vera è stata così intensa che è come se avesse vissuto due vite. Quella della sua giovinezza, in Iugoslavia, dove conobbe l’unico amore della sua vita, Miloš, col quale ha combattuto nella Resistenza. E l’altra vita, quella in Israele, quando si trasferì anni dopo con sua figlia Nina. In mezzo un buco, un vuoto di senso: l’accusa di alto tradimento, il suicidio del marito, la prigionia in un campo di rieducazione, l’abbandono coatto della figlia ancora bambina. Ma è proprio attorno a quel buco, a quel baratro che si gioca il buio profondo di tutti i personaggi presenti in La vita gioca con me.
David Grossman, ispirandosi a un personaggio davvero esistito e davvero ammirato, si pone dalla parte di chi non ha la forza di una irreprensibile dirittura morale quale quella di Vera. Come ci saremmo comportati noi, si chiede implicitamente, di fronte alla possibilità di sfuggire al gulag rinnegando il proprio amore? E quali le conseguenze di tale scelta radicale?
A chiederselo, nel romanzo, è Ghili, la nipote, figlia di Nina (donna tormentata dal rapporto irrisolto col monumento vivente che è sua madre) e di Rafi, il figlio del secondo marito di Vera, conosciuto giunta in Israele. Questi quattro personaggi alla fine progettano, ognuno per ragioni differenti, di intraprendere un viaggio nel baratro del tempo, sull’isola di Goli Otok, in quello che fu il campo di prigionia di Vera. Memoria ingannevole e allo stesso tempo scolpita come pietra, amore incondizionato e irruzione tragica della Storia, patto generazionale e dramma familiare: nelle mani di altri scrittori tale e tanto materiale sarebbe deragliato verso un melò lacrimevole e insostenibile. Ma, fortunatamente per noi, Grossman non è uno scrittore come altri.
*
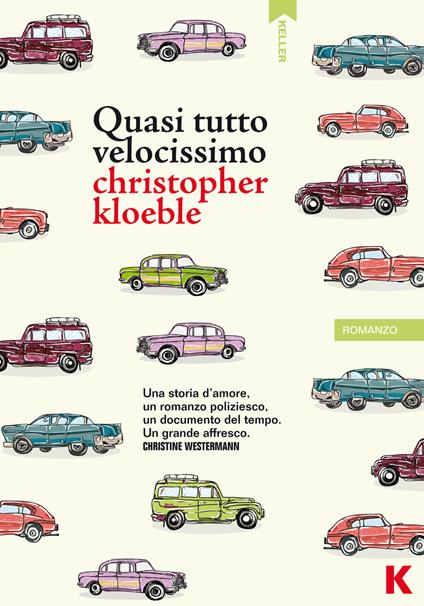 Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti
Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti
Fred ha sessant’anni ma è come se ne avesse sei. Ad accudirlo come un padre è stato suo figlio Albert, diciannove anni appena compiuti, cresciuto senza madre in un orfanotrofio gestito da suore, nel cuore della Baviera. Il loro tempo è scaduto, a Fred, che ha passato la vita a contare le macchine verdi passare per strada o a leggere voluminosi vocabolari, mancano pochi mesi di vita. Albert, prima di perderlo, decide di scoprire le sue origini, di sapere chi era davvero sua madre. Ma Fred, l’unico custode della verità, non può essergli d’aiuto. È solo un peso, “un quarto di genitore”, un incapace.
Messa così sembra una storia triste. Ed in effetti i personaggi e le situazioni che Christopher Kloeble mette in campo, sono intimamente tragici: storie di povertà estrema, di manie, di incesti, di infanticidi, di guerre e di follia. Ma la forza di Quasi tutto velocissimo sta nella capacità di rendere credibile anche il più incredibile dei personaggi, di rendere appassionante anche la situazione più urticante. E ce ne sono tanti di personaggi, uno più eccentrico, sbalestrato, surreale dell’altro. Tutti assolutamente sopra le righe, come se, viene da credere, nelle prealpi bavaresi possano vivere solo freak, matti, inetti o klöble, come li chiama l’autore, evidentemente autoironico.
Eppure nessuno di questi viene trattato come un mostro da baraccone. In questa ricerca delle origini, con una storia parallela che parte un secolo prima e si ricongiunge solo alla fine alla trama principale, Kloeble sembra dirci che la norma, nella vita, è l’eccentricità, che le regole sociali sono puro artificio, che dentro ognuno di noi alligna l’assurdo, il torbido, il primitivo, il lutto. Ma anche la compassione, l’amore e persino estasianti momenti di pura felicità.
*
(pubblicati precedentemente su Cooperazione nel 2020)


Letto Svensson. molto interessante. Nemmeno io avrei immaginato di riuscire ad arrivare fino alla fine di questo libro che non è un romanzo, o non solo, ma molto di più. Una lettura che mi ha preso e mi ha fatto viaggiare come un’anguilla nel tempo e nello spazio. Lo consiglio.