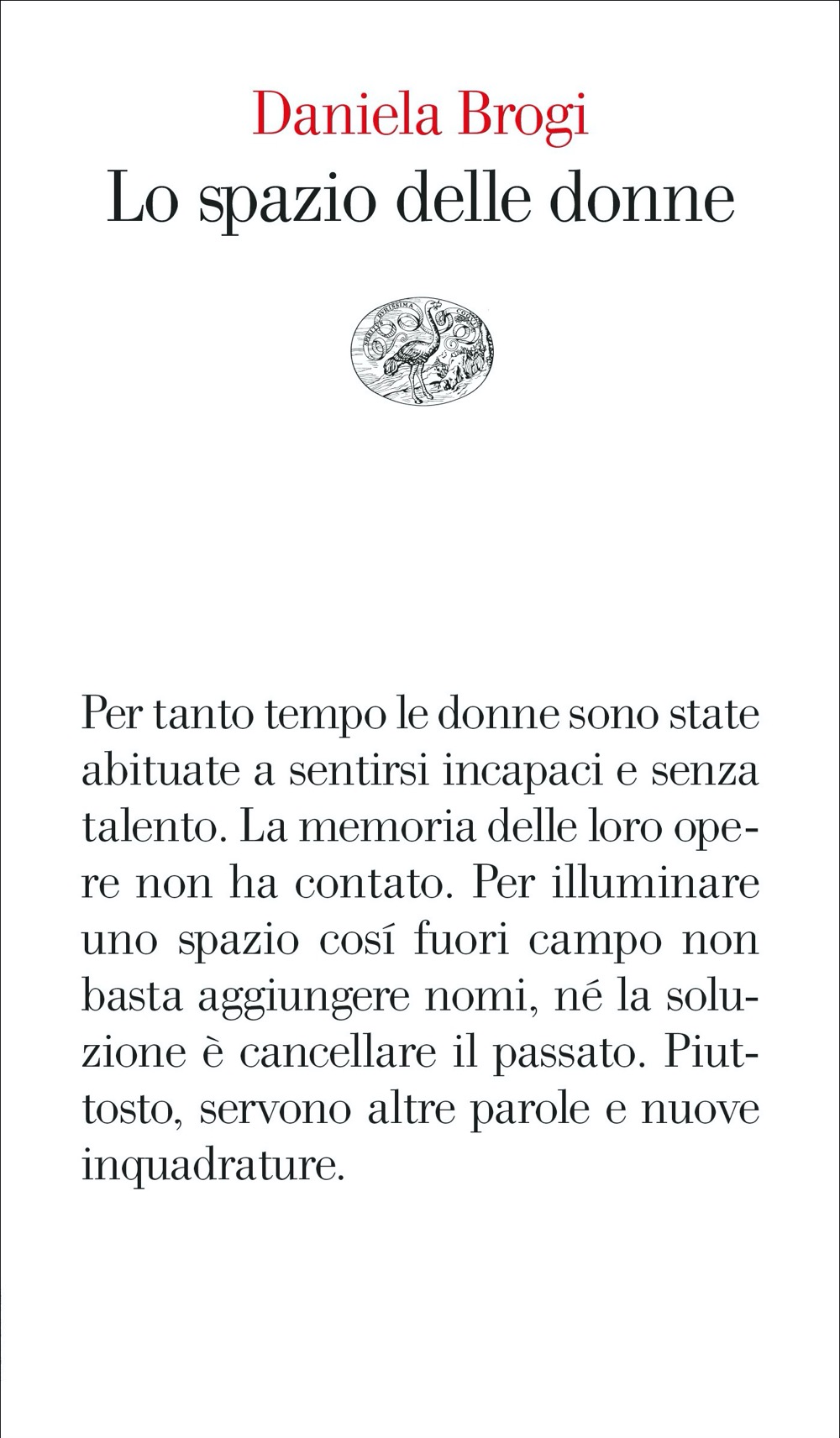Lo spazio delle donne e il loro sguardo: il fuori campo attivo che ridisegna il mondo

di Francesca Scala
Lo spazio di cui ci parla Daniela Brogi è il territorio fisico, psichico, artistico, sociale e politico che, per secoli, è stato usurpato alle donne (sul piano della storia e del diritto). Ma è anche lo spazio che le donne sono chiamate a ridefinire (sul piano cognitivo) da quel punto d’osservazione fuori campo da cui è possibile guardare e riconsiderare attivamente l’assetto dato per ripensarlo e trasformarlo (sul piano dell’azione e della realtà) in un luogo abitabile da parte di tutti (ragazze, donne, altro) in maniera diversa: più giusta, non discriminante, paritaria ed equa.
Le donne di cui ci parla Daniela Brogi sono poste come soggetto fin da subito, in quanto titolari di un diritto inalienabile: il diritto di occupare uno spazio vitale e visibile. E poco importa che questo loro diritto sia stato costantemente e ovunque reso indisponibile da una cultura che ha scempiato, mutilato e distorto la realtà, marginalizzando, oscurando, denigrando da un lato, ed erigendo un sistema di valori monologico (per usare un termine caro all’autrice) e monologante dall’altro. Non per questo le donne smettono di affermarsi come soggetto, dal momento che di quel diritto non hanno mai smesso di essere titolari. Il sottotesto, invece, con cui siamo cresciuti e con cui continuiamo a essere subliminalmente nutriti, l’idea che nessuno avrebbe mai il coraggio di sbandierare apertamente se non per criticarla – pena una levata di scudi generalizzata -, ma di cui è intrisa in realtà la cultura a cui in varia misura apparteniamo tutti, è che le donne siano cose. E allora che un libro, fin dal suo titolo, elimini dal nostro orizzonte mentale la possibilità di guardare alle donne come a un oggetto, che sgombri il campo dalla semplice ipotesi di considerarle come tali e che, soprattutto, lo faccia senza lasciare alcuno spazio a quell’ipotesi, estromettendola cioè dal discorso, è cosa degna di nota. È cruciale: significa porsi fuori dal discorso patriarcale, sovvertirne i termini, negarli a priori e implicitamente così da far passare il messaggio in modo più efficace. Per una volta, insomma, presupposizioni e impliciti che, come insegna Lombardi Vallauri sono spesso al servizio di una lingua disonesta (di una lingua cioè che sfrutta l’abbassamento dell’attenzione del ricevente per trasmettere contenuti discutibili), vengono piegati allo scopo eroico di combattere ad armi pari una cultura patriarcale e monologica e servono a ribaltare una percezione dominante e discriminante, a ristabilire giustizia e veridicità cognitive.
Un altro degli elementi di ricchezza di questo libro (che offre peraltro mille spunti di riflessione) è la sua trasversalità, la prospettiva molteplice che adotta: artistica, letteraria, sociale, storica, politica e linguistica. In questo modo riesce a fornire una sorta di metodo – suggerendo l’idea che l’approccio alla questione di genere vada condotto su tutti i piani e in ogni ambito – e riesce a dimostrare ciò che sul finale, nella quinta parte, espressamente dice, ossia che «il patriarcato non è la preistoria». Ribadirlo è importante, esemplificarlo pure: a ogni livello, spaziando in lungo e in largo fra gli argomenti, così come scendendo nelle profondità della lingua fino a portare a galla la novità di certi accostamenti semantici (“amica” e “geniale”), che reimpostano il pensiero o che almeno lo aprono a significati a lungo interdetti dalla consuetudine ottusa di «un mondo in cui … l’unica possibilità di intendere e riconoscere il genio, in quanto potenza creatrice, è stata solo maschile»; fino a snidare e a correggere parole intrise di condiscendenza, vezzeggiativi o diminutivi che si erano fatti vulgata sostituendosi alla Storia (Brogi parla ad esempio delle “suffragiste”, facendo notare come il termine sia «più appropriato di ‘suffragette’», in quanto restituisce serietà alle lotte femminili per il suffragio universale che serie furono e che non vanno in alcun modo sminuite); fino a riattivare il senso originario di sintagmi che l’uso, spesso stoltamente improprio, ha fatto smarrire: il “politicamente corretto”, se si rimane «nella lettera e nella sostanza dell’espressione, non è un’opzione, ma una condizione di esistenza e convivenza»; fino a fare esistere, per il fatto stesso di nominarle, le “opere d’autrice” e “le maestre del pensiero”.
E il dispositivo privilegiato per disattivare certi automatismi di percezione e di immaginazione è il fuori campo attivo, che consente di scardinare «schemi e modelli cognitivi in cui le donne mancano sempre dalle caselle del prestigio», quegli schemi, cioè, e quei modelli che «hanno prodotto e riproducono discriminazioni di genere naturalizzate». È il fuori campo attivo lo strumento fondamentale per ribaltare un destino, per riconoscere come limitato, relativo, storicamente datato, non eterno, non immutabile l’assetto della realtà che abbiamo ereditato. E, per certi versi, questo strumento di analisi ricorda le “lenti di genere” che Paola Di Nicola, ne La mia parola contro la sua, ci esortava a indossare, sottolineando, peraltro, che indossarle «È una fatica improba perché vuol dire disarticolare discorsi spesso unanimemente condivisi […] comodi stereotipi […] inconsapevolmente introiettati»: «stereotipi che saturano ovunque l’aria», dalle case private alle aule di giustizia.
In questa fatica improba Daniela Brogi ci accompagna e ci scorta, aiutandoci a sfatare certi miti ancora in auge, come per esempio l’idea che le cosiddette quote rosa premino chi non se lo merita, che la lotta contro il patriarcato sia una lotta contro chi è geneticamente e fenotipicamente maschio e che a condurla debbano essere unicamente le donne. Anche solo per questa ragione il suo viatico meriterebbe di essere letto.