Intervista a Giorgio Ghiotti
Marino Magliani intervista Giorgio Ghiotti
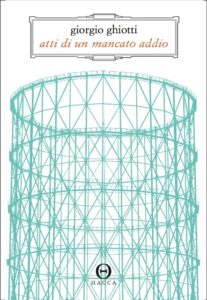 MM In “Atti di un mancato addio” un gruppo di ragazzi cresce – o almeno tenta di farlo – attorno alla sparizione di uno di loro, Giulio. Questa assenza, invece che oscurare, sembra illuminare i personaggi che la vivono. Allo stesso modo la voce si intensifica grazie alla rarefazione: sottraendosi, la parola si ispessisce. Qual è stato il tuo lavoro con il vuoto, con l’ellissi, nella trama e nella scrittura?
MM In “Atti di un mancato addio” un gruppo di ragazzi cresce – o almeno tenta di farlo – attorno alla sparizione di uno di loro, Giulio. Questa assenza, invece che oscurare, sembra illuminare i personaggi che la vivono. Allo stesso modo la voce si intensifica grazie alla rarefazione: sottraendosi, la parola si ispessisce. Qual è stato il tuo lavoro con il vuoto, con l’ellissi, nella trama e nella scrittura?
GG Nell’ultimo racconto del mio precedente libro di racconti (“Gli occhi vuoti dei santi”), scrivo che “crescere è un buco arrugginito e bellissimo, un solco lunare”, insomma un grande vuoto. Dove c’è un vuoto qualcuno ha fatto spazio, ha estirpato, ha fatto un passo indietro. Il vuoto è la possibilità per le cose di compiersi. Quindi anche per le persone, per le scelte, per i desideri. Per questo amo di più i vuoti e meno i pieni: più la provincia e meno le città (Roma fa eccezione, ogni quartiere è come fosse un paese), più il silenzio e meno il chiacchiericcio continuo ch’è proprio del nostro tempo. Ricordo dei bellissimi versi di Valerio Magrelli, allora ventitreenne al suo esordio con “Ora serrata retinae”, che dicono “Preferisco venire dal silenzio / per parlare. Preparare la parola / con cura, perché arrivi alla sua sponda / scivolando sommessa come una barca…”. Così si comporta questa storia – viene da un’assenza per poi proseguire il cammino –, così si comporta la scrittura di questo libro – illumina immagini senza spiegarle, preferisce seminare indizi, che non sono misteri, ma pietre d’appoggio. Bisogna tornare dal buio con la luce per potersi riappropriare delle storie, e della propria storia. Lo dice perfettamente Silente in Harry Potter: “Anche nei tempi più bui è possibile trovare la felicità se solo uno si ricorda di accendere la luce”. Nel caso di questo romanzo, la felicità è un tono minore ma fondamentale per i protagonisti: è capire che si può continuare a vivere anche quando il tuo testimone viene meno, quando il tuo grande amore si trasforma in fantasma e i fantasmi si fanno più veri che mai.
MM C’è un intreccio di relazioni in “Atti di un mancato addio” che ha a che fare con la scrittura: molte sono infatti le citazioni, celate e palesi, che intarsiano il racconto. Scrivere per te è anche inscenare un discorso letterario?
GG Scrivere è per me sempre un discorso in sospeso che si riprende a ogni riga, e si porta avanti. Non credo possa darsi una discendenza senza una genealogia. Nelle pagine dei libri le storie cantano, e non solo le storie: le parole, i nomi, i gesti, si richiamano e poi si innovano. L’aggettivo ‘ricciuto’ o ‘riccioluto’, per esempio, è per me immediatamente Natalia Ginzburg; le contrade di Firenze mi portano subito al vociferare delle Ragazze di San Frediano di Pratolini; ogni banda di ragazzini selvaggi, spettinati, è in egual misura Il signore delle mosche e il Peter Pan. I libri cantano, ecco. Come le città. È che credi di guardare e ti rammenti. Non esistono un tanto di citazioni al lordo e un tanto al netto da mettere in un libro, sarebbe un libro falso, goffo, di studio eccessivo. È tutto naturale, tanto che a volte mi fanno notare dei possibili rimandi che ignoravo proprio. A volte ci sono, a volte no, ma ognuno nei libri legge quello che vuole.
MM La tua è una scrittura che si nutre del linguaggio poetico. Quale il confine tra le due scritture, se esiste, anche materialmente: due tavoli, due emisferi cerebrali, due momenti della giornata?
GG La prosa si nutre della poesia, cioè di quegli aspetti della poesia che, in qualche modo, possono sostenere entrambe le forme: una certa idea di ritmo, e di musicalità interna al verso/alla frase. Un immaginario d’infanzia e di giovinezza, un’infanzia e una giovinezza “complete come mondi” – scrisse quello straordinario scrittore che è stato Paolo Zanotti; il suo romanzo Bambini bonsai è per me l’opera di un grande poeta, è un libro di poesia. Perché la poesia la senti, ha un respiro inequivocabile, immagini feroci, parole taglienti. Insomma dal grande serbatoio della poesia la prosa non scaturisce (perché ha una sua vera e propria indipendenza), ma attinge a piene mani, per me.
Non scrivo mai, o quasi mai, poesia e prosa contemporaneamente. Non c’è un motivo preciso, semplicemente i versi non escono quando scrivo un racconto o un romanzo e viceversa. Anche se poi, come ho appena detto, l’una e l’altra sono sempre presenti in modi diversi. E questa alternanza di tempi tra la scrittura in prosa e quella in poesia è tremenda: ogni volta che ho un romanzo fuori e devo presentarlo, sto in realtà lavorando a un nuovo libro di poesie, così che devo fare uno sforzo di memoria (e di immaginazione) per ricordarmi com’era, per me, stare nell’onda di quella storia. Di recente sto scrivendo molta poesia, e (novità dell’autunno, ora ormai inverno) quasi sempre al mattino. Una sezione del nuovo libro di poesia l’ho chiamata allora Le mattutine su consiglio di Vivian Lamarque, e la prima poesia semplicissima, fa così: “Ora scrivo poesie quasi solo al mattino. / Ecco una probabile spiegazione. / L’oscurità me la lascio alle spalle, / i versi mi escono semplici, chiari / a prova di bambino”.

