Quattro romanzi: Dard, Carlier, Réal, Castellanos Moya
di Gianni Biondillo
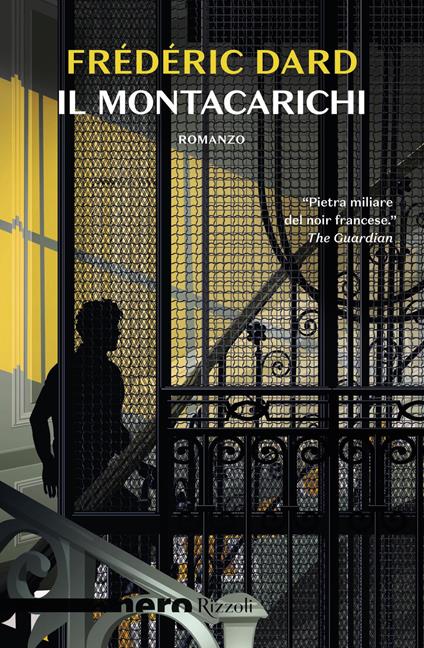 Frédéric Dard, Il montacarichi, Rizzoli, 2019, 139 pagine. traduzione di Elena Cappellini
Frédéric Dard, Il montacarichi, Rizzoli, 2019, 139 pagine. traduzione di Elena Cappellini
Un uomo torna a casa dopo anni. Una casa vuota. La madre è morta da tempo, lui non ha più nessuno. Gira per il quartiere, è la vigilia di Natale, alla ricerca di vita. Decide di fermarsi al tavolo di un ristorante, qui incorcia una donna con sua figlia, tristi, in un momento che dovrebbe essere familiare, gioioso, condiviso. L’uomo, che si chiama Albert, riconosce in quella donna la sua stessa solitudine. Un po’ per caso, un po’ per volontà, passerà la serata con lei. Ma quello che succederà, l’incredibile sucessione di colpi di scena che conviene non svelare, cambieranno radicalmente la sua esistenza.
Frédéric Dard è considerato un maestro del noir francese. Il montacarichi è un romanzo che uscì oltralpe nel 1961. Bisogna riconoscere che i quasi sessantanni, dal punto di vista della scrittura, spesso ingenua, si sentono. C’è un pudore nei dialoghi, sopratutto nelle scene più erotiche o sentimentali, che oggi fa sorridere. Il Dard del Sanantonio più maturo, quello ironico impastato di argot, qui ancora non ha fatto breccia.
Ciò non toglie che la macchina narrativa non sia mirabolante. Il romanzo, mai come in questo caso, si legge davvero d’un fiato. Dard mette in scena una rappresentazione al limite dell’inverosimile, eppure precisa e ineluttabile, grazie a una attenzione maniacale dei particolari.
Quando Dard dimentica le emozioni e lascia che il racconto si sviluppi per immagini diventa imbattibile. Leggendo il romanzo sembra quasi di vedere un film del miglior cinema francese in bianco e nero. Il montacarichi ha tutti gli elementi e i meccanismi di un giallo classico ma la risoluzione e il mood sono già quelli del noir più fecondo. D’altronde i quattrocento titoli da lui prodotti nella vita stanno a dimostrare quanto Dard fosse una vera e propria macchina immaginativa al servizio del lettore.
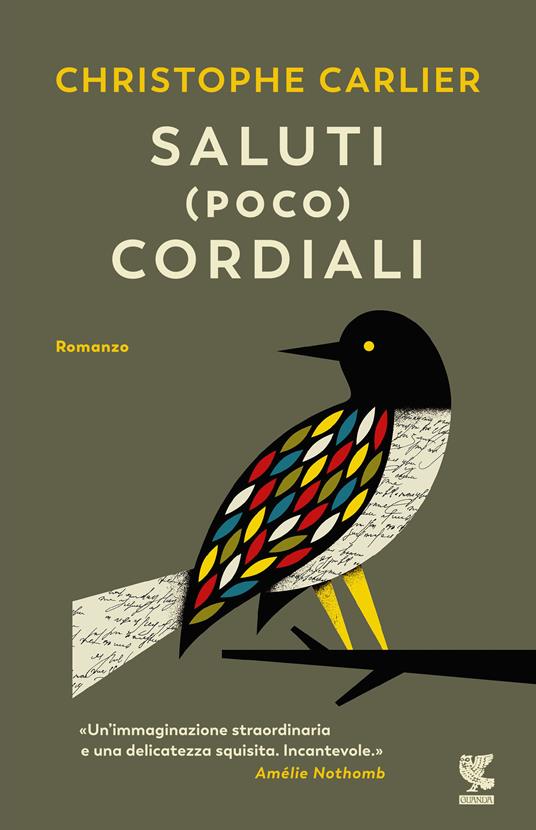 Christophe Carlier, Saluti (poco) cordiali, Guanda, 2019, 176 pagine, traduzione di Luciana Cisbani
Christophe Carlier, Saluti (poco) cordiali, Guanda, 2019, 176 pagine, traduzione di Luciana Cisbani
Forse è vero che finita l’estate, andati via i turisti, su un’isola non c’è molto da fare. Almeno così pare su quest’isola bretone, sferzata dal vento, dove con l’arrivo dell’autunno tutto pare pronto al letargo. Chissà, forse è stata questa la ragione che ha fatto spedire ad un abitante dell’isola una lettera ad un altro abitante dell’isola. Persone che si conoscono, che potrebbero chiacchierare tranquillamente al bar La Marine. Ma in un periodo in cui nessuno ormai conosce più l’arte della corrispondenza ecco che una delle sue più perverse derive riappare fragorosa: la lettera, insomma, è anonima. E non sarà l’unica. Con cadenza ineluttabile, abitante dopo abitante, chi più chi meno, riceverà la sua dose d’insinuazioni maliziose. Così, in un posto dove non succede niente, succederà di tutto.
Con Saluti (poco) cordiali Christophe Carlier sembra scrivere un saggio scientifico, illuminista. Mette in gioco i suoi piccoli, meschini personaggi e lascia che le buste anonime diventino le cartine di tornasole per raccontare la piccineria umana. L’isola è il suo laboratorio protetto, il luogo perfetto per un delitto a camera chiusa. Il crimine è la perdita di fiducia nel prossimo, la soffocante retorica della provincia, l’abisso che è presente in ogni comunità, anche piccina, anche graziosa.
Carlier scrive come se ci stesse raccontando una fiaba, no, di più: un apologo. La lingua è minimale, di puro servizio. Bastano i suoi pupazzi per la messa in scena. Che sianogiovani o anziani, uomini o donne nulla cambia. Là dove il mondo è perfetto, dove ci si conosce tutti, dove non capita mai niente, può bastare una busta anonima a far cadere la prima tessera del domino. L’effetto finale, sarà travolgente. E l’inverno, quanto meno, sarà passato.
 Grisélidis Réal, Il nero è un colore, Keller editore, 2019, 277 pagine, traduzione di Yari Moro
Grisélidis Réal, Il nero è un colore, Keller editore, 2019, 277 pagine, traduzione di Yari Moro
All’apparenza sembra semplice raccontare questo libro: Il nero è un colore è l’autobiografia di Grisélidis Réal, la storia, cioè, di una ragazza inquieta che fugge da una Svizzera sonnolenta con due dei suoi quattro figli, per seguire l’amante in Germania. Qui, in una puntuale descrizione di come un essere umano possa sprofondare sempre più, conoscerà miseria, fame, stenti, clandestinità, accattonaggio, fino all’esito finale, quello della prostituzione.
Eppure neanche una riga del libro è affetta da rimorsi. Grisélidis, alla ricerca della sua libertà, con spirito antiborghese, rivoluzionario, libertario, racconta la prostituzione, la fuga dalla polizia, dagli assistenti sociali, il suo amore per i soldati afroamericani (al contempo clienti e divinità sessuali), la sua vita in un campo di zingari, gli incontri notturni con clienti perversi e violenti, la sua iniziazione allo spaccio di hashish, il suo viaggio picaresco in Marocco per procurarselo, l’inevitabile esito finale, quello del carcere, racconta tutto ciò senza mai prospettare una consolatoria morale d’emancipazione, di ritorno alla normalità borghese.
Quella di Grisélidis Réal è un’estetica punk alla quale è escuso il nichilismo. La sua voce è inebriante, erotica, eccessiva. È forse l’ultima vera esponente di una bohème fuori tempo massimo. La più allucinata, simbolica, spudorata. È difficile in realtà parlare di questo libro. Che racconta la libertà, la sessualità, la violenza, l’anelito di vita oltre ogni limite. È difficile capire come una ragazza colta, borghese, amante dell’arte, possa aver raggiunto tali livelli di abiezione, eppure tutto nelle sue parole è vero, potente, credibile. Il nero è un colore è un inno alla libertà, all’amore per la diversità, i dannati, i dimenticati, i difformi. Kitsch e sublime al contempo. Indimenticabile.
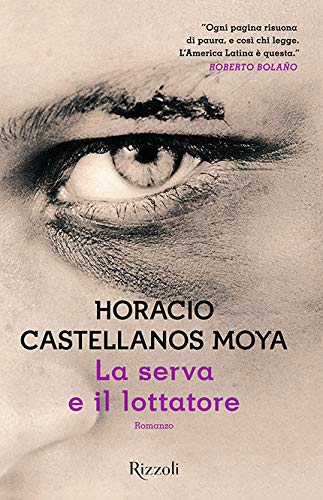 Horacio Castellanos Moya, La serva e il lottatore, Rizzoli, 252 pagine, traduzione di Enrica Budetta
Horacio Castellanos Moya, La serva e il lottatore, Rizzoli, 252 pagine, traduzione di Enrica Budetta
La serva e il lottatore racconta un’ordinaria giornata d’inizio anni Ottanta a San Salvador. C’è Rita la Gorda, che gestisce una bettola nei pressi della caserma militare, servendo cibo a facce poco rassicuranti, sbirri che sembrano criminali. E c’è sua figlia Marilù, adolescente preda degli sguardi lascivi degli uomini. C’è El Vikingo, un ex lottatore, avanti negli anni e sfatto nel fisico, che puzza già di morto, ma cerca di nascondere le sue condizioni di salute continuando il suo sporco lavoro di torturatore. C’è El Chicharròn, obeso e violento componente di uno squadrone della morte. Ci sono Alberico e Brita, rampolli della meglio borghesia del paese, figli di ricchi imprenditori e illuminati intellettuali, di ritorno dopo anni di esilio a casa e subito rapiti per essere portati nel Palazzo Nero, dove verranno torturati. C’è María Elena, anziana domestica di famiglia che deve rassettare la casa dei due rampolli, per poi trovarla vuota, comprendendo subito che i due giovani sono stati rapiti. C’è sua figlia Belka, infermiera che non vuole saperne di politica né dei sermoni del vescovo Romero, pensa solo a trovare un lavoro migliore per mantenere la sua famiglia. E c’è suo figlio Joselito, il nipote di María Elena, un ragazzo poco più che adolescente, con troppi grilli per la testa e troppo attratto dalle sirene della guerriglia.
Un’ordinaria giornata di violenza irrazionale, gratuita, ferina, angosciante. La lingua di Horacio Castellanos Moya è asettica come il suo sguardo sulla guerra civile salvadoregna. È uno sguardo anestetizzato dall’orrore. Ogni personaggio porta con sé una colpa, comprese le vittime. Ogni protagonista una ragione, compresi i carnefici. Tutti sono pupi nel grande teatro dell’assurdo di una America Latina metafora del buio dell’umanità.
(pubblicati precedentemente su vari numeri di Cooperazione nel 2019)

