Storia di un piano inclinato
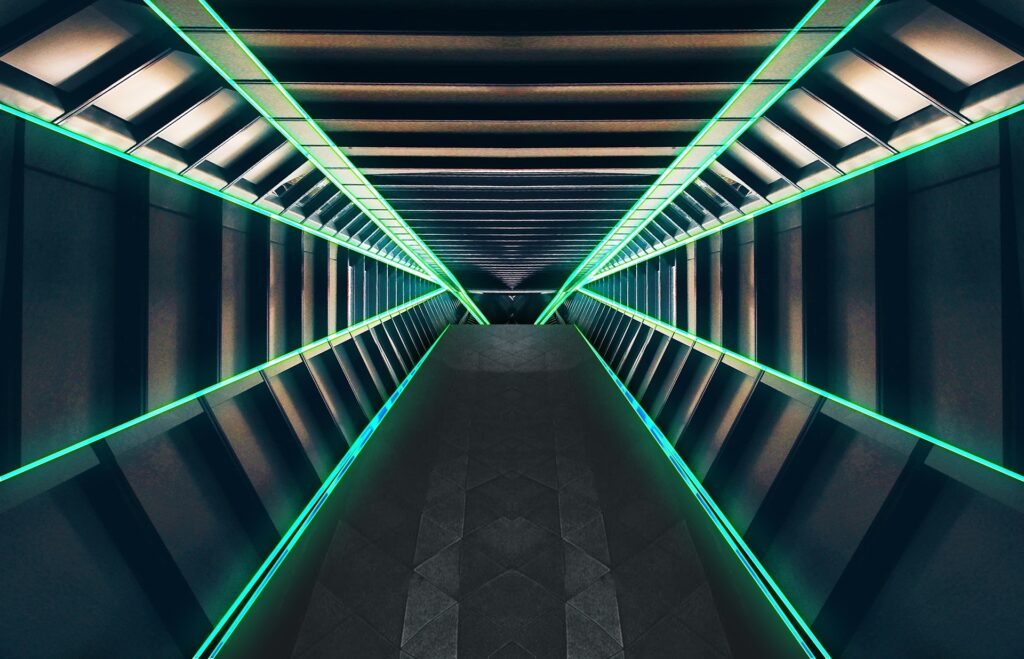
di Giorgio Castriota Skanderbegh
Il lato della faccia ti pulsa, mentre il finestrino prisma il sole fino a cuocerti lievemente la carne, la tua mano a fare da spessore con le dita incastrate tra tempia e vetro. Guardi il paesaggio tirarsi via in direzione opposta e, come tutti alla tua età, immagini (vedi, in effetti) l’ometto che corre equiveloce alla macchina, e che salta e schiva cartelli e cespugli; la differenza nel fatto che tu in quell’ometto ci vedi una versione in scala di Obi-Wan Kenobi [McGregor | Guinnes invece per l’acrobatico non va bene (e in più McGregor è la versione che conosci meglio, anche se non sai che tuo padre non è d’accordo con te)], che quindi ha anche la spada laser per fare a fette 1 ostacolo su 3 in una gioia di scintille. Non è una parte della città che ricordi, e in effetti le case sono sempre più lontane tra loro; normalmente non ci fai caso, ma le tue richieste di conoscere l’itinerario sono state testardamente e sospettosamente rimbalzate al mittente, con quel tipo di elettrica complicità che è quasi insopportabile quando ne sei al di fuori. L’esasperante cospirare non è finito a casa, e tuo padre – che guida con la mano destra mentre la sinistra gli circonda il mento, gomito sul davanzale del finestrino – lancia intermittenti occhiate impazienti a tua madre, e quando anche lei lo intercetta entrambi sorridono.
Tua madre è sul sedile del passeggero; da dove sei seduto, se solo giri la testa scollandola dal finestrino, puoi vederla mentre si batte le ginocchia a seguire la musica, e che indossa quel coso che è un paio di jeans che continua fino alle spalle e poi va dietro e ridiventa jeans. Nei capelli ha la maggior parte di un cerchio che sembra di plastica ma che è di tessuto in realtà. Quando non porta il tempo le sue mani si riposano a coppa, una dentro l’altra, e anche lei guarda fuori. Ti chiedi se vede anche lei l’ometto saltante, e da che film proviene il suo. Ride spesso: è di umore limpido.
Sei distratto mentre tuo padre fa quella cosa di girare il volante con il palmo di una sola mano che tu proprio non capisci, ma avverti comunque la forza centripeta che ti solletica verso il centro del sedilone di dietro, tutto il tuo corpo tirato via dalla portiera. Le ruote della macchina fanno ora quel rumore che fanno in tutti i ristoranti fuori città, e che tu associ a matrimoni e a parenti che non vedi molto spesso ma che quando li vedi hanno attenzioni particolari per le tue guance e proprio non vogliono lasciarti stare i capelli. Quando tuo padre viene ad aprirti la portiera e scendi dalla macchina provi la stessa sensazione sotto la gomma delle tue scarpe, quel cricchio cresimale, e vedi che però non sei a un ristorante; c’è un palazzo piatto e basso, e intorno ci sono cosi dove si coltivano (ti sembra) i pomodori. Sei ancora quasi attaccato alla macchina mentre tua madre ti porge la mano – tuo padre è andato avanti. La macchina fa uno scatto e lampeggia. Chiedi di nuovo spiegazioni, e di nuovo inutilmente. Tua madre assicura che ormai siete arrivati, e che non c’è da aspettare molto.
Papà si fa raggiungere e fuori dal palazzo piatto vi viene incontro un signore, che ha quei baffi grigi e quegli stivali alti verdi, e un pantalone-spalla-pantalone simile a quello della mamma, ma meno elegante e leggero. Ha anche un sorriso familiare, e chiaramente vi stava aspettando. Ora, subito prima di entrare, fa più caldo, e sei grato di varcare la soglia.
Decisamente non è un ristorante, pensi adesso; per prima cosa l’aria non è cambiata molto da fuori a dentro, in quanto a temperatura, e poi tutto ha quell’odore che non è esattamente sporco, ma che non è neanche di ossessivamente lavato. Il rumore poi; il rumore ti assale come un matto, e fisicamente preme contro le tue orecchie e pure contro la tua pancia; sulle prime non capisci che razza di frastuono ti sta arrivando con tanta ferocia, e perché non sentivi niente prima di entrare, poi il tuo cervello comincia a fare dei collegamenti; non vedi (perché stai guardando avidamente avanti) che tua madre e tuo padre non si perdono un momento del tuo processo di realizzazione, guardandoti e trattenendo le risate da in alto alla tua sinistra, e anche il Signore Baffuto assiste entusiasta. I tuoi occhi vedono – e il resto di te mano mano elabora – grandi piastrone di luci che piovono direttamente su quelle che ora capisci che sono gabbie. Adesso senti, e riconosci che il casino indistinto che non afferravi è quello che si può produrre solo dove c’è una grande concentrazione di cani. L’ultima parola la dici davvero, e talmente ad alta voce che tuo padre ti poggia una mano ovattante sulla cima della testa, ovattante ma non rimproverante; ora tiri alla mano di mamma come (guarda un po’) un cane tira il guinzaglio, e i tuoi piedi moonwalkano sul posto fintantoché un peso con cui non puoi competere ti trattiene. Ti vengono dietro, e finalmente vi avviate in una delle corsie in cui è diviso l’ambiente. Non sei mai stato in un canile, ma ne hai visti in quasi tutti i film che danno su certi canali, nel bene e nel male. Sono gabbie, sì, ma non rugginose e terribili, non buie e strette – non sono le gabbie dell’antagonista, queste, ecco –; i cani ti sentono e vedono da molto lontano, e prima ancora che tu sia realmente entrato nel corridoio tutti – tutti, fino a quelli che riesci a vedere più giù – gli occupanti delle gabbie si sono fatti avanti più che potevano, schiacciati contro le maglie tanto che una rete di rombi a negativo di pelo sporge fuori. Vuoi andare più in fretta, ma saggiamente i tuoi genitori mantengono il passo. Ti sembra di camminare in un unico grande abbaio costante.
Contro la prima gabbia in ordine di vicinanza si dimena un cane che il Signore dei Baffi chiama Colli o una cosa del genere; per la maggior parte del tempo sta su con le zampe incastrate nei punti di non-rete della rete di ferro, ma ogni tanto atterra di nuovo e fa una specie di piroetta, in qualche modo senza staccare gli occhi di dosso a te e a i tuoi genitori. Hai un bruciore che ti tira nella sua direzione – i tuoi arti non riescono né a stare né a direzionarti nel giusto modo, quindi la tua posizione è ferma dinamica, come il ritratto di qualcuno che scende le scale, né da una parte né dall’altra. Vedi Colli nella macchina, a dividere con te la forza centrifuga del sedile posteriore, steso in una coperta guardandosi intorno come se tutto fosse nuovo (ed effettivamente lo è), e vedi il suo angolo in casa tua, che pretenderai posto nella tua camera, dove metterai la suddetta coperta e almeno tre cuscini; e ti vedi passare i pomeriggi lì, a fare finta di leggere per la scuola ma in realtà a fare più attenzione a come fare più attenzione al cane mentre guardi il libro. Lo hai chiamato Batman.
Ora la tua mano ti ha superato, e con lei il braccio di tua madre che ci è attaccato, e lei e i due uomini ti guardano incoraggianti per proseguire. Sei ancora a metà del passo. La gabbia alla tua destra contiene un cane che è meno fluffo di quell’altro, ma che fa partire i tuoi occhi con i cavetti rosso e nero. Baffi lo chiama con un nome da uomo, anzi da signore: Rass, ma tu sai che non è giusto: è Milo, il cane di Jim Carrey in The Mask, e tiene le zampe al suo posto alla larga dal ferro, ma la sua coda è alta, e il suo sguardo, come quelli di tutte le creature in questo stanzone, è fisso laser su di te. Il suo atteggiamento cambia quando siete in macchina, e allora sì che alza le zampe sul coso poggia-gomiti e guarda fuori, occasionalmente saltellando sulle tue cosce per poi ritornare a non perdersi niente del panorama scorrevole. Gli piace stare sul divano e guardare i cartoni con te, e gli mostri dov’è che l’hai visto per la prima volta, e lui guarda attentamente la sua precedente carriera, e chi è quel signore con la faccia verde che va così veloce e non sta zitto un attimo. È Natale e gli hai ormai insegnato a non saltare sull’albero, anche se è pieno di giochi chiaramente per cani. Lo vuoi chiamare Batman, ma per ovvie ragioni (e per ulteriore ignoranza di copyright) lo chiami Milo.
C’è ora un dondolio interrogativo nella tua mano, inferto da tua madre che ti sta guardando come prima, solo stavolta con il sorriso non esattamente in pieno spolvero, come scalini sbeccati dalla pioggia, e tuo padre toglie una mano dalla tasca; ma tu non percepisci niente di tutto questo, perché nei hai visto un altro (che chiami Batman) e per il quale hai fatto comprare appositamente una di quelle piscine rotonde gommose che non riempi d’acqua perché non hai il giardino, ma che va bene lo stesso come letto/arena di gioco, e questo decisamente lo hai chiamato Batman, e gli piace quando stai appena per chiudere gli occhi saltare sul tuo letto e ingirellarsi di fianco, vicino alla tua pancia; ma vedi che c’è un altro Batman che ti guarda dalla gabbia successiva, che porti con te la sera a passeggiare quando hai quasi finito la scuola superiore; e ma nella gabbia accanto ci sono altri due Batman insieme – che a questo punto uno è Robin – che hanno le code a metronomi sfalsati e ogni tanto fanno un piccolo abbaio, e siete insieme al mare a prima aspettare il- e poi scappare dal- piatto piano di onda che arriva fino alla fine della spiaggia più scura, e poi correte di nuovo dove la sabbia bagnata si strizza con le vostre orme cambiando tonalità. Ma ti sei distratto dalla singola gabbia ora, e vedi che il numero è uno che non sai contare, che ce ne sono, che c’è una dietro l’altra, e puoi vedere contemporaneamente il Batman di quella più vicina e della prossima, e anche di quella dopo; infinite gabbie, infiniti cani, infiniti viaggi in macchina di ritorno, quello che non vedi più è la fine della stanza, la parete opposta a quella da cui siete entrati – al suo posto c’è ora un cielo stellato che non sta fermo e sfrigola, le stelle che navigano a destra e sinistra e ritorno, lasciando la scia: devono essere stelle comete; e il frastuono canaio non c’è più, ti rendi conto, e nelle tue orecchie c’è solo e soltanto il Tempo che urla per essere ascoltato, ma urla mooolto lentamente, e la sua voce è diventata mooolto grave; Aspetta, gli senti dire da una grande distanza, e ora la spalla ti fa male, ora le stelle sono più forti e grasse, e pulsano di calore che senti tutto sulle guance, e la spalla ti fa male e non sai perché; poi le ginocchia, che comunque non riesci a guardare, sbattono forte, e le stelle recedono per un momento per poi tornare più forti di prima, e la spalla ti fa male; il Tempo urla sempre più vicino a velocità normale, ora, e sta urlando il tuo nome, e tu lo senti pressare contro le orecchie; la spalla non ti fa male più e la tua mano viene finalmente lasciata, che è un sollievo perché sei veramente stanco, e le ginocchia hanno battuto troppo forte; allora apri la bocca per dire che sei molto stanco, ma ora i tuoi occhi si chiudono senza l’aiuto delle palpebre, e quando si riaprono le stelle sono ora davanti a te, e sotto la tua testa c’è il duro, e un anello di teste di Mamma Papà e Baffo non riesce comunque a oscurare le stelle che brillano talmente forte che devi chiudere gli occhi per davvero, ora. L’unica e ultima cosa che riesci a pensare è a quanti Batman e occasionale Milo ci sono intorno a te, tutte le permutazioni di possibilità, le stringhe di tempo che convergono tutte nella fotografia di un te più adulto in piedi di fianco a un buco nel terreno.
È la guancia che ti fa aprire gli occhi questa volta. La luce nella stanza è di nuovo troppa, ma questa volta è statica, e non arrivano urla alla porta dei tuoi timpani che pretendono di entrare subito; anche i gorgheggi canari sono spariti. Capisci dove ti trovi – l’hai visto in televisione – e lo sguardo ti saetta alle braccia, e con sollievo constati che non ci sono tubicini che escono dai tuoi polsi, e neanche (deduci) quel coso che fa bip e disegna la linea spezzata. Tua mamma si avvicina al letto in meno di un movimento, come saltando un frame: un attimo è alla porta, un attimo è attaccata al tuo letto e ti struscia la mano sulla faccia, delicatamente, e ti tocca tutte le parti della testa come cercando difetti strutturali. Allora avverti il bubbone che hai alla base del cranio sotto i capelli, e trasalisci al solo tatto. Una signora con un camice bianco che finora non avevi visto ammonisce di non esagerare e tua madre rilutta ma ti adagia di nuovo sul cuscino, con la testa reclinata da un lato. Ah, sei a letto. Papà appare sull’uscio con due bottigliette sudate tra le mani e quando vede la scena si affretta anche lui, parlando qualche parola vestita per suonare più sicura di quello che è davvero; eccoli lì: Baffo è sparito, e ora ci sono Mamma Papà e Signora che ti stanno intorno. L’odore è marcatamente più pulito. Il soffitto è normale.
Non capisci quello che è successo, non davvero; vedi soltanto quello che puoi percepire esternamente. Vedi Mamma e Papà che parlano con la Signora che ti indica con mano ottimista, e vedi che ogni tanto lanciano uno sguardo nella tua direzione; non capisci perché ogni volta che provi a pensare ai tanti cani, alle tante possibilità di prima, ti minaccia un mal di testa che aspetta giusto fuori dal campo visivo; e soprattutto non vedi che nel corpo dei tuoi genitori c’è quell’ombra lunga e stanca di chi crede di aver visto il tuo futuro.

