Diario della pandemia dall’Himachal Pradesh # 4
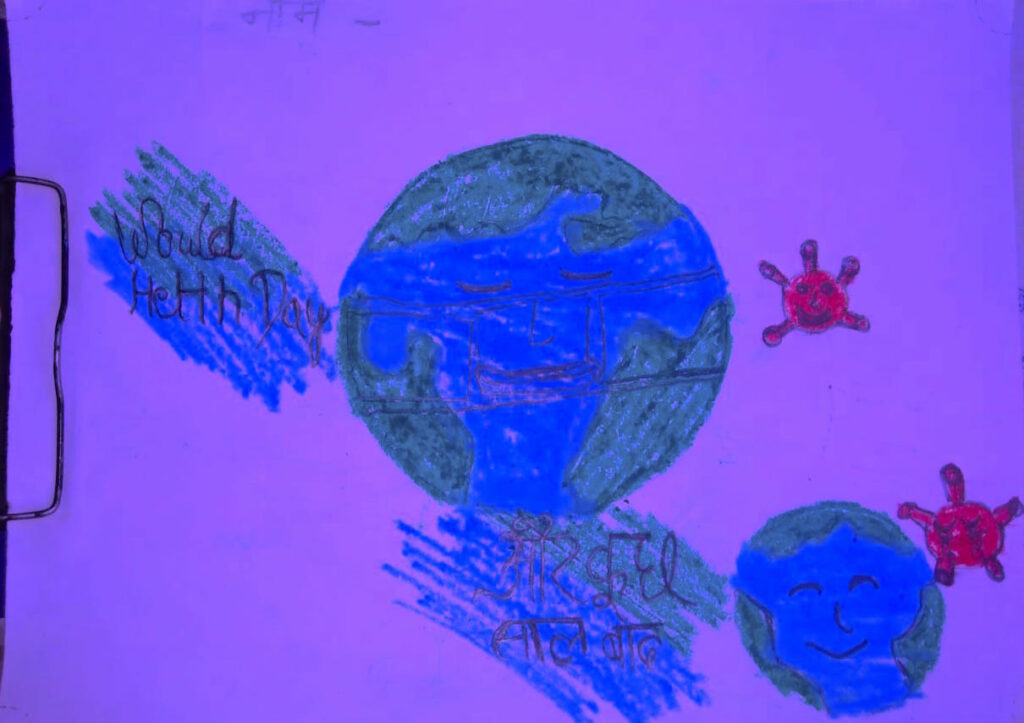
di R. Umamaheshwari [foto di Sushant]
R. Umamaheshwari è una storica e giornalista che vive in India. Ha pubblicato When Godavari Comes: People’s History of a River (Journeys in the Zone of the Dispossessed), Aakar Books, New Delhi, 2014; Reading History with the Tamil Jainas: A Study on Identity, Memory and Marginalisation, Springer, 2017 e From Possession to Freedom: The Journey of Nili-Nilakeci, Zubaan, New Delhi 2018. Un anno fa ha cominciato a scrivere un diario della pandemia dall’Himachal Pradesh che pubblichiamo a puntate. Qui la prima, qui la seconda, qui la terza. Quella che segue è la quarta.
1 Aprile 2020. Che fine fa la donna single?
Che fine fa la donna single, che vive da sola, lontano dalla sua casa (se ne ha una, cioè ammesso che ne abbia una), o dalla sua città, nel mantra che recita “Resta a casa, stai al sicuro” concentrato esclusivamente sull’idolatria della famiglia e sull’idea che ad ogni casa corrisponda una famiglia? Lei non appartiene a nessun luogo.
Comunque, l’idea che la famiglia sia necessariamente quella dove sei nata è piuttosto riduttiva. Quanto a me, io sento di avere famiglie fatte non di parenti di sangue, ma di persone che hanno saputo aprirmi le loro case quando attraversavo i loro villaggi e città, come viaggiatrice, o come ricercatrice, o come giornalista, o semplicemente come una donna single e sola. E in ogni caso, cosa produrrà questa paura del virus? Porterà via quell’apertura di cuore della gente in giro per il mio Paese e per il mondo, chiuderà le porte e renderà univoca la definizione di famiglia, come singola unità in cui uno è nato? Sarebbe un mondo abbastanza chiuso per una persona come me. Essere senza casa è ancora abbastanza gestibile, ma essere privata dell’accesso alle molte famiglie che incontro, e alle loro case e ai loro cuori sarebbe un durissimo colpo. Sarebbe pura solitudine e morte.
Ma può la basilare esigenza umana di vivere in società e in relazione, e di stringere legami, cambiare così tanto a causa di una nuova malattia? Specialmente quando queste nuove malattie hanno incrociato il nostro cammino solo per pochi anni, dopo secoli? Cosa si intende per “casa”? Io vivo letteralmente in una terra di nessuno, in molti sensi: una minuscola guest house di meno di dieci metri quadrati. Che strano! Solo fino ad un mese fa, avrei potuto sistemarmi in uno spazio di più di cinquanta metri quadri che avrei potuto cominciare a chiamare casa in un prossimo futuro. E adesso, invece, questo spazio che a stento arriva a dieci metri quadri mi sembra un segno di buona sorte. Un rifugio da non sottovalutare, specialmente se considero i molti che sui loro piedi, per strada, camminano verso le loro case, altrove.
Le case sono sempre “altrove”, per qualche ragione: un posto in cui andare, perché il posto da cui si lavora non si chiama mai “casa”. I lavoratori rimangono “migranti” anche se vivono per anni in una città, in piccole case popolari. Sembra che non raggiungano mai lo status o la dignità di “residente”. La residenza è temporanea e improvvisata, come per la maggior parte dei luoghi di soggiorno: molte volte, in baracche o bidonville, con tetti di amianto o ancor più provvisori, fatti con qualsiasi materiale di scarto che chi le abita riesce a trovare nelle città che sta costruendo o per le quali sta lavorando.
Se c’è qualcosa che è accaduto, è che improvvisamente il “lavoratore migrante” esiste nella narrazione dei media, presentato di nuovo come una vittima e non come il lavoratore con dignità di residenza in una città che idealmente lui o lei avrebbe dovuto percepire come “casa”. Lui o lei sono improvvisamente diventati i potenziali vettori di un virus, per una pura questione di percezione e non in base ad un’evidenza basata su parametri scientifici. Così ci si chiede se è la paura del lavoratore migrante portatore del virus che mette questa categoria di persone al centro del discorso, o la pietà e una sorta di condiscendenza verso i poveri. Dovrebbe essere solo uno specchio da mettere davanti alla popolazione del Paese, che ci potrebbe vedere un grande tema: mentre “stare a casa, stare al sicuro” può sembrare una cosa meravigliosa da fare per una certa parte della società, il luogo in cui i lavoratori si guadagnano da vivere diventa realmente “casa”. Ed è veramente una casa sicura?
E una domanda ancora più importante: cos’è “casa”?
La programmazione televisiva (radio e televisione) è piena di stereotipi sulla famiglia indiana. E sul “tempo della famiglia”, di cui si fa persino un uso eccessivo. La “famiglia” è sempre mostrata, in qualche modo, come la migliore e ideale unità sociale, e universalmente buona per tutto, nonostante i problemi di abuso e discriminazione al suo interno. La donna di casa, durante il lockdown, diventa contemporaneamente la madre, la cuoca, la badante, il sorriso che dà sollievo, colei che porta tutti i pesi del mondo, in modo che i suoi figli, suo marito e forse i suoceri o i genitori possano vivere felicemente, dimentichi di tutte le preoccupazioni del mondo.
I programmi radiofonici per donne (di solito pomeridiani, in ossequio all’assunto che sia questo il tempo che le donne possono dedicare a se stesse), danno ricette e idee che possano servire alle donne per compiacere le proprie famiglie e impegnare i propri figli. Un attore del cinema Hindi tradizionale degli anni passati suggerisce con un gran sorriso quanto divertimento produca lo stare a casa ad ascoltare le storie degli anziani, aiutare i figli a fare i compiti, guardarli giocare, etc. Lo stare a casa è presentato come la più felice cosa da fare. E mi chiedo come si collochi, rispetto a queste immagini, chi è lontano da casa. Specialmente chi non ha uno stipendio sul suo conto a fine mese, e non è così fortunato da “lavorare da casa” per un’azienda o per il governo, e da ricevere alla fine del mese uno stipendio – non importa quanto – sul suo conto in banca. E poi quel che è peggio è sentire che gli stipendiati, i professori universitari, i burocrati, gli insegnanti si lamentano perché lavorano da casa. Persone alle quali lo stipendio e tutte le provviste (grazie alla consegna a domicilio in alcune città) arrivano direttamente a casa e sui loro conti in banca, senza che ci sia alcuna necessità di uscire.
Spazi Covid-free e alcune altre domande.
Che cosa dire degli spazi che non hanno registrato neanche un caso di Coronavirus in India? Ho sentito dello Srikakulam, nella parte nord dell’Andhra Pradesh; o di quella parte dello Srikakulam che conta un numero relativamente più ampio di piccoli agricoltori, o delle regioni abitate per lo più da adivasi o comunità indigene. C’è anche l’esempio di Spiti, nell’Himachal Pradesh, e forse di molti altri villaggi che sono fortunatamente sfuggiti al contagio. Dovremmo anche chiederci perché. Può non essere una coincidenza che queste aree siano relativamente più verdi di altre e contino meno attività commercialmente distruttive e altamente competitive dal punto di vista economico (a parte il turismo, naturalmente).
È anche una pura coincidenza che a Spiti, in questo momento, la natura sia stata d’aiuto. Le strade sono state bloccate dalla neve fino ai primi di Marzo. Così gli abitanti, per alcuni mesi ogni anno, godono di un relativo isolamento, che lascia la gente della regione alle sue attività invernali. Concentrati sulla vita urbana, spesso non ci accorgiamo dell’aspetto più splendente di questi spazi eminentemente rurali, che possono esistere ovunque nel mondo. E l’attenzione che dedichiamo ai disastri nelle città e nei paesi del mondo, che sono stati così distruttivi e travolgenti, produce certe decisioni politiche che condizionano tutti, prese solo per mitigare i danni e calmare l’opinione pubblica.
Provvedimenti che, in futuro, possono creare situazioni avverse dove oggi non ce ne sono. Perché ai non-disastri non viene data uguale visibilità sui giornali? E perché, nel mondo, le non disastrate-zone dovrebbero subire gli stessi interventi di mitigazione delle zone disastrate? Il fatto che questa sia stata dichiarata una pandemia significa anche che essa elude ogni tipo di interrogazione o ricorso legale cui di solito il popolo può accedere nei confronti dei provvedimenti presi dal decisore politico senza consultare tutti i settori. Solo recentemente in India è stato dato respiro ad alcune attività agricole e a pochi altri settori, cui è stato permesso di riaprire anche durante il lockdown.
Migranti e esodo.
L’esodo di massa di lavoratori migranti dalle grandi metropoli indiane – che era essenzialmente connesso (non tutti sembrano comprenderlo) al ciclo agricolo nelle aree rurali, nelle quali molti di coloro che vivono in città sono impegnati – ha dimostrato la mancanza di una vera consultazione della politica con gli altri settori del Paese prima dell’adozione del lockdown. Molti lavoratori nel campo dell’edilizia provengono dalle aree rurali, che rimangono il loro campo-base, dato che essi incrementano il loro reddito con i lavori agricoli e talora anche tramite la conduzione di piccole fattorie. Molti hanno delle “carte di razionamento” (che garantiscono loro una minima fornitura di grano sovvenzionato) nei loro villaggi, delle quali si servono anche quando lavorano nelle città. Questa gente rimane legata al proprio villaggio anche se vive nelle città e là educa i propri figli nelle scuole private e pubbliche. Sono tutte verità risapute da tempo.
I loro spazi vitali nelle città sono tra i meno invidiabili. Molti costruiscono case per altre persone, ma non possono permettersi di viverci. In una situazione altalenante, in qualche caso, a Hyderabad, alcuni lavoratori dell’edilizia, che costruiscono appartamenti di media grandezza, o anche più piccoli, diventano i portieri del palazzo e quindi ottengono una stanzetta gratis nello stesso complesso. Queste persone diventano lentamente residenti permanenti della città e i loro figli vengono messi in scuole private. Molti di loro si guadagnano da vivere attraverso varie attività in grado di produrre reddito, grazie all’alloggio gratuito ricevuto. In molte città, la gente lavora negli alberghi, o anche in negozietti, come commesso. Ma se durante le crisi, se non hanno un tetto e un riparo, come sta diventando evidente adesso, queste persone preferiscono ritornare ai loro villaggi – anche se all’inizio i loro villaggi (e le crisi agricole) li avevano costretti ad emigrare nelle città.
Tempo per fermarsi, guardarsi dentro, disfare, rifare.
Indulgenza per i viaggi aerei? Perché la gente si concede viaggi aerei anche non essenziali? Qual è l’impatto ecologico del traffico aereo globale? Che effetto hanno avuto l’aviazione commerciale e i viaggi aerei non essenziali sull’ambiente? E oggi che il traffico aereo è quasi dimezzato, è stato calcolato il vantaggio ecologico? E cosa dire dei viaggi in treno, in uno Stato come l’India? Qual è il vantaggio ecologico dell’attuale lockdown? Ogni momento storico dovrebbe essere valutato soltanto in base all’impatto presumibilmente negativo sull’economia? Non dovrebbe ogni epoca storica essere valutata anche in base al relativo vantaggio ecologico? Il virus sta solo uccidendo, necessariamente, o è il modo in cui il virus è gestito dallo Stato che lo fa? Chi dovrà rispondere di queste morti? Non dovremmo forse guardare più in profondità nella natura dello Stato (e, di conseguenza, anche allo stato di natura), nell’assistenza sanitaria, nell’accesso delle persone svantaggiate alla sicurezza sociale, politica ed economica?
Controllo totale dello Stato?
Sulla scia del lockdown sorgono alcune domande che molti di noi nel mondo stanno fronteggiando oggi. Mentre il Covid 19 si è preso il centro della scena del dibattito in ogni Stato – nascondendo sotto il tappeto ogni altra questione pertinente – e mentre noi siamo costretti a piegarci a nuovi tipi di app e a nuovi metodi di sorveglianza, nascono alcune domande: che succederà ai diritti civili e alle libertà, durante i tempi dell’emergenza medica come questo? Emergerà in tutto il mondo un meccanismo che attraversi le nazioni e gli organismi internazionali di modo che una pandemia non significhi nel complesso anche la fine delle libertà e, cosa ancora più importante, non renda certe popolazioni o comunità più vulnerabili alla discriminazione e agli attacchi?
E inoltre, le applicazioni tecnologiche saranno tutte ugualmente e rigorosamente testate (proprio come si fa con vaccini e medicinali), prima di costringere o forzare la gente a usarle in nome della protezione e della prevenzione? C’è un urgente bisogno di un meccanismo globale di controllo della realtà fondato sull’interesse dei cittadini, di modo che una pandemia non finisca per favorire la nascita di severi regimi autocratici, che mettano le persone l’una contro l’altra attraverso la creazione di paura e sospetto. Ci saranno meccanismi (se necessario legalmente vincolanti per lo Stato) per proteggere la dignità e il rispetto dei più vulnerabili, specialmente durante periodi di emergenza come questo, piuttosto che vederli fuggire nella paura, incapaci di credere che i loro interessi saranno presi in carico, e rischiando le loro proprie vite in questo processo?
Ricordando Joy, e pochi altri.
Alla fine dell’anno scorso l’ho incontrata, in un angolo tranquillo. Stava in piedi, non lontano da un piccolo ristorante, con il suo carretto traballante. Aveva tre pentolini, una larga padella, e un vassoio un po’ più largo della padella. In quanto donna single, non particolarmente interessata alla cucina, ho molte volte benedetto questi venditori coi carretti, dove compravo il mio pasto serale da single. Quando infatti il mio cane Malli è stato male per un mese intero, e dopo che lei è morta, questi carretti e altri curry point sono stati la mia salvezza.
Hyderabad ha molti di questi punti di street food, con una sola persona (maschio o femmina) o una coppia che vendono i loro curry (di solito stufati speziati a base di pollo o vegetali) e chapatis (pani spianati di farina di grano, arrostiti su una padella asciutta). Molti lavoratori (specialmente operai celibi) li comprano. Sono a buon mercato e di solito freschi, e possono essere impacchettati in piccole quantità, e portati via, a casa.
Joy, la donna del carretto, inizia verso le sei del pomeriggio, stando in piedi tutto il tempo, e spianando le sue chapatis fino alle dieci. Aveva piccole porzioni di curry e la sua clientela era piccolissima. Doveva aver previsto di poter smettere da lì a pochi mesi. Era un piccolo investimento, per un piccolo ma sicuro guadagno mensile; meglio che candidarsi per lavori che non eri sicuro di poter ottenere.
Numerose località a Hyderabad hanno questi punti di ristoro ai lati della strada, di solito messi in piedi da giovani uomini e donne che dubitano di potersi assicurare un lavoro d’ufficio. Un punto curry assicura sempre una certa clientela di habitué e una rendita dignitosa in fin dei conti. E poi c’erano le donne del Telangana rurale, che sedute sui percorsi delle località abitate dalla middle class, preparavano i jonna rotti (pane fatto di farina di sorgo, una specialità della regione del Telangana), specialmente durante i mesi invernali. Ogni rotti costa dieci rupie, e le donne stanno sedute lì ogni sera, per una clientela affezionata, semplicemente con una padella di ferro, riscaldata da piccoli fasci di rami di tenera acacia (abbattuti regolarmente dal dipartimento dell’elettricità del Telangana in base al loro programma di taglio degli alberi).
Sto pensando anche al bajji taatha, il vecchio uomo che preparava deliziose patatine fritte con le verdure, che si vendono come tortine calde ogni sera in un’altra località a Secunderabad. Il vecchio era accompagnato da suo figlio. Durante l’esperimento della demonetizzazione in India, nel 2016, mi sono resa conto che quel vecchio era uno dei tanti che era totalmente dipendente dall’economia in denaro contante, mentre il governo insisteva nel suo piano di digitalizzazione. Fortunatamente, alcuni di questi lavori basati sull’economia in contante sono sopravvissuti alla digitalizzazione, anche perché il governo ha capito che era il caso che questo accadesse. Ma oggi il Coronavirus ha offerto un altro pretesto per magnificare i vantaggi dei pagamenti digitali.
Ed io oggi sto pensando a Karthik, che vendeva fiori di stagione e ghirlande di fiori, accanto al grande tempio di Secunderabad. Karthik aveva appena dodici anni quando stabilì il suo carretto accanto al tempio, insieme con sua madre. È cresciuto in fretta, considerando che ben presto si è preso sulle spalle il peso di tutta la famiglia, compresa la madre e le due sorelle. Stava lì, alto e dignitoso, per ore, ogni mattina (dalle sei e mezza alle undici o alle dodici) e la sera dalle cinque e mezza/sei alle nove. Tutti i giorni della settimana, tutti i mesi dell’anno. E pian piano riuscì a far sposare la sorella maggiore. Forse aveva preso in prestito un po’ di denaro, che forse ha già restituito, o forse no. Karthik, e molti come lui, non era riuscito a completare la scuola. Mentre molti erano venuti in città con i genitori, facendola finita con l’insostenibile prospettiva dell’agricoltura (i piccoli fattori erano pochi, mentre la maggior parte erano contadini senza terra), alcuni di loro erano nati a Hyderabad e si sentivano essenzialmente figli della città.
Phoolmani, suo marito e i due figli – Jyuti and Dipika – avevano una minuscola baracca da tè accanto alla casa dove io e Malli vivevamo, a Guwahati, alcuni anni fa ormai. Phoolmani era una donna che lavorava sodo, e sapeva gestire la baracca del tè praticamente da sola, anche se suo fratello maggiore Kakaideo (come alcuni lo chiamavano, inclusa me) faceva delle commissioni per mantenere la scorta di soprammobili, miscele salate, biscotti da tè, pacchetti da beedi e sigarette, sempre pronte. Non guadagnavano molto seduti lì, in quella minuscola baracca di fortuna (difficile intuirne la struttura), fuori dalle mura del complesso di appartamenti a Kharguli, sulla strada che si affaccia sul possente fiume Brahmaputra (nei mesi invernali avvolto in una nebbia surreale). Ma erano sempre là, sorridenti. Malli era la loro più gradita cliente, e ogni giorno doveva sedersi lì come un ninnolo, mentre Phoolmani invitava persone per il tè e la mostrava ai clienti, dandole in pasto qualche snack. Molte volte Malli restava lì finché le veniva data la sua parte di quella mistura, che mangiava soltanto dalle mani di Phoolmani. Piuttosto che stare a casa, Malli preferiva ascoltare i pettegolezzi e guardare i clienti all’angolo del tè. I clienti erano per lo più operai dell’edilizia e tiratori di risciò del quartiere. Phoolmani e la sua famiglia vivevano in un minuscolo monolocale: una casa popolare, buia, accanto al nostro complesso di appartamenti. Malli ed io le facevamo spesso visita, talora condividendo un pasto (riso e pesce) con la famiglia. Il fiume Brahmaputra e l’angolo del tè di Phoolmani erano parte di un quadro più grande: quella non-struttura si stagliava con quieta dignità – anima generosa e compassionevole – contro le lussuose case e i complessi di appartamenti che stavano su quel terreno collinare. Penso a lei, e allo spazio oggi privo del suo angolo del tè, e mi chiedo come il destino di quella famiglia debba essere cambiato senza il loro solo mezzo di sussistenza.
Poi c’è Madhavi, che era nato a Hyderabad. Prima accompagnava sua madre, che vendeva fiori messi in un cesto di canna appollaiato su uno sgabello di plastica all’angolo della strada, in una località di Secunderabad. Madhavi non ha un conto in banca. E neanche ha ricavato mai abbastanza dal suo business. Anche pagare l’affitto mensile non le era facile, e alcuni dei suoi clienti abituali la aiutavano di tanto in tanto. L’abbondante e inebriante fragranza dei malle poollu (gelsomino bianco) creava un netto contrasto con le loro vite.
Ognuna di queste persone che si sono fatte da sé sono Dalits. La loro resilienza è di ispirazione per tutti, ma allo stesso tempo è doloroso renderla esotica. La città sembrava dar loro una qualche speranza e opportunità di guadagnarsi la vita. Penso a tutte queste persone durante il lockdown. Penso anche ai carretti qui a Shimla, in alcuni importanti luoghi turistici. Per esempio, vicino all’Indian Institute of Advanced Study. Qualcuno preparava zuppa e noodles e i momos, verdure cotte al vapore, che erano le più vendute ogni sera.
Sono persone che hanno affrontato la città e i loro propri destini con coraggio, e hanno messo su qualcosa di proprio, ricavandone un guadagno piccolo, ma dignitoso e rispettabile. Oggi durante il lockdown mi chiedo come se la passino. Come sarà la vita per loro una volta che “riapriremo”? Loro non fanno parte delle immagini dominanti delle famiglie felici, “che mantengono la distanza sociale” (loro non possono, probabilmente, nel monolocale in cui vivono) nelle loro case. Loro non possono essere felici di “lavorare da casa” – semplicemente non possono – e di ricevere un salario – semplicemente non ne hanno.
La cosa peggiore è che la maggioranza di queste persone non hanno conti in banca. I loro commerci insignificanti erano totalmente dipendenti dal contante e di certo non quel tipo di contante che in banca chiamano “risparmi”. È di solito un’esistenza basata sul passaparola. Una qualunque emergenza medica, come quella che noi oggi chiamiamo Covid 19, colpisce questa gente come disagio economico, prima ancora che come infermità fisiologica.
Non sappiamo cosa accadrà quando la vita tornerà “normale”. Sospinti così indietro fin dal tempo in cui il lockdown è cominciato, saranno in grado queste persone di tornare a rialzarsi e ricominciare da dove erano rimasti? I settori organizzati, anche nell’agricoltura, possono ancora avere incentivi governativi per essere sostenuti durante le crisi, ma cosa accadrà di queste persone, che sono letteralmente ai margini dell’economia, e di cui nessuno si occupa?
Una pentola a pressione, un piano a induzione e una padella (e un bollitore da tè)
Vorrei aggiungere a questo elenco quattro tazzine col piattino, quattro bicchieri, due cucchiai da tè, nella stanza di una piccola guest house. Quando un tempo io avevo uno spazio di cucina adeguato (e adeguati utensili, per lo più di mia madre e di mia sorella), in una casa che teoricamente possedevo, dove entravano i primi raggi del Sole – uno spazio suggestivo – non cucinavo mai abbastanza. O comunque non ne godevo tanto quanto Malli, se e quando cucinavo un buon pasto (repertorio limitato) per me stessa o per un’amica occasionale, o un parente.
Oggi provo a cucinare in una cucina decorosa e a desiderare qualcos’altro rispetto al riso e lenticchie di ogni giorno. Ma penso anche ad alcuni dei lavoratori migranti qui a Shimla, che non hanno una cucina e sono sfamati nei langars (cucine comuni) da organizzazioni di volontariato, e da privati in alcune aree. Io non dovrei desiderare nulla. E seguo per caso alla radio un programma “per donne” che parla di ricette “per madri”, ansiose di tenere allegri figli, mariti e parenti durante il lockdown. E penso ora che una cucina non significherà la stessa cosa per me quando le cose ritorneranno alla normalità. O almeno alla recente normalità che conoscevo. Per adesso so di quanto poco ognuno di noi abbia bisogno in realtà, e come sia invece possibile accontentarsi di cucinare un umile pasto e, ancor di più, semplicemente di cucinare. La tentazione di non mangiare è grande quando qualcuno è lasciato solo al mondo inaspettatamente, a causa di una morte o di una separazione, o, forse, di un lockdown simile. Ma alla fine, un bel giorno, la fame prende il sopravvento, e tu devi mangiare.
E bisogna ringraziare i produttori di cibo, i numerosi commercianti, gli autisti dei camion, i trasportatori di beni, i negozianti dei piccoli negozi di quartiere per gli acquisti di base, che galleggiano sopra il presente. Che sopravvivono e ci fanno sopravvivere. La sopravvivenza sembra la comune metafora, anche in momenti in cui la gente cammina per migliaia di chilometri, dai loro luoghi di lavoro in città alle loro case nei villaggi. E tu cominci a sentirti orgogliosa, ma anche colpevole della tua buona sorte e della pentola a pressione, del piano a induzione e della padella, e del bollitore.
Per non parlare della generosità di poche persone, nel vicinato “esteso”, che ti regalano patate, cipolle e lenticchie, e talora sottaceti per speziare un po’ il cibo, come fa Sunita, la mamma della piccola Bhumika, chiedendomi di non dire a nessuno che lo ha fatto, così che a volte sono costretta a portare il cibo fuori di nascosto.
(traduzione di Rosario G. Scalia)
I commenti a questo post sono chiusi


Thank you for sharing this fantastic diary – great work Uma! And, having read both the original and the Italian version, I also wanted to commend Rosario Scalia’s impressive translation.