La Heimat è una cosa da matti? Intervista a Maddalena Fingerle
di Giovanni Accardo
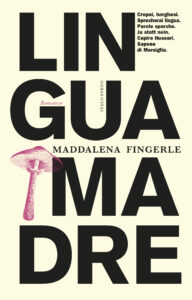
“Lingua madre” è il romanzo d’esordio di Maddalena Fingerle, bolzanina trapiantata a Monaco di Baviera, dove ha studiato germanistica e sta svolgendo un dottorato di ricerca in italianistica, pubblicato da Italo Svevo e con cui ha vinto l’ultima edizione del Premio Calvino, il più importante premio letterario italiano per esordienti. La vicenda è quasi interamente ambientata a Bolzano, con una parte a Berlino, e in qualche modo è una dissacrante riflessione su talune ossessioni che caratterizzano l’Alto Adige/Südtirol, soprattutto ossessioni linguistiche e identitarie. Un romanzo fortemente comico, specie nella prima metà, di grande maturità stilistica e di notevole freschezza.
Nell’intervista che segue proviamo a farci raccontare qualcosa in più dall’autrice, che i lettori di Nazione Indiana conoscono bene, visto che proprio qui ha pubblicato alcuni suoi racconti.
Paolo Prescher, anagramma di parole sporche, non sopporta le parole sporche, appunto, cioè quelle segnate dalla falsità, dall’ipocrisia. Ci fai qualche esempio?
Giuliana, la madre, utilizza espressioni politicamente corrette ma in maniera totalmente ipocrita, dice per esempio “sudtirolese di madrelingua tedesca” e “persona di colore”. Paolo odia la falsità con la quale lo dice e preferirebbe un atteggiamento sincero che per lui si rispecchia in espressioni come “tedesco” o “negro”.
Pur vivendo a Bolzano, anzi, forse proprio per questo, non crede nel bilinguismo. Perché?
Cresce in una famiglia italiana senza parlare il tedesco. Non crede nel bilinguismo altoatesino perché è qualcosa che sente nominare a livello politico ma di cui non trova riscontro nel quotidiano, tanto che il tedesco lo impara da solo con i libri e lo migliora poi a Berlino.
Il protagonista si accorge che non basta conoscere il tedesco per sentirsi davvero figlio della sua terra, l’Alto Adige/Südtirol, anche perché, ragiona, la vera lingua è il dialetto sudtirolese, inaccessibile agli italiani, che proprio di un dialetto sono orfani.
Per Paolo, ossessionato dalle parole, la mancanza di un dialetto è qualcosa di molto sofferto e che invidia, per esempio, all’amico napoletano che conosce a Berlino, ma in realtà anche a Jan, amico d’infanzia, che parla dialetto sudtirolese. Vorrebbe anche lui una lingua della famiglia, una parlata marcata, forte, decisa. Nei confronti del dialetto prova (in)sofferenza, legata all’essere cresciuto in un luogo di cui conosce una sola lingua. Personalmente non credo che il dialetto sia inaccessibile, penso però sia difficile da imparare in età adulta senza che faccia effetto scimmiottamento.
E ritiene la Heimat una cosa da matti.
La Heimat è una cosa da matti. Lo pensa da ragazzino, poi però rivaluta il concetto di Heimat una volta arrivato a Berlino, quando, solo, si accorge che una specie di Heimat, legata alla figura del padre, ce l’ha avuta e l’ha persa insieme a lui: “L’unica cosa brutta di Berlino è che mi sento un po’ solo perché non ho amici e non parlo praticamente con nessuno. Anche a Bolzano non avevo amici e non parlavo praticamente con nessuno, ma finché c’era papà io non mi sentivo così. Forse era quella la mia Heimat, non sentirmi solo.”
Per Maddalena Fingerle il rapporto con la sua terra d’origine può essere solo conflittuale? Dipende dall’essere italiani? Credi che per un tedesco, anzi un sudtirolese di madrelingua tedesca (sic!), sia diverso?
Sul piano della realtà non lo credo, no, penso però che ci sia ancora una forte divisione tra i mondi di madrelingua italiana e tedesca. E che ci siano molti pregiudizi. E diffidenza. A volte mi stupisco pensando che si possa vivere anni in un luogo senza conoscere una delle due lingue che lì vengono parlate. Mi sembra assurdo, possibile che non ci sia un minimo di curiosità, almeno? In linea generale è vero che le persone di madrelingua tedesca tendenzialmente sanno l’italiano, mentre le persone di madrelingua italiana raramente sanno il tedesco e, ancora più raramente, il dialetto; ma ci sono eccezioni, ovviamente. Il mondo sudtirolese di lingua tedesca l’ho conosciuto solo l’anno scorso, dopo il Calvino, quando sono stata accolta alla biblioteca Teßmann. Avevo paura di non capire e invece ho avuto una sensazione simile a quella che ho provato in Puglia al Festival Armonia: mi sono sentita a casa, che è molto raro, per me.
È solo trasferendosi a Berlino che Paolo finalmente scopre le parole pulite e trova un luogo dove si sente a casa. Pensi che per amare la propria terra sia necessario andar via, cioè prenderne le distanze?
Paolo si sente a casa soprattutto quando conosce Mira, di cui si innamora. Lei gli pulisce le parole ed è grazie a lei che Paolo riesce ad amare Bolzano, riscoprendola: ciò che prima gli faceva orrore, insieme a Mira diventa improvvisamente meraviglioso perché lo è per lei e lui lo guarda attraverso il suo sguardo. Paolo da piccolo odia così tanto la città che ha bisogno di allontanarsi per poterla poi amare. In generale, nella realtà, non lo so. Io, che vivo a Monaco e sto costruendo casa in Allgäu, sicuramente inizio a sentirne nostalgia. Ma è più per le persone e per la radio italiana in sottofondo, che per il luogo; forse dipende anche dal fatto che non ci si può spostare a causa della pandemia.
Vero protagonista del tuo romanzo è la lingua, anzi, le parole. Le cose non esistono, ci vuole dire Paolo Prescher, finché non le nominiamo, solo dopo acquistano la loro identità, evocano emozioni, hanno odori?
Assolutamente sì! La parola per Paolo è la cosa, ha un rapporto sinestetico e ossessivo con la lingua e con le letture e la ripetizione. Ci sono parole sporche e pulite, ma anche parole in grado di sfamarlo, parole (e voci) che lo spaventano e parole che lo tranquillizzano.
A partire dalla terza parte assistiamo a una progressiva normalizzazione dello stile e anche del protagonista, come mai?
Il linguaggio segue le fasi della vita di Paolo in una sorta di climax in tre atti. Nella prima parte, a Bolzano, la voce è quella di un ragazzino, è la sua naturale di quando è a casa ed è insofferente e addolorato; nella seconda parte, ambientata a Berlino, il linguaggio, attraverso l’innamoramento, diventa positivo e si calma, Paolo stesso è come anestetizzato, ciò che prima lo infastidiva ora lo riscopre grazie a Mira. Nella terza e ultima parte, in cui Paolo perde il contatto con il reale, le parole si svuotano invece di senso, il mondo si ovatta e si allontana, lasciando così spazio al delirio finale.
Le prime due parti, molto pirotecniche linguisticamente, sono fortemente dissacranti e derisorie, è la lingua più che la storia a decidere il registro di un romanzo?
Non credo che ci sia una divisione dicotomica tra lingua e storia che vanno invece di pari passo. L’esperimento linguistico è nella terza parte, dove italiano e tedesco si mescolano, le parti dissacranti sono legate al fastidio che prova Paolo nei confronti dell’ipocrisia bolzanina, nella parte e nell’ultima parte. È vero però che una storia priva di una voce adatta tendenzialmente non mi affascina e, quando leggo, cerco un registro che sia deciso, come Paolo con i dialetti.
Paolo ha un giudizio molto duro sui suoi insegnanti di Bolzano, dice che s’interessano solo di radici e territorio, di beghe sui monumenti e sui nomi delle vie, mentre sono disinteressati agli scrittori che arrivano da fuori. Condividi?
Non ha importanza se condivido o meno perché sono due piani differenti, questo è il filtro di Paolo, all’interno della finzione letteraria e non la realtà. Lui si innervosisce per il provincialismo e la megalomania dei suoi insegnanti che, se non organizzano loro gli incontri con gli scrittori, se ne disinteressano.
Come pensi che sarà accolto il tuo libro dai lettori di Bolzano e dell’Alto Adige? Come vorresti che fosse letto?
Vorrei che venisse letto come una storia di finizione che racconta di un giovane uomo ossessionato dalle parole e non solo come una storia su Bolzano. Certamente Paolo non avrebbe le ossessioni che ha se fosse cresciuto, per esempio, a Roma: ne avrebbe avute altre e la storia sarebbe stata diversa. Ma sono proprio le ossessioni che mi interessano. È il filtro di Paolo, il suo modo di vedere e sentire le parole è ciò che ho voluto raccontare, partendo dall’idea che fosse l’esasperazione di idiosincrasie che possiamo avere tutti, evitando di etichettare le sue stranezze come malattia mentale.
Possiamo rivelare un segreto ai lettori? Il tuo incontro con il premio Calvino risale al 2009, quando eri ancora una studentessa di liceo, ed è merito di Giorgio Vasta, la cui lingua, tra l’altro, è da te estremamente apprezzata.
Certo, e solo a pensarci mi emoziono perché quel ciclo di incontri, organizzato da te (sveliamone un altro di segreto!) me lo ricordo ancora. Mi ricordo soprattutto Giorgio Vasta che parlava del Calvino e delle schede di lettura e pensai per la prima volta: parla pulito. Per me quell’espressione designava una precisione di linguaggio, un rispetto e una correttezza che non avevo mai percepito così. Ritrovai tutto ciò nel romanzo Il tempo materiale.
Un’ultima domanda sugli scrittori italiani che ti hanno formata e in un certo senso dato una lingua.
A nove anni mi coprivo di ridicolo vantandomi di aver letto Il Gattopardo, recitavo le battute di Angelica a memoria, probabilmente senza nemmeno capirle. Allo stesso modo leggevo la poesia italiana del Novecento, mi trascinavo quei volumi Einaudi ovunque e giocavo a cercare le ricorrenze. Quando leggevo Bernhard non avevo bisogno di mangiare perché mi sfamava e mi faceva ridere e mi faceva piangere. Ho pensato mi scoppiasse il cuore quando ho letto Bassotuba non c’è perché Nori è così bravo – mi dicevo, terrorizzata dalla velocità del battito – ma così bravo che sembra morto. L’Adone è il mio nuovo tormentone (da quattro anni, ormai), il modo in cui Marino riesce a giocare con i riferimenti intertestuali mi diverte e mi affascina così tanto che mi viene voglia di urlare. Bisognerebbe leggerlo a scuola! E non le parti noiose…


Ecco finalmente “il” libro sul bilinguismo bolzanino, e – anche se non esplicitamente – su quanto contiene. Perché è vero, come dice Maddalena, che il suo è un romanzo sulle ossessioni (linguistiche), ma se il suo romanzo viene da Bolzano (dopo che lei se ne è andata) una ragione c’è: c’è una storica tragedia identitaria prodotta dal fascismo e dal nazismo (cioè di molto prima della globalizzazione, di quando le identità tenevano in piedi le persone), che gli italiani hanno a lungo rimosso anche in epoca democratica, e che gli è tornata in dietro solo col terrorismo degli anni ’60. Il fatto che ora comincino ad uscire riflessioni vere sull’ identità linguistica ed il bilinguismo anche da autori “italiani” (bolzanini italiani) è un ottimo segnale. La cosa non ha nulla di “locale”, sono i problemi del mondo contemporaneo: le “identità” sono elemento di rottura nel mondo globalizzato. Roberto Antolini