Come ci inquadriamo quando videochiamiamo / 2: sullo stendino
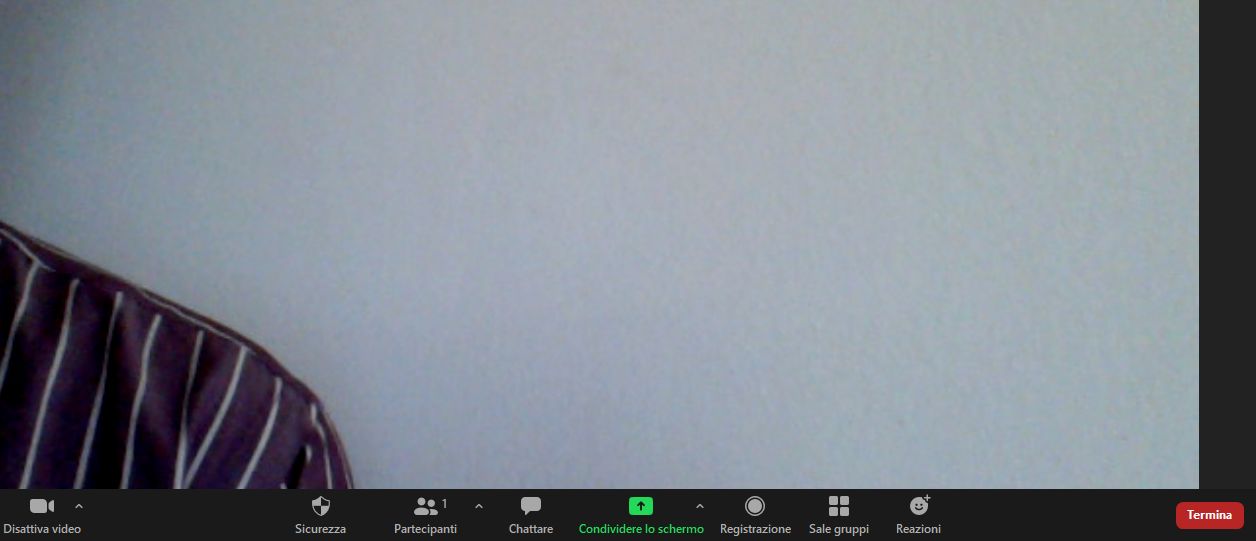
di Alberto Brodesco
Ipotesi: si è prodotta una biforcazione tra una comunicazione impersonale (verso tutti) curata, e una comunicazione personale (verso qualcuno di preciso) sciatta. La prima è lo stile Instagram, la seconda lo stile Zoom.
Ho presenziato a un meeting di gruppo su Zoom dove una partecipante aveva alle spalle lo stendibiancheria. Al di là di un fastidio estetico, idiosincrasico, per quell’oggetto, lo stendino ha svolto una funzione rivelatrice. Di solito lo stendipanni è un articolo che si nasconde, che si ripone quando entrano ospiti, da collocare sul poggiolo o nella cosiddetta “zona notte”. Vederlo così in vista nel corso di una riunione di lavoro fa capire una cosa che va oltre la scelta o la distrazione della singola partecipante alla video-call: non ci interessa davvero come siamo inquadrati su Zoom.
Ho dedicato un primo pezzo su Nazione Indiana a ragionare sugli errori (il quadro, gli sfondi, le luci) che commettiamo su Zoom o sugli altri software. Ora giungo alla conclusione che non si tratta di errori ma di disinteresse.
Chi partecipa alle video-riunioni non presta veramente attenzione a come appare. È una constatazione puramente numerica: la stragrande maggioranza di chi usa Zoom fa così. Osservando la video-riunione dello stendibiancheria, su 21 partecipanti visibili, conto: 1 controluce, 5 inquadrature del soffitto, 2 facce tagliate dal naso in giù, 1 sfondo virtuale (ponte famoso), 3 sfondi imbarazzanti (foto di parenti morti, foto del matrimonio incorniciate a cuore, stendino), 2 sfondi oggettivamente brutti (termosifone, vecchia cucina). Inquadrature, sfondi e luci curati si vedono in 2 soli rettangoli su 21. Conclusione (ribadita): di come siamo inquadrati quando siamo in video-chiamata ci importa abbastanza poco.
Povero Zoom. Siamo attenti, in modo ossessivo, a come appariamo sui social network (filtri, correzioni colore, scatti ripetuti…), ma quando ci riprendiamo in video-conferenza non ci curiamo della nostra immagine. È una negligenza in totale attrito con l’epoca in cui viviamo.
Proviamo a trovare delle ipotesi per spiegare questo disinteresse. Si può intanto dire che trattiamo la video-conferenza come se fosse una vecchia telefonata, che si può fare, con un po’ d’attenzione, anche seduti sul water. L’onda lunga del “vecchio telefono” spinge a privilegiare il verbale sul visivo.
Una seconda ragione può essere attribuita alla qualità generale delle riprese (o foto) che ci siamo abituati a fare, alla sciatteria con cui inquadriamo di solito. Non sto parlando delle foto che pubblichiamo su Instagram, ma di quelle che ci scambiamo su Whatsapp, quelle che servono solo come testimonianza, icona di un momento, indice di una presenza. Quelle fatte a cazzo. Allo stesso modo, ci siamo abituati a girare i video un po’ come vengono: muovendo molto lo smartphone, tenendolo in verticale, perdendo il fuoco, e con esso, in definitiva, anche il senso stesso dell’idea di inquadratura come selezione accurata dello spazio. Non ci importa veramente di filmare bene: conta la condivisibilità della scena, non la qualità della sua ripresa.
Terza ragione: vince la contingenza. Sul frame “occasione formale” (riunione) prevale il frame “ambiente domestico”. Il senso di comfort casalingo ha la meglio. Sono a casa mia e mi vesto da casa, faccio quel che voglio, mi mostro come mi pare.
Un’ulteriore motivazione potrebbe essere attribuita alla nausea da video-conferenza: da marzo in qua abbiamo partecipato a decine e decine di riunioni su Zoom, il che può aver prodotto un rifiuto di prestare attenzione al proprio aspetto/contesto: non ne posso più, ora basta, me ne frego. Gioca contro questa tesi il fatto che le inquadrature su Zoom vengano male sin dall’inizio del lockdown. Non sono quindi il frutto di una progressiva stanchezza nei confronti del dispositivo.
Nelle culture digitali, in conclusione, va riconosciuta l’esistenza di una pulsione low-fi. Zoom, avrebbe detto McLuhan, è un medium freddo. Rende manifesta la presenza di un’anti-estetica che sprigiona una peculiare forma di autenticità. Le inquadrature brutte di Zoom possono essere trattate come un segno interessante, come uno strano e forse anche involontario (o persino inconscio) rigurgito in reazione alla cultura della trasparenza e del narcisismo. Lo stendino vale come linda icona iperrealista, a contrasto con lo straripante esibizionismo fighetto dei mondi digitali che rimangono là fuori, in paziente attesa di un clic su “End Meeting”.
I commenti a questo post sono chiusi


Stendino. Riunione di Lavoro. Zoom. Fastidio. Anti-estetica. MA: peculiare forma di autenticità.
Nelle ultime sei righe un tentativo di salvare i poveri film-maker da inquadrature anti-estetiche con la possibilità che queste, alla fine, possano esprimere una peculiare forma di autenticità. Tu che avevi fatto una inquadratura sciatta e pessima su zoom e non te ne eri neanche accorta, stavi già colpevolizzandoti perché non sei in grado, non capisci il valore estetico di far vedere un bel quadro e non l’armadio incolore della tua stanza-studio-letto, no, sei salva perché anche lo stendino non lo dovrai più nascondere, è una icona linda e iperrealista. Ebbene, io amo zoom perché in questo dannato momento in cui non possiamo incontrarci, lo abbiamo utilizzato e lo utilizziamo per avvicinare le nostre case, le nostre debolezze e osare un po’ farci vedere come siamo. Senza trucchi. E non ce lo ha comandato nessuno. Ci è venuto spontaneo. Una domanda mi rimane insoluta: ma quello stendino era vuoto o con i panni stesi?