Dalla disfavola al fuoco
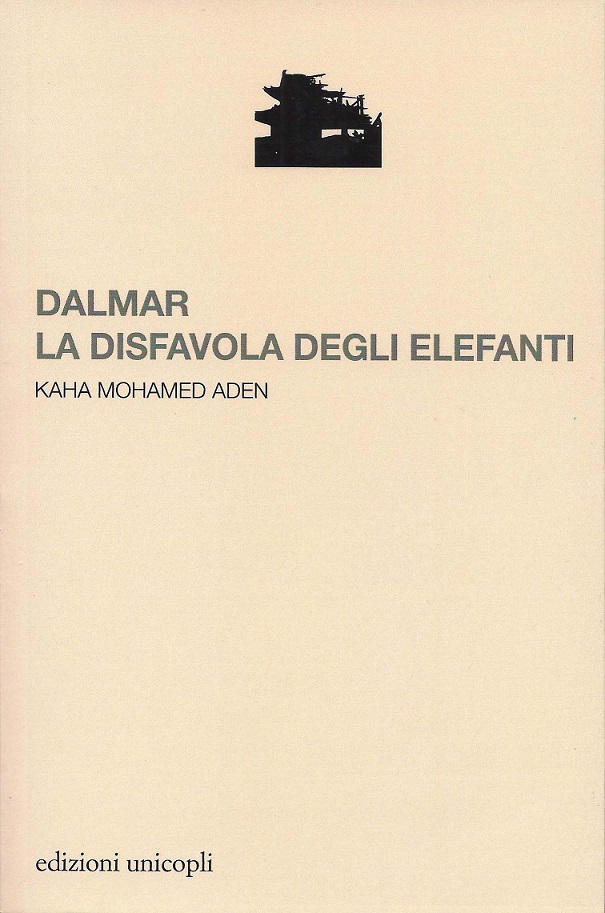 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi
Kaha Mohamed Aden, Dalmar. La disfavola degli elefanti, 2019, edizioni unicopli.
Marco Rovelli, La parte del fuoco, 2020, TerraRossa Edizioni.
Ci sono libri che càpitano in mano casualmente e casualmente si legano tra loro. Fanno “clic”, come dice Rovelli, e si incastrano l’uno nell’altro. Due autori diversi per cultura, due case editrici entrambe piccole ma diverse per impostazione editoriale, due storie che usano poetiche e linguaggi differenti, eppure due libri che collimano e si completano uno con l’altro quasi portassero impresso lo stesso marchio: la diversità. Sono convinto che se Kaha Mohamed Aden leggesse Marco Rovelli e viceversa, entrambi riconoscerebbero questo punto in comune.
Sono due libri che proiettano il lettore in un mondo di simboli. La Aden evoca gli orrori della guerra civile somala dei primi anni Novanta attraverso una favola dai toni duri, per adulti, con spiriti di animali morti in modo drammatico che chiedono giustizia, che non hanno pace finché la loro storia non viene alla luce. Lo fa partendo da una storia di migrazione: la fuga di un branco di elefanti dalla minaccia di una guerra e il loro approdo su un’isola abitata solo da orsi e api che si sono spartiti rigidamente il territorio. È una favola della memoria, una disfavola appunto, nell’accezione utopia-distopia favola-disfavola. Gli spiriti degli animali che popolano la foresta non hanno nulla di ecologista o di animalista, è tutta una metafora delle lotte per il potere, un po’ come nella orwelliana Fattoria degli animali. E anche gli spiriti “intrappolati in questo ginepraio di foresta” non sono concepiti come singoli fantasmi ma come l’insieme degli ultimi sentimenti espressi da tutti gli animali assassinati, una massa indistinta di pura rabbia rimasta in sospeso e che da tempo attende di essere liberata. L’allusione ai massacri somali tra i clan Hawiye e Darood è evidente. Altrettanto evidente è lo scopo del libro, che è poi lo stesso della foresta: “La foresta si limita a ospitare la rabbia che non aspetta altro di essere recepita nella storia dopo che si è riconosciuto, semmai c’è stato, il torto che l’ha creata”.
La Storia diventa allora disfavola, le metafore si accavallano in continuo, si fanno, come ho detto, parodie del mondo umano. Ci sono i giri d’affari della guerra, le armi leggere, le armi letali, i Fabbricatori dell’ordine mentale, il tutto narrato – per quanto la Aden scriva e parli perfettamente l’italiano – attraverso un linguaggio permeato di invenzioni semantiche, di frasi idiomatiche e modi di dire attinti dal linguaggio familiare e utilizzati senza che siano aderenti alle caratteristiche morfologiche dell’animale-personaggio (ad esempio l’ape regina che schiocca le dita). Ne nasce una prosa con forme e costrutti che sembrano non appartenerci e che l’editore ha deciso di lasciare così come sono – salvo alcuni interventi per esigenze di maggior chiarezza – proprio per mantenere “il profumo dell’Africa”.
 Con Rovelli siamo invece in un’altra dimensione: mentre la Aden abbandona la cultura del Paese di adozione per lasciarsi guidare dal suo istinto africano – sicuramente più vicino alla natura – e si immedesima nello spirito di elefanti e orsi umanizzati, Rovelli si spoglia dei suoi pregiudizi di occidentale per vestire i panni di un immigrato africano e di una ragazza psichiatrica. Altro parallelo: come l’elefantino Dalmar della Aden stringe amicizia con l’orsetta Dritta, così l’immigrato clandestino di Rovelli, Karim, stringe amicizia con la giovane e benestante Elsa.
Con Rovelli siamo invece in un’altra dimensione: mentre la Aden abbandona la cultura del Paese di adozione per lasciarsi guidare dal suo istinto africano – sicuramente più vicino alla natura – e si immedesima nello spirito di elefanti e orsi umanizzati, Rovelli si spoglia dei suoi pregiudizi di occidentale per vestire i panni di un immigrato africano e di una ragazza psichiatrica. Altro parallelo: come l’elefantino Dalmar della Aden stringe amicizia con l’orsetta Dritta, così l’immigrato clandestino di Rovelli, Karim, stringe amicizia con la giovane e benestante Elsa.
Ma anche Rovelli resta fedele al suo stile, mantiene il linguaggio del suo essere poeta e cantautore e alterna dialoghi di parlato che sembrano tratti da una sceneggiatura con passi di pura poesia: “Il tempo si mostra qui, nella sua assenza. E tu che guardi sei puro guardare”. Sino a includere brani musicali come testi di canzoni: “Scendete ancora, giù per il sentiero che dal castello arriva al mare, scendete quasi inerti, come minerali che scivolano perpendicolari al sole, che scivolano in basso per sfidarlo, a raccogliere la sfida dell’incandescenza, che i minerali trattengono presso di sé, racchiudendola senza sprigionarla, conservandola per l’eternità. Siete pietre nere, racchiuse nell’attesa, l’attesa dell’incandescenza, e l’incandescenza non attende niente. Poi vi sciogliete in fuoco, o forse metterete radici e vi distenderete in terra, o germinerete in vermi e butterete bellezza come un cadavere il grasso, ma non sarete acqua, questo no, non potrete mai essere acqua”.
C’è molta introspezione psicologica, un’analisi attenta sia delle fobie di Elsa, nate proprio dal suo ambiente familiare trincerato dietro la solidità economica (“Vivere in una fortezza fa crescere nella paura. E la paura produce una percezione del mondo diversa”), sia della saggezza di Karim, intriso di una visione filosofica che non è data solo dalle drammatiche esperienze di vita ma anche dalla sua cultura: Karim legge libri, cita Nagib Mahfuz e San Paolo, è un diverso tra i diversi, un immigrato speciale, di quelli che Elsa vorrebbe al posto di tanta gente che non è immigrata. Karim ha fiducia negli altri e ispira fiducia, è di una gentilezza che più nessuno conosce. Per questo Karim e Elsa sono così vicini, due facce della stessa medaglia. Entrambi vogliono le stesse cose, ossia giustizia, libertà, uguaglianza, un mondo migliore, fatto di persone vere. Elsa ne ha la netta percezione quando raggiunge Karim in Puglia, sceso per la raccolta dei pomodori: “Tutta questa campagna intorno è libertà, (Elsa) vede persone e non maschere, e non le importa se è una sua illusione, l’ennesima visione”.

