Una famiglia
di Cristian di Furia
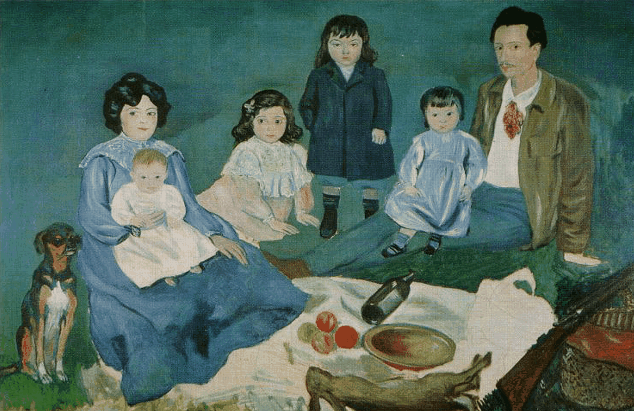 Un padre
Un padre
Quando otto anni fa mio padre è deceduto credevo mai più l’avrei rivisto: ieri invece mi ha telefonato per dirmi che era appena risuscitato.
Poi ha chiuso, e io sono rimasto col telefono in mano.
Poi ha richiamato e mi ha detto, ci vediamo?
Quando, ho chiesto io.
Ora, ha detto lui.
Dove, ho chiesto io.
Sotto casa, ha detto lui.
Quale, ho chiesto io.
Ma aveva già chiuso. E io sono rimasto col telefono in mano.
Così sono sceso, e sono sceso sotto casa mia, che non è casa di mia madre, da cui sono venuto via l’anno scorso, e non è casa di mio padre che a sua volta non è casa di mia madre – divorzi, litigi, comunione dei beni – e che non è neanche più casa di mio padre essendo, casa di mio padre, tornata casa del proprietario di casa cui mio padre pagava l’affitto e ha pagato finché è morto, casa mia, voglio dire, sono sceso sotto casa mia, quindi uscito dal portone: non c’era. Allora a piedi sono andato sotto casa di mia madre, che era anche casa di mio padre, e anche casa mia, e anche casa di mia madre finché mia madre non ha deciso di metterla in vendita da che sono andato via io e dacché di quella casa ha brutti ricordi, avendone invece trovati di più belli tra gli infissi e nei cassetti e sulle mensole della casa del suo nuovo compagno, quindi anche casa di mia madre prima che mia madre si trasferisse dalla casa di mia madre: non c’era. A quel punto, deciso, mi sono incamminato allora verso la casa di mio padre che non è più casa di mio padre e che non so di chi sia, se poi è di qualcuno, se poi, in effetti, è ancora dello stesso proprietario di prima o se invece non l’ha venduta come ha fatto mia madre con la casa di mia madre, sotto casa di mio padre che non è più di mio padre e che non so se ci abita qualcuno, se un nuovo padre o una nuova madre o un nuovo figlio o una nuova famiglia prima di diventare solo un padre, una madre e un figlio: non c’era. Quindi alla fine ho deciso di tornarmene a casa mia, perché casa mia, almeno questo, è casa mia e tanto basta, e così tornando da casa di mio padre, che non è più casa di mio padre, a casa mia, che è ancora casa mia, sono passato sotto casa nostra. Casa nostra è: casa nostra. La casa dove mio padre e mia madre hanno vissuto il loro amore, e io il loro amore e la mia infanzia. Ogniqualvolta, andando per la città, capitava di passarci sotto, tutti e tre ci giravamo, guardavamo il balcone del nostro vecchio appartamento e dicevamo: casa nostra. Non lo dicevamo, lo pensavamo. Casa nostra.
E insomma mio padre stava lì. Quello per lui era: sotto casa; sotto casa: casa nostra.
Mi stava aspettando, stava in silenzio, sul marciapiedi, in sella: a una bicicletta da bambini con le rotelle.
Papà…
Ciao.
Ciao.
Andiamo?
Dove?
Ma già era partito, già pedalava, già: in un fracasso rotolante di ferro su ferro e ferro sull’asfalto e l’asfalto era sconnesso, rotto sulle radici degli alberi emersi a rompere l’asfalto del marciapiedi lungo il quale mio padre pedalava a una lentezza esasperante, e facendo un rumore talmente assordante che mi guardavo intorno imbarazzato, ora per il rumore, ora per mio padre che stava sui pedali con le ginocchia che gli arrivavano alle orecchie.
Siamo arrivati al parco quando mio padre ha detto: siamo arrivati al parco; fermiamoci qui, e ci siamo fermati.
Avevo tante domande da fargli, e gliele avrei fatte pure, sulla strada, non fosse stato per il rumore. Avevo tante domande da fargli e gliele avrei fatte ora, gliele avrei fatte al parco. Una volta seduti, gliele avrei fatte seduti, sull’erba, e ci siamo seduti. Ci siamo, siamo seduti… E davanti a noi, più in là, ci sono due bambini: giocano, giocavano, a calcio. Uno tirava, uno parava. Quello che tirava ha tirato, e quando quello che parava ha parato si è poi alzato e ha rinviato, calciato, il pallone, al volo: il pallone, calciato, è andato in alto, in altissimo, e io che guardavo ho guardato i bambini che guardavano il pallone che in volo era sparito: quindi guardavano in alto, e basta, quasi pareva pregassero.
Dopo qualche secondo il pallone è esploso: ma lontano. Come un fulmine, ma lontano, come per annunciare una pioggia, lontana: che presto sarebbe arrivata.
Mi sono girato per dire a mio padre: hai visto?
Ho visto, invece: che mio padre non c’era più.
Una madre
L’auto accosta, lo spazio è libero. Quello alla guida chiede, per sicurezza, e affacciandosi al finestrino: «È libero?».
«Certo», gli risponde uno sulla soglia del teatro prospiciente.
«Posso parcheggiarmi qui, allora?» domanda di nuovo l’autista.
«Ma certo» gli risponde di nuovo il ragazzo sulla porta del teatro.
L’auto accosta, lo spazio è libero. E ampio. All’autista è sufficiente svoltare, allinearsi al marciapiede. E spegnere.
Esce dalla portiera e con un sorriso saluta quello davanti al teatro. Quasi contemporaneamente dallo sportello di dietro spunta una bambina, nove, massimo dieci anni. Sorride, è allegra, canticchia.
«Papà!, papà!» dice, «Papà, posso aprire io a mamma?».
«Va bene» le risponde il padre l’autista, «Apri tu».
«Evviva» esclama gaia la bambina. Che dunque scesa dal sedile, chiusa la portiera, aggira la macchina per andare all’altro lato. Ma si ferma, davanti al bagagliaio. E poi bussa, sul lunotto.
«Mamma?» chiama, «Mamma?» e bussa.
E apre: il palmo rivolto in alto, le dita che fanno scattare la serratura del bagagliaio. Lo sportello che si alza.
Nel bagagliaio non c’è niente, a parte una busta: nera, di quelle per l’immondizia. Piena: come una busta. Nera di cose; piena da buttare.
Una famiglia
Il piccolo non riesce a dormire: è notte e fa gli incubi. Così si sfila le coperte, scende dal letto, esce dalla camera e cammina: ha un pupazzo stretto al petto, giunge alla camera dei suoi, spinge la porta e entra.
Papà? Mamma, papà?
I genitori del bambino si scuotono dal torpore e lo guardano, teneri.
Posso dormire con voi?
Sospirano. Vieni, tesoro: rispondono.
Il bambino sorride e si avvicina al letto matrimoniale. Si piega sulle ginocchia, poi si sdraia a terra. Finalmente striscia, sotto il letto, e si mette: tra mamma e papà.

