La radice dell’inchiostro. Dialoghi sulla poesia (terza parte)
NOTA INTRODUTTIVA
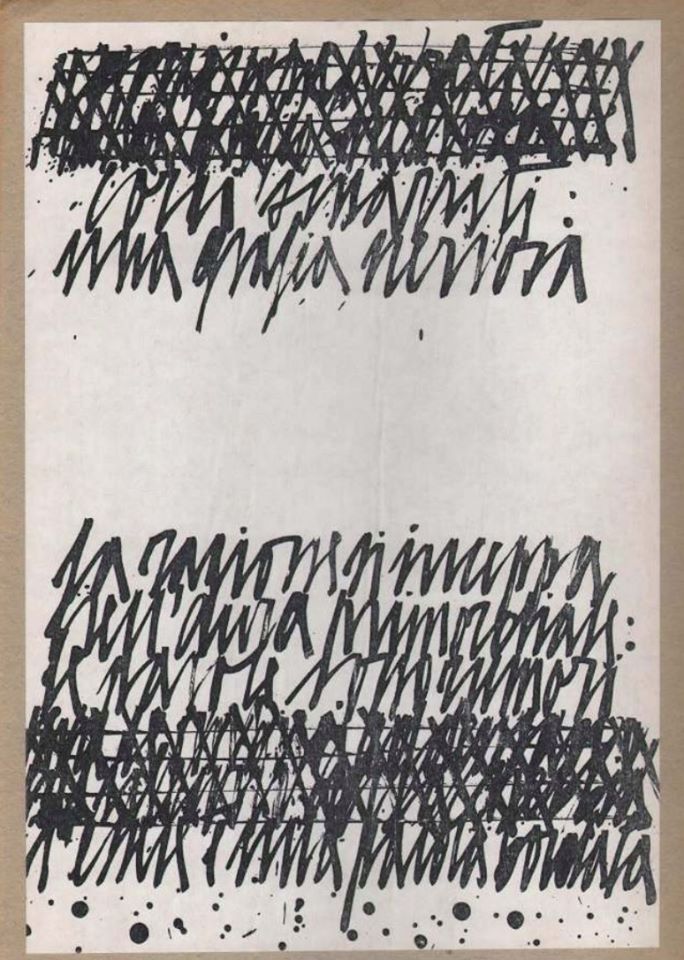
Giancarlo Pavanello, Prosa
«Forse non spetta a te di portare a termine il compito, ma non sei libero di rinunciare.»
(Avot 2,21)
Un questionario, come luogo di una sollecitazione: «È ancora legittima la radice dell’inchiostro?». Non solo il come si scrive, ma lo scrivere stesso, malgrado le storture. Lo scrivere che si porta avanti per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento.
Una nota appuntata altrove scompiglia ulteriormente il ciglio dell’interrogazione: «Come dimenticare la fine -della storia, della poesia-? Non soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in eschaton rovesciato, in buona novella liberale: “la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità” (Sergio Quinzio, La Croce e il Nulla, 1984).»
Oggi la scrittura non sarebbe altro che uno stornare la necessità di una risposta a tali quesiti, e insieme un esserne già in partenza incomodati, chiamati a dire prima ancora di sapere. Citati in giudizio. Forse per questo i poeti italiani somigliano sempre più a glossatori dell’affaccendamento, come se l’andirivieni tra le cose quotidiane fosse un modo per incenerire con uno stesso rogo i sintomi del presente e l’eredità del secolo passato. Qualcosa continua a battere sulla pagina, e allora ne riporto una traccia…
Adriano Spatola, da Poesia Apoesia e Poesia Totale (1969): «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno. […] “Per il poeta, la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”». Corrado Costa, da Alzare la gru ad alta voce (1972): «Che nome è che gridano / alle gru spaventate dal loro nome / volano via inseguite dal nome che le insegue / che vola via sta insieme con le gru / senza sapere che nome è». Emilio Villa, da quell’abiura in forma di annotazione che segnerà il suo congedo definitivo dalla letteratura (1985): «Ma, volevo dire: non si sente che io non credo alla “poesia”, che ritengo una baldracca del baldraccone che è il linguaggio … Io mi sono duramente dissociato della “poesia”, quindi perdonami, e non mi chiedere più niente».
Nulla più che righe inferme, potrebbe obbiettare qualcuno. Se non altro, questo breve attraversamento aiuterà a scamuffare le tresche dell’oblio programmato, e così a comprendere qual è il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare. Ogni nostra parola vigila il suo personale dirupo: sta a noi scrivere come se già custodissimo un anticipo della caduta.
Il vero lavoro del glossatore, conviene ripeterlo con Heller-Roazen, è quello di rinnovare l’incompletezza, poichè sempre precaria dovrà essere l’interpretazione del libro-mondo (e insieme sempre cercata). Proprio a partire da ciò, ho chiesto ad alcuni poeti e critici letterari di farsi alleati a una riserva di bianco. Di raccogliere gli interrogativi da posizioni divergenti, cioè di strincerarsi, e di usare questo spazio come un modo per tornare a domandare un qualche assenso alle cose nominate…
Giorgiomaria Cornelio,
dicembre 2019
SOGLIA
soltanto raccogliere. Gocce di resina, galle,
sul muschio ingiallito, stucchi, calcine,
dentro un’ampolla incrinata, crostuta di polvere,
non sarà vanto, di sapere far cernite, di velare,
costringere al meglio, scartando, la fattura,
di altre e di molte, ore che varranno, liete,
quanto il tepore del bianco, la scansione limpida
come d’albume, delle nuove parole, perlate,
in procinto di muta, da inchiostro a candide biacche,
che non trattengono il pasto, la veglia, fanno ragione,
dell’uso e del profitto, rendono l’estro, a disciogliere,
provetto, per l’armonia degli incontri, a rastremare,
a spargere il sale, prodigo, non porgere cura,
verso la fine, alla scelta: soltanto raccogliere
Giuliano Mesa, Quattro argomenti
TAVOLA DEGLI INTERVENTI
(uscita il 14 marzo)
Aldo Tagliaferri / Giulia Martini / Davide Brullo / Polisemie (Mattia Caponi, Costantino Turchi) / Francesco Iannone / Carlo Selan / Marco Giovenale / Mattia Tarantino / Giovanna Frene / Carlo Ragliani / Marilina Ciaco / Sergio Rotino
(uscita il 29 marzo)
Matteo Meschiari / Andrea Inglese / Davide Nota / Renata Morresi / Riccardo Canaletti / Bianca Battilocchi / Anterem (Flavio Ermini, Ranieri Teti) / Mariangela Guatteri / Mario Famularo / Fabio Orecchini / Giovanni Prosperi
TERZA PARTE
Massimo Gezzi / Mariasole Ariot (con Andrea Inglese) / Vincenzo Ostuni / Lorenzo Mari / Giorgia Romagnoli / Daniele Poletti / Alessandro Mazzi / Claudia Zironi / Enzo Campi / Alessandra Greco
MASSIMO GEZZI
A place for the genuine
Caro Giorgiomaria,
c’è una famosa poesia di Marianne Moore, intitolata Poetry, che in una prima versione del 1921 comincia così: «I, too, dislike it: there are things that are important beyond all this fiddle» (e credo che «fiddle» contenga in sé sia l’idea dell’imbroglio, della truffa, sia quella del perder tempo, del cincischiare). È un testo furbo, perché subito dopo Moore ci dice che in ogni caso, leggendola con tutto il disprezzo che merita, nella poesia si può trovare comunque «a place for the genuine», con tutta l’ambiguità e la scivolosità di quella parola (genuino? autentico? vero? Che in ogni caso è sempre meglio dell’«onesto» di Saba, per quanto mi riguarda). È il testo da cui un giovane poeta americano, Ben Lerner, è partito per scrivere il suo brillante e ambiguo pamphlet Odiare la poesia (Sellerio, 2016), atto d’accusa e d’amore nei confronti del genere di cui parliamo.
Spesso provo anch’io questa contraddizione, ultimamente. Scrivo pochissimo, pubblico ancora meno e quando leggo gran parte della poesia che circola vado in cerca con ansia del «genuine» di cui parla Moore, che può prendere le forme linguistiche e testuali più disparate, ma non lo trovo così spesso. Perché mi accade questo? Dipende soltanto da me? Per certi versi sì, devo ammetterlo subito: il mio rapporto con la poesia è cambiato, da qualche anno a questa parte. L’accelerazione della vita e delle relazioni sociali, l’eccesso di comunicazione, la mia professione di insegnante, l’impossibilità quasi sistemica di stare da soli e di riflettere con continuità mi hanno costretto a una postura diversa, nei confronti dei testi poetici. Se quando avevo venti o trent’anni leggevo tutto quello che usciva, rispondevo con lunghissime email (irreali, a ripercorrerle ora) a chi mi mandava qualcosa da leggere o reagiva con generosità a quello che gli avevo mandato io, ora non sono più così sistematico, così continuo. Però leggo, naturalmente. Con più lentezza, discontinuità, ma leggo. E se la poesia certe volte mi appare un fiume lutulento forse dipenderà un po’ anche da lei e dalle condizioni che la riguardano, mi dico: ovvero, credo, dalla mancanza di attrito di cui ha parlato in questo stesso spazio Andrea Inglese, dalla difficoltà di trovare campi di interesse attorno ai testi, alle opere. Si scrive e si pubblica molto, forse troppo (e troppo spesso); si legge (profondamente) e si condivide poco, e spesso tale condivisione obbedisce a logiche più da social che da comunità di lettori: i campi di interesse si formano sempre di più attorno a un nome, a un profilo, secondo quella che Gianluigi Simonetti, parlando di Bianco di Easton Ellis, ha chiamato «sindrome di Tripadvisor». Dire perché questo accade è complesso: perché la critica della poesia contemporanea è morta o agonizzante; perché l’editoria di poesia è esplosa in una galassia di sigle di pari valore (per fortuna), per cui i grandi marchi in fondo non assicurano né una leggibilità né un canone; perché questa è l’epoca del narcisismo di massa; perché scrivere, pubblicare e distribuire poesia, considerati i relativi pubblici, è più facile che scrivere, pubblicare e distribuire un romanzo, ecc.
Per tutte queste ragioni e per altre ancora, a volte faccio fatica a orientarmi, a seguire, a capire. E tuttavia, accanto al «contempt» di cui parla Marianne Moore resta sempre in me lettore – prima che scrittore – il desiderio di percepire, in un testo poetico, quella reazione che mi fa dire sì, ci siamo, qui si sta dicendo – o costruendo – qualcosa di vero (o di genuino, di autentico, di importante…). Ecco, io credo di non cercare nient’altro, nella poesia, che questa traccia di verità (con la minuscolissima), e continuo a credere, nonostante «all this fiddle», che questa forma di espressione linguistica sia una delle più forti e profonde che abbiamo. Devo chiarire però qualcosa a me stesso e a chi legge, perché io non penso che la poesia sia l’espressione di una verità: come se tutto ciò che conta fosse lì fuori, a disposizione della nostra percezione e intelligenza, e la poesia non fosse altro che una sorta di mimesi, di trascrizione, al limite di raffinamento (per carità!) di quella realtà. A me pare che la poesia sia, nei confronti della verità, sempre un passo indietro, come un asintoto rispetto a una curva, o come Achille che non riesce mai, per quanto corra veloce, a raggiungere la tartaruga. E questo perché mentre la poesia tenta di costruirla, una verità, questa sfugge, scarta di lato o in avanti, si sposta di un millimetro, si rivela diversa da quella che credevamo di avere in mano quando abbiamo cominciato a scrivere. In fondo sta qui la forza conoscitiva e persino politica della poesia: nell’accendere in chi legge e in chi scrive il desiderio di un oltre, di un di più, di un meglio, perché quello che si è letto o si è scritto magari è giusto ma non basta, non soddisfa, non conclude. Quello che dobbiamo capire o realizzare è ancora un passo più in là (qualcosa di simile, mi pare, dice anche Lerner).
Per questo apprezzo la poesia che sa accendere quella tensione, con i suoi strumenti precipui ed essenziali (il significato, il ritmo, il suono). Una scrittura che sappia vivere in un rapporto dinamico tra parola e cosa, insomma: né troppo schiacciata sulla realtà, come se questa fosse l’unica dimensione davvero importante (è la vecchia concezione di arte come mimesi, di cui accennavo sopra); né annegata nella parola, come se questa avesse un valore magico, una capacità creatrice autonoma (è la vecchia concezione simbolista). Cerco e provo a scrivere, nella mia esperienza di lettore e di scrittore di versi, una poesia in continuo viaggio tra parola e reale, tra ciò che abbiamo e ciò che dovremmo avere e non abbiamo ancora. A prescindere da tutti i complessi discorsi che potremmo intavolare sul contenuto dei testi, sull’ordine o sul disordine stilistico, sulla postura dell’io, sull’efficacia della letteratura (in termini politici o etici), questo continua a sembrarmi il nucleo incandescente e vitale della scrittura in versi, il suo «place for the genuine».
Grazie dell’opportunità,
Massimo Gezzi
LORENZO MARI
B***, 2*/*/20**
Caro Giorgiomaria,
cerco di rispondere alla tua domanda intendendola come una questione radicale, nella sua offerta e richiesta di esposizione, o di strinceramento, come scrivi. Ti ritrovi tu stesso esposto e, com’è del tutto comprensibile, il primo passo è di ripiegare e prevedere già una prima reazione, in quel paradosso tra lo stornare la necessità di una risposta e l’esserne già in partenza incomodati che per molti, anche per me, è già un accenno di risposta. Di per sé non basta, naturalmente: la risposta è da verificare nella scrittura e, trattandosi di un paradosso, anche nel silenzio, nel bianco della pagina. Senza verifica, infatti, si può anche aggirare la portata radicale dell’interrogativo e continuare a parlare, non di rado in modo illegittimo: si possono anche produrre volumi poderosi cercando di analizzare con puntiglio un paradosso, uno solo…
Ma non si tratta soltanto di una verifica dei testi, si tratta anche di una verifica dei poteri, per usare un’espressione nota: se la contraddizione resta esclusivamente contra-dizione, senza misurarsi con l’ascolto, o il vuoto in cui cade, il suo destino è di cadere senza fare alcun attrito – come già rilevava qualcun altro, qui.
A questo, aggiungo che ci si potrebbe porre anche la domanda speculare: è legittima, oggi, l’abiura? Differentemente dall’esposizione – che, a dispetto dell’etimologia più facile, non ha bisogno di rapportarsi a una posizione originaria – alla radice dell’abiura mi sembra, invece, che debba esserci una qualche posizione: raggiunta, costruita o (de)negata che sia, riconoscibile o irriconoscibile, dentro o fuori, magari oltre, la letteratura. Qualcosa che si potrebbe essere tentati di replicare, senza scandalo né rischio…
E poi, se oltre l’abiura ci fosse, oggi, una nuova mistica che si bea del proprio silenzio, o della propria luce, dimenticando del tutto la notte oscura che si è attraversati o si sta attraversando?
In altre parole, per chi e in quale circostanza è legittima l’abiura, oggi, senza che sia una ripetizione epigonica, un abbaglio o altro?
Suscitare una domanda in risposta a una domanda, senza essere in grado di rispondere, mi sembra un buon modo non tanto e non ancora per motivare o legittimare la scrittura, ma per introdurre un aneddoto e, nel caso si tratti di un aneddoto potenzialmente condivisibile, per cercare di parlare di una tendenza. Da molti amici, dunque, ho sentito dire, negli ultimi tempi, che il gesto intellettuale (o, nel nostro caso, la scrittura: non mi pare che sia sempre giustificato e necessario distinguere tra questi tipi d’inchiostro) necessita di essere consapevolmente posizionato e che, al tempo stesso, questa posizione non si trova più, non è più individuabile. Ne nasce l’idea di una trincea infinita, invalicabile, popolata da quelle che sembrano essere monadi – al meglio delle nostre possibilità, è stato ricordato, ci ritroviamo nella solitudine della forma – che, però, non sono del tutto nascoste e che per questo ogni tanto si sfiorano o, perlomeno sul piano fenomenologico, si incontrano. Ci possiamo interrogare a lungo sull’incontro tra monadi ma a un dato momento, in un dato luogo, occorrerà estendere la prospettiva – immaginandola, al più, sognandola, profetizzandola, etc. – al campo di battaglia. Potrebbe essere davanti, alle nostre spalle – potremmo imporci la velleità di raggiungerlo, dunque, anche con l’arretramento… – oppure non essere qui, non esserci.
Mi sembra, insomma, che non sia possibile dare pienamente senso né alla continuazione imperterrita né all’abiura, non potendo determinare con certezza alcuna posizione. Ciò che può perdurare è l’esposizione (non siamo mai del tutto nascosti, all’interno della trincea, e a quel punto potrebbe non esserci nemmeno, la trincea, potrebbe ridursi ad esempio ad una narcisistica volontà di autodefinizione), per evitare di portare avanti in modo esclusivo l’im-posizione mortifera della parola sulle cose assenti. Potrebbe essere un’esposizione aperta alla contraddizione in quanto contra-dizione, ma anche come epifenomeno di una totalità non del tutto perduta (magari solo tralasciata, taciuta, aggirata…). Non sarebbe solo nudità, ma anche cammino, attraversamento, magari verso una nuova posizione, successiva e non antecedente all’esposizione. Ancor meglio che cammino o attraversamento, una tendenza, radicata nell’amicizia: non l’amicizia di congrega e nemmeno in quella radicata in una fraternità di per sé esclusiva ed escludente, ma in una comunità a venire.
Che sia il momento più propizio, nella distanza imposta, per immaginare, sognare, profetizzare, etc. (forse: designare e insieme disegnare) una simile comunità nella parola esposta?
Non ti dico da dove scrivo, né il giorno – non lo so – ma ti abbraccio, a colmare un vuoto sul quale dovremo poi verificare una tendenza, ossia come (ci) si (in)tende.
GIORGIA ROMAGNOLI
Non ci è dato sapere
Non occorre dire niente
non occorre insegnare niente,
è così triste e buona
la buia anima selvatica:
non vuole insegnare niente,
non sa affatto parlare
e nuota come un giovane delfino
per le canute voragini del mondo
O.Ė. Mandel’štam
(…)
Così, e con forza uguale, la più piccola cellula del corpo dell’uomo è attaccata alla parola, e viceversa.
Ma a volte un altro essere viene a violare questa tomba, se è fatta bene, e a fissarvisi al posto del costruttore defunto.
È il caso del paguro.
F.Ponge
Generalizzare parlando della storia della poesia come qualcosa di concluso e negando che essa possa sopravvivere a se stessa e all’autore, al momento attuale non mi sembra verosimile: finché scriviamo tesi di dottorato su autori contemporanei, facciamo critica o semplicemente pubblichiamo non si può intravedere un punto di arrivo.
Probabilmente siamo qui a scrivere perché altri lo hanno fatto prima di noi e continuiamo a causa di quell’attaccamento alla parola che ci è proprio in quanto esseri umani. Che sia inerzia o un giocare a render conto della nostra esistenza, la scrittura senz’altro non ci rende persone migliori – come sostiene Marilina Ciaco – ma non ci è dato sapere se resterà o meno, pur senza alcuna pretesa.
Non sarebbe forse più lecito chiederci cosa intendiamo per poesia, qual è il nostro concetto di forma, su quali riferimenti ci basiamo, quanto c’è di ancora non tradotto (anche in termini di critica)?
Inoltre – ne discutevamo tempo fa con Luca Rizzatello ad un incontro bolognese – siamo legati all’oggetto libro e quindi alla memoria; ma che fare quando l’oggetto non è più in grado di racchiudere la forma? (Mi vengono ora in mente i lavori di Nicco Furri, quelli Ophelia Borghesan o Andrea Leonessa). Può la rete darci ciò che ci dà il libro a livello di visibilità e memoria? Ma soprattutto: ne abbiamo necessità? E in caso contrario, la labilità della rete e la rinuncia al supporto fisico porterebbero a una effettiva fine della storia della poesia?
DANIELE POLETTI
Libro dell’abbandono del libro
THEMROC
{Daimonografia della citazione}
«La macchina dispotica tiene costantemente sotto controllo la messa in opera del sapere perché questa è una condizione essenziale per la sua sopravvivenza e, allo stesso tempo, essa è cosciente del fatto che non le è possibile sottrarre l’esercizio del potere dal riconoscimento automatico dell’esistenza universale dell’oppressione. […] Il primo dovere del sapere è il “non-sapere”, l’esaltazione dialettica della voluttà, i cui effetti sono fuori discussione: lo sgretolamento della macchina di produzione capitalista».
Ancora.
«La macchina dispotica esalta le rivoluzioni a sua immagine e somiglianza, come quelle, per esempio, che si danno il compito di rovesciare lo Stato o colpire a morte i rapporti di produzione capitalisti. […] Queste parodie rivoluzionarie […] sortiscono dei risultati […] come quello di prendere del potere senza prendere il potere e, soprattutto, senza distruggerlo, così, tutto si limita ad un generico controllo sulla produzione della propria sopravvivenza che quasi sempre vanifica molto in fretta».
Siamo nel 1979, Bernard Rosenthal (al secolo Gianni Emilio Simonetti) in Fine delle utopie sul buon governo.
Il 26 febbraio del 1969 “Le Monde” apriva un articolo della pagina culturale con queste parole: «Il s’agit de la première pièce d’un inconnu» => “Doux métroglodytes” de Claude Faraldo; il pezzo si riferiva a uno spettacolo teatrale, da cui Claude Faraldo prenderà spunto per la sceneggiatura del film Themroc del 1973 (goffamente conosciuto in Italia come Il mangiaguardie, titolo che oblitera del tutto la presenza anagrammatica di “Metrò” nella parola, appiattendo una sia pur indiretta – remota per lo spettatore italiano – carica simbolica e ricchezza analogica del linguaggio ingaggiato dal regista).
Themroc è un operaio, cittadino medio, schiacciato dai ritmi di vita della società di massa. Dopo aver subito un rimprovero ingiusto sul posto di lavoro, in preda a una rabbia viscerale, regredisce a una sorta di stadio primitivo. Tornato a casa, si mura in una stanza, ne demolisce la parete esterna, che dà su una corte, ricreando una specie di caverna e dà il via a una rivolta contagiosa che pian piano coinvolge sempre più persone. Le guardie cercano di intervenire, ma Themroc e la sua nuova comunità reagiscono mangiandosele arrosto. Il grottesco e sferzante film di Faraldo, che distrugge in sol colpo tutte le convenzioni del “buon governo” e della buona società – partendo dalla parafasia glossolalica di tutti i personaggi, prima del regressus di Themroc, per arrivare alla più estrema prefasia gutturale del protagonista, che risolve il linguaggio a pura funzione fàtica; passando attraverso l’eliminazione di tutti gli orpelli del vivere borghese, ma anche dei tabù più radicati nella società occidentale, come l’incesto e il cannibalismo; il tutto nella cornice di un’autoregolamentazione pseudo-anarchica, che ovviamente scardina e affonda le istituzioni – è assimilabile alla pratica della negazione di stampo avanguardista: «Tornare al punto di partenza per ricominciare dall’inizio e fondare un nuovo linguaggio sgombro dalle scorie. […] Questo perpetuo ritorno all’origine operato dalle avanguardie implica che, nel regime radicale dell’arte, il nuovo diventi un criterio estetico in sé, fondato su un’antecedenza, sullo stabilimento di una genealogia all’interno della quale si distribuiranno ulteriormente una gerarchia e dei valori» (Nicolas Bourriaud, Il radicante).
L’abbattimento di un iperoggetto (v. Timothy Morton) come il capitalismo attraverso un’ipotesi di rivoluzione, per quanto sia un argomento ancora ricco di fascino e di potenza, risulta ormai poco credibile e forse sorpassato. «La nostra epoca dell’ansia è, in gran parte, il risultato del tentativo di svolgere i compiti di oggi con gli strumenti e i concetti di ieri» (Marshall McLuhan, Il medium è il massaggio).
Distruggere il potere, quindi il capitalismo, si configurerebbe come la volontà di distruggere il capitale del linguaggio, ma rimarrebbe un’operazione specifica, all’interno del linguaggio stesso in quanto mezzo. «Se si interroga la natura della pittura, non si può interrogare anche la natura dell’arte. Questo perché la parola arte è generale mentre la parola pittura è specifica» (Joseph Kosuth). Si tratta di riflettere non sull’effrazione del mezzo, ma sull’effrazione del contesto, grazie alla manomissione => (intesa anche nella prima accezione derivante dal diritto romano) del mezzo. Tesaurizzare e prosperare o sopravvivere (come dice Rosenthal), significa sedimentare segmenti di potere che fruttano solo al potere più grande, quello inaggirabile, l’iperoggetto, per ottenere (per riconoscimento) un ridicolo potere temporaneo, esteticamente inutile, se non riprovevole. Stare dentro il contesto o fuori da esso. Oppure starci dentro respirando l’ossigeno della “disappartenenza”, unica incrinatura possibile della Tavola.
«Il fine più alto è il non avere nessun fine. Questo pone in accordo con la natura, con il suo modo di operare» (John Cage, Silenzio). Cage sviluppò la sua ricerca non tanto sul livello dell’innovazione linguistica ma, più a fondo, sulle basi antropologiche della pratica musicale e dell’arte. Mentre le avanguardie consumavano nel secondo dopoguerra una rincorsa alla dissoluzione di ogni convenzione linguistica, Cage si interrogava sul significato stesso del fare musica (v. supra Kosuth).

* «L’orecchio non privilegia nessun particolare “punto di vista”. Siamo avviluppati dal suono. Esso forma un’ininterrotta ragnatela sopra di noi. Diciamo “La musica riempie l’aria”. Non diciamo mai “La musica riempie un particolare segmento dell’aria”. […] Non possiamo spegnere il suono automaticamente. Semplicemente non siamo dotati di palpebre sulle orecchie. Mentre uno spazio visivo è un continuum organizzato di genere uniforme e connesso, il mondo dell’orecchio è un mondo di relazioni simultanee» (Marshall McLuhan, Il medium è il massaggio).
Themroc, vittima e incolpevole rivoluzionario privo di progetto, attua una rivolta radicale senza un fine preciso, se non quello della negazione delle “strutture linguistiche” (intese come strumenti di rappresentazione e controllo in senso ampio), non riuscendo a sommuovere il contesto che fonda quelle stesse strutture. Il suo è un fuoco di paglia, seppure sfavillante, una rivoluzione che utopicamente riporta la scrittura al corpo, grazie all’eliminazione della parola-cosa, del raddoppiamento che la scrittura fa del mondo e quindi dello scambio simbolico di stampo capitalistico. Themroc è l’analogon contrario di Amleto, quasi un caso di enantiodromia, entrambi criticano il potere della parola: l’uno stracciandola e rinnegandola, l’altro interrogandola e cercando di farne uno strumento di verità, ma entrambi sono destinati al fallimento, perché il medium non diventa massaggio, ma rimane messaggio.
A tale proposito non sembra essere risolutiva, ai miei occhi, neppure la “teoria dell’ipergesto” sostenuta con convinzione da Paolo Mottana, ma con mutuazioni importanti da Yves Citton e Hakim Bey. Per contrastare l’imposizione della monolingua dell’immaginazione della merce, della comunicazione della merce e del significato della merce che la nostra società ha acriticamente adottato, si ipotizza l’atto insurrezionale dell’ipergesto. «Il carattere insurrezionale dell’ipergesto, in quanto “aumento di tensione” e non “soluzione permanente”, in quanto azione che non pretende di strutturarsi in forma definitiva, ma che promuove mutamenti in divenire, che si manifesta come un appello, una dimostrazione, un esempio cui ispirarsi per affermare nuove linee di concatenamento, nuovi flussi, nuove posture sociali, economiche e passionali, fa di esso un atto regolativo e mai definitivo» (Paolo Mottana, L’ipergesto).
L’indicazione precisa è quella di muoversi all’interno della sfera in cui siamo immersi, quella mediatico-comunicazionale, e utilizzarla per la mobilitazione e diffusione di messaggi per la sovversione della narcosi e dell’appiattimento inerziale del senso critico.
https://soundcloud.com/canecapovolto/istituto-di-obbedienza-animale
canecapovolto, Istituto di Obbedienza Animale
«[O]rigine della scrittura è la decisione del supporto, dove la natura del supporto è la sua smaterializzazione. Il supporto è ciò che si assenta, ciò che fa un passo indietro, ciò che si annulla, ciò che si decontestualizza […] primo supporto è il corpo, anzitutto lì avviene la smaterializzazione del mondo e il mondo viene messo in prospettiva; il qui è un segno per là e io sono nel mezzo, non sono mai radicato, sono sempre nello slancio della prospettiva» (Carlo Sini, in De|Scrittura).
Se la scrittura è per biologia desostanzializzazione del mondo, in un sistema di segni che restituiscano senso, e il supporto stesso si ritrae per far esistere la scrittura – nel caso dei nuovi dispositivi tecnologici il risultato non cambia, anzi diventa esponenziale, in quanto se il foglio è metafora della sua nullità nel bianco, il supporto elettronico è nullità senza metafora) – la simbolica dell’assenza per sottrazione deve farsi parte costitutiva della scrittura come elemento di continuo differimento del senso. Volendo rimanere all’interno delle strutture linguistiche è necessario dunque un altro tipo di approccio.
«L’uomo conduce la sua vita ed erige le sue istituzioni sulla terraferma. Ma il movimento della propria esistenza cerca di comprenderlo, nella sua totalità, specialmente con la metafora del temerario navigare» (Hans Blumenberg, Naufragio con spettatore).
«[Q]uando Foucault parla di resistenza parla della possibilità di creare degli ambiti nei quali ciò che il potere nega viene comunque salvato; la resistenza non è opporsi per rovesciare la tendenza, ma è invece la capacità di contenere, come in una bolla, come in un ambito separato […] ciò che va assolutamente salvato. […] Il senso in cui Foucault parla di resistenza mi pare contenga l’idea di costruire ambiti di autonomia, di indipendenza, di sottrazione, piuttosto che l’idea di far fronte e contrapporsi». Così Franco Berardi Bifo glossa il suo concetto di fuga, intesa come sottrazione dai meccanismi che soffocano la divergenza.
«Vous êtes embarqué» (Blaise Pascal). Le istituzioni della terraferma devono essere continuamente forzate per arrivare a delineare la dinamica del “naufragio attivo”: luogo in cui, non solo spettatore e naufrago vengono a identificarsi, ma dove è necessario spezzare l’eterno ritorno dell’uguale abbandonando la nave venuta costruendosi, che a sua volta diventerà relitto alla deriva per ulteriori forme di naufragio: di nuovo nuotare cercando di imbattersi in altri segmenti.
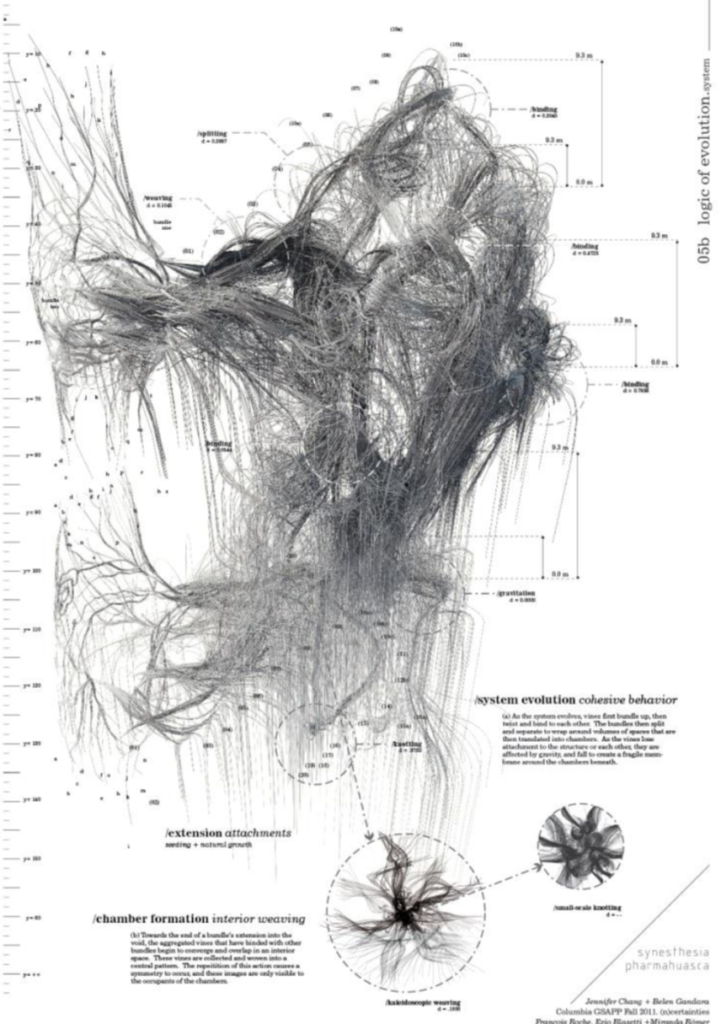
«L’immigrato, l’esiliato, il turista, l’errante urbano sono pertanto le figure dominanti della cultura contemporanea. L’individuo di quest’inizio di XXI secolo, per restare in un lessico vegetale, ricorda quelle piante che per crescere non si affidano a un’unica radice, ma avanzano in tutti i sensi sulle superfici che si offrono loro, aggrappandovisi come l’edera. Quest’ultima appartiene alla famiglia dei radicanti, i quali fanno crescere le radici a seconda della loro avanzata, contrariamente ai radicali, la cui evoluzione è determinata dall’ancoraggio al suolo» (Nicolas Bourriaud, Il radicante).

Così i contatti col suolo si riducono e la scelta, la selezione, per acclimatamento, diventa un processo di capacità di contestualizzarsi all’ambiente non appartenendogli mai fino in fondo. La disappartenenza è una condizione di sradicamento perpetuo e di ritmo eteromorfo rispetto all’habitus. Si afferma non per insurrezione, né tantomeno per rivoluzione, quanto per sottrazione dalle logiche di utilità e aspettativa. Insomma una sequenza ininterrotta di naufragi dove, per parafrasare Tim Ingold, la meteorologia sostituisce la geometria lineare – che comprime la vita in punti e definisce la linea come la distanza più breve tra di essi – in favore di una mappatura delle masse in volumi, definendo la densità come il rapporto tra gli uni e gli altri. Nello spostamento di una massa i percorsi diventano orbite o traiettorie. Per effetto del continuo re-radicamento queste orbite sono spezzate e inarginabili, provocando una deflazione del codice per inflazione di senso.
«È ancora legittima la radice dell’inchiostro?».
«Insegnamento che Reb Zalé tradusse con questa immagine: “Tu credi che sia l’uccello a essere libero. Ti sbagli; è il fiore… » (Edmond Jabés, Il libro delle interrogazioni). Per effetto della deflazione, ma quella operata dal vento portatore di disgregati, la radice dell’inchiostro può proliferare e vivere attraverso l’aria. La radice dell’inchiostro è lo spostamento di una massa d’aria. E avendo toccato tutti o quasi gli elementi che pertengono alla biosfera, in un’epoca ormai denominata Antropocene, risulta necessario liquefare i confini della semiosfera e tentare di ragionare in termini di Meteorocene. Se non altro per un’“ecologia della mente”. Altrimenti, di questo passo, l’inchiostro diventerà sempre più inutile.
ALESSANDRO MAZZI
Ogni tempo è storia di discese
«La Storia, disse Stephen, è un incubo da cui sto cercando di svegliarmi»
James Joyce, Ulysses
La radice è un organismo di percezione spaziotemporale. L’albero se ne serve per distinguere l’alto e il basso. Non sono forse i rami le radici del cielo? Radice e ramo sono gemelli. Entrambi si accordano sul sopra e sul sotto. Il sopra e il sotto, che grande mistero. Ci fu un tempo dove non esistevano, e quindi non c’era tempo. Quando abitavamo le fronde degli alberi, c’era solo atemporalità. Il suolo era un grande animale dal pelo cangiante. Le brevi escursioni ai corsi d’acqua plasmarono i miti dell’aldilà. Scendere dall’albero era sempre un viaggio orfico, ogni scimmia uno Stilita tuffatore. L’acqua è quella sostanza che non risale mai. Ecco perché sollevarla è prodigioso. Poi ci incamminammo a terra, tastammo la granulosità degli eventi. Ci rendemmo conto di essere alberi. Scendere a terra, alzarsi sulle gambe, liberammo gli arti superiori e scoprimmo l’alto: ecco l’inizio della Storia. Ogni tempo è storia di discese. Come la scimmia scende dall’albero, l’uovo scende dal corpo, il serafino discende dal cielo e si mostra nella Storia. La vita, anche quella sacra, è gravità.
La gravità degli angeli. Perché l’alto e perché il basso? Si discende nella Storia, e si sale nell’Eternità. Anche in seguito la Storia mantenne sempre il senso di essere bassa. Lasciammo la foresta e i cenotafi arborei che coprivano il cielo, guardammo per la prima volta un cosmo senza fronde. Ora gli alberi non erano più l’alto. Ora gli alberi erano uno degli alti. C’era un alto silvano sorretto dagli alberi, e c’era un alto desertico sorretto dal nulla. Nasce la metafisica. Inizia il viaggio sciamanico. Irrompe l’immaginazione, le prime storie di ascesa, le scalate degli alberi. Gli alberi ora non sono più identici allo spazio, ma un passaggio, un tramite. I ponti che conducono ai palazzi d’oro, il giaciglio sui cui rami sonnecchiano felini gli dèi.
«Lascia dunque che ti parli del momento drammatico in cui la Parola non è ancora che il progetto doloroso di un rantolo muto… Riesci a pregustare questo silenzio così pregno di tuono?»
René Daumal, Controcielo.
No, la scrittura non è necessaria. Perché quello che può dire l’uomo è già gridato dall’aquila e dalla cascata. Ed è questo il punto. Nonostante tutto, qualcosa vibra. Un dito che scrive sull’acqua.
CLAUDIA ZIRONI
Fantasmi: la Poesia
E se la poesia si reggesse sull’equivoco di vite sospese?
Che solo da un certo bilico di confini potesse venire il sublime come errore.
Se fosse più vicina alla morte di un nido abbandonato nel fango di ottobre o di una spuma d’onda;
un’incomprensione della convenzionale accettazione di un transito, istintività deviata
di propagazione, difetto di visuale come un occhio dal nervo malato che sfochi i primi piani,
un orecchio sensibile solo agli acufeni tanto da confondere nel cervello la percezione del reale.
Se i poeti per ciò si riconoscessero senza potersi accoppiare, incapaci di lasciarsi in eredità,
muli sterili assediati di visioni, separati: se fosse un difetto dell’amore, come un gene zoppo,
una mancanza partorita, quest’arte?
Se fosse sintomo di un fantasma nella mente?
Assunta la domanda a postulato, superato lo iato tra poesia e prosa, riconciliato il concettuale con l’estetico, arresa nichilisticamente all’innegabile necessità individuale di produrre arte come somma manifestazione di ego, esplorato laicamente a grandi linee il lato mitico ed esoterico del verbo, passata dal letto di D’Annunzio a quello di Villa, derubricate l’ontologia e la fede a incidenti di umano percorso, escluso il bisogno ineluttabile di dare un’agambeniana forma alla mia vita, opto per un dialogo diretto con l’inchiostro e con l’amante che lo ha incarnato:
mi hai insegnato l’impotenza, l’inutilità
della parola, quanto sia vana la poesia.
la mistica del segno, un risonare di mondi
inesistenti, dare il nome alla creazione
e chiamare ad alta voce ogni pensiero
non avvicinano al divino né all’amore.[1]
Eppure scrivo. Come respiro scrivo, come mi sveglio, come sorrido e piango. Scrivo. Io sono la macchia di Rorschach – dove puoi vedere la farfalla o la testa mozzata.
La radice è ben piantata nel mio sistema cromosomico, nella mia catena evolutiva. Io sono la gemma dell’inchiostro. E la sua scoria.
[1] da “Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni” di Claudia Zironi, Marco Saya Ed., 2016
ENZO CAMPI
Palinsestosenso (fallacia e incompiutezza della scrittura)
Partiamo da una poesia o, se preferite, da un pezzo di scrittura. Una poesia qualunque. Non ha importanza (o comunque è relativamente importante) ciò che viene detto ma come viene esposto (disperso) sulla pagina. Questo non significa che ci si debba ridurre al solo aspetto (fatto, fenomeno) estetico. Forma e contenuto, in teoria, co-esistono in uno spazio la cui unità di misura (di fruizione?) è scandita da una temporalità. L’insieme di forma-contenuto/spazio-tempo produce sempre un risultato, a prescindere dal fatto che possa ritenersi, a seconda dei punti di osservazione, compiuto o incompiuto. Ciò che ne risulta è quindi un tipo o un prototipo che si potrebbe assumere a modello per una possibile reiterazione del gesto. Il fatto che gesto e gettata appartengano alla stessa famiglia etimologica, fa scendere in campo l’estensione o il dispiegamento, ovvero: un protendersi verso il fuori. È questo lo scopo precipuo di un pezzo di scrittura? Protendersi verso un fuori-di-sé? Ma il fuori-di-sé, ovvero il fruitore, cosa riceve da quel gesto? La gestalt complessiva, che va interpretata solo nel suo insieme, o una serie di tanti piccoli elementi che vanno esaminati uno per uno e a prescindere dal fatto che poi possano più o meno concorrere alla definizione di un insieme?
Sorvoleremo, per il momento, il fatto (che non si arroga il diritto di essere incluso nella categoria del dato di fatto, ma che si auspica di poter essere incluso nel registro degli epifenomeni) che i singoli elementi (o se volete le singole strofe), in quanto figure, possano depositare sulla pagina svariati rinvii perché ciò presupporrebbe una potenza significante che non può essere ignorata. Quindi, senza concedersi il lusso di guardare dentro guardiamo solo all’oggetto complessivo.
Il sogno è quello della scrittura. La risoluzione è la castrazione.
È così che si vorrebbe.
Ed è proprio questo ciò che l’altro o gli altri dovrebbero aspettarsi da lui.
Lui chi? Il Poeta?
L’indomito, anacronista scriba che ancora persiste a usare la penna e la carta?
Il pigiatore di tasti?
Se l’altro o gli altri comprendessero che l’unica via di salvezza fosse quella di accettare la sospensione e l’incompiutezza (il disastro incombente e il tragitto della caduta che non arriva mai a toccare il suolo?) forse si potrebbe qualificare il gesto del poeta come naturale.
Ma non basterebbe.
Bisognerebbe anche accettare la riproposizione seriale di quel gesto.
Ed è così che la poesia, essendo già morta da sempre, sopravvive a se stessa: nella serialità della sua incompiutezza, nel qualificarsi come un fenomeno (anti-fenomeno o, se preferite: epifenomeno) nullificante. Nancy parlava di un “fantastico fenomeno” di un’immagine in grado di rappresentare la “presenza di questa assenza […] imago di ciò che fu prima di tutto e che dunque non fu affatto, in nessun tempo né fuori del tempo in cui nulla è” (Cfr. Fantastico fenomeno, 2009).
Un po’ come se la lingua fosse una forma (un segno, un’immagine, un’insegna luminosa sì ma intermittente) piuttosto che una sostanza. Visto che parleremo anche di contrari e di riconciliazione dei contrari, di un qualcosa che si origina e si edifica sul/dal suo contrario, poniamo che in quell’insegna luminosa le intermittenze siano al bianco e non al nero, ovvero che il messaggio pubblicitario (la lingua) sia leggibile solo in mancanza di luce (al nero), e che i lampi di luce (al bianco) quindi si assumano l’onere di decretare l’assenza del messaggio rendendolo illeggibile. La presenza della lingua si dà nella sua assenza di visibilità ma è anche vero che l’assenza della lingua si rende visibile nell’invisibilità della sua presenza. Una presenza che quindi c’è, esiste, persiste, ma non è decifrabile se non nella sua dispersione nel bianco. La presenza di questa assenza, con una leggera forzatura, si potrebbe spiegare attraverso le parole di Mallarmé, quando nella nota introduttiva al suo Coup de dés parla dei «bianchi» e di quanto risultino importanti e decisivi. Bisognerebbe citare un’intera pagina derridiana (Cfr. De la grammatologie, 1967), dove il nostro pensatore – partendo da Saussure e filtrando la differenza tra l’incoscienza del linguaggio e la spaziatura intesa come “origine della significazione” – arriva a qualificare la spaziatura come la “marca del tempo morto nella presenza del presente vivente, nella forma generale di ogni presenza”. Ma se la nostra presenza è l’assenza, quel tempo morto rappresenta il trait d’union che lega tra loro una serie di assenze. Il tempo morto è la casella vuota che permette alle tessere di spostarsi nel puzzle del testo. E quindi alla prima affermazione derridiana “Essa marca il tempo morto” ci toccherà aggiungere: facendolo divenire vivo o facendolo sembrare vivo. Proseguendo sulla falsariga dei supplementi, si potrebbe dire che la scrittura, come disastro e deriva, come la presenza di un’assenza, derivi innanzitutto dallo spazio morto (il tempo morto si ri-qualifica e ri-determina nello spazio, perché solo la loro intrallacciatura permette la costituzione di una figura), dai cosiddetti «bianchi». Perché solo in quel luogo, proprio là dove s’intersecano spazio e tempo (attraverso il tramite di un inchiostro, ideale e idealizzato, che per comodità d’esposizione definiremo simpatico, per l’appunto: «la presenza di questa assenza»), si può percepire il «non-percepito», si può dire il non-detto e lasciarlo decantare il tempo sufficiente per una degustazione diversamente funzionale che possa investire tutti e cinque i sensi. Ne converrete, questo tipo di avvento accade raramente, anzi si potrebbe dire che per il 95% dei casi rappresenti una mera utopia (compreso l’esemplare sopra esposto – fornito a solo titolo d’esempio – che ha inaugurato e qualificato la mia stessa fallacia). Verrà da sé che la massificazione dell’utopia equivalga alla fallacia e all’incompiutezza, al non-risolto. Resterebbe da precisare che per alcuni inchiostratori l’irrisolvibile rappresenti un punto d’arrivo, una sorta di fissaggio del paradosso, che sarebbe già una contraddizione in termini (se volete anche una riconciliazione dei contrari): si può fissare l’irrisolvibile?
No. Non può essere fissato.
Però può essere enunciato.
Allora la forma più plausibile della scrittura (ma se la scrittura è già di per sé una forma allora di cosa stiamo parlando?) potrebbe ridursi all’enunciazione. In linea teorica tutto può essere enunciato. Abbiamo fatto l’esempio dell’insegna luminosa enunciando l’ambiguità di un pensiero diversamente funzionale (anche disfunzionale, se volete). Pensiamo all’insegna come a un ricettacolo formato da una serie di figure che rinviano ad altre figure. E queste ad altre ancora. Sarebbe una pratica lecita enunciarne la struttura sovradeterminata.
È ciò che fece a suo tempo (1480-1544) un certo Giulio Camillo Delminio nella stesura, sempre incompiuta e quindi sempre fallace, di una sorta di Theatrum Mundi sovrastrutturato per stratificazioni di livelli e giustapposizione di figure, quelle che Delminio stesso definiva “insegne”, ovvero: “i segni delle visioni, le quali significano & non esprimono”. Proviamo a considerare, en passant, questa proposizione come un’arcaica definizione della differenza tra significato e significante. Delminio poi continuava così: “laonde non senza ragione gli antichi in su le porte di qualunque tempio tenevano, o dipinta, o scolpita, una Sphinge, con quella immagine dimostrando che delle cose di Dio non si deve se non con enigmi far pubblicamente parole” (L’idea del Theatro, 1985). Se proviamo a sostituire, senza nessuna intenzione blasfema, la parola (di) Dio con la parola (del) Poeta, il gioco è fatto. Il Poeta sarebbe colui che fa mostra di sé, pubblicamente, attraverso parole enigmatiche. Se vogliamo, l’enigma, se resta indecifrato, rappresenta l’immagine stessa dell’incompiutezza: non esprime un senso compiuto ma lascia ad intendere, per così dire, una potenza significante.
Da un altro punto di osservazione si potrebbe anche dire che l’incompiutezza rappresenti il limite di una lingua, e quindi ancora una volta la sua fallacia. Delminio, in un certo senso, risolve la questione in questo modo: “non potendo la lingua nostra giunger alla espressione di quello se non per cenni & similitudini, affinché per mezzo delle cose visibili saliamo alle invisibili”. Il cenno (il verso e non il periodo) e la similitudine (analogia e, per estensione, tutta la famiglia delle figure retoriche e grammaticali: metafora, allegoria, e se vogliamo anche il simbolo, ecc.) sono le armi del poeta, quelle armi attraverso il quale un testo può essere dotato di un sottotesto o di un ipertesto, ovvero quelle armi che consentono di lasciare a intendere il non detto.
Cosa abbiamo fatto fino a ora?
Abbiamo parlato di segni, insegne, visioni, figure, immagini, ovvero di tutto ciò che, anche se non manifestato palesemente, dovrebbe costituire il «pensiero» dell’inchiostratore, l’imprintig concettuale da cui si dipana (o si ingarbuglia) la matassa. Deleuze diceva che i concetti sono immagini di pensiero. Il compito dell’inchiostratore – per dirlo più o meno alla maniera nancyana – consiste nel pensare il pensiero di quell’immagine o, per meglio dire, avanzare verso la «venuta» di quell’immagine, protendersi verso l’immagine che viene verso di lui e concedersi il lusso di toccarla, di sentirla prossima-a-sé. Solo così, dopo averla, per così dire, posseduta può finalmente liberarla, può lasciarla andare per la sua strada e può concedersi l’ulteriore lusso di conservarne solo l’eco e lo scarto. La sentenza è chiara: “non basta vedere l’immagine, bisogna soprattutto «sentire» ciò che l’immagine non ci fa vedere”. Ne converrete, il compito dell’inchiostratore non può ridursi al semplice atto di affiancare parola a parola (o come diceva Malherbe di essere definiti manipolatori di sillabe [arrangeurs de syllabes]) per scrivere. Il suo compito sarebbe, o dovrebbe essere, quello di dire la scrittura e di fallire mentre compie il suo atto. Il suo fallimento, che rappresenta a tutti gli effetti una risoluzione, è la «marca» della sua fallacia e della sua incompiutezza. Si può dire la scrittura solo dopo essersi liberato dell’immagine del pensiero. Ed è così che si crea un concetto, lavorando sull’eco di un qualcosa che risuona e insieme si dissolve e sugli scarti che resistono all’esperienza e rinvengono, sebbene a tratti, disseminando una serie di segni che rappresentano, a tutti gli effetti, segnali di senso. Questi segnali equivalgono alle insegne delminiane. Sono figure. Quando queste figure, come direbbe Derrida, divengono «figure di figure» la scrittura diviene letteratura o, per dirlo proprio con una famosa metafora derridiana, l’istrice – chiudendosi a riccio e offrendosi all’urto, all’incidente – diviene il simbolo della poesia. Per divenire poesia si sacrifica facendosi investire e quindi decreta la sua morte. Ci consegna la presenza della poesia solo a condizione di rendersi assente.
La presenza di questa assenza, come diceva Nancy, è proprio ciò che fu prima di tutto. È assente perché non ci appartiene, se non attraverso l’immaginazione (attraverso l’azione che l’immagine esercita su di noi), attraverso il filtro di una presunta sfera sensibile che ci permetterebbe di riprodurla. Si direbbe un’assenza primigenia, un’assenza di radici, quelle radici che, essendo tanto lontane da noi, non consentono nessun tipo di radicamento.
Ed è proprio qui, in questo non-luogo costruito, idealmente, tra immagine e immaginazione, tra radice e radicamento, che si situa il nostro lavoro improduttivo. Quel lavoro che si potrebbe sistematizzare (e quindi vanificare), facendo rinvenire il fantasma batailleano, tra il limite dell’utile e l’inutilità del limite.
Porsi al limite non significa «essere limite».
Essere limite presuppone, anche e soprattutto, una predisposizione al superfluo che, amplificando il nulla di cui si nutre, rappresenterebbe il carattere predominante della poesia, il suo status, il marchio a fuoco che determina l’appartenenza a una tribù o a una famiglia.
La tribù degli inchiostratori?
“Quale utopia/ è mai stata così vera?/ pura emozione/ del precipite/ alla ricerca della sua levata (autocitazione)”.
Precipite e levata.
Pura contraddizione in termini o riconciliazione dei contrari?
Essere limite potrebbe significare anche questo. Nullificarsi mettendo in scena (levando dalla scena?) simultaneamente i contrari senza arrivare a una conclusione, o meglio ancora: abiurando qualsiasi risoluzione definitiva. Questa sarebbe, o potrebbe essere, la ragione d’esistenza della tribù degli inchiostratori, la presenza della loro assenza di fondo. Quest’assenza di fondo pretende un lettore diverso (quello che Mallarmé definiva il lettore avvertito e che Eugenio barba definiva il quarto spettatore) e, come dire, più articolato, disposto cioè a recepire la prima assenza per affiancarla alla propria assenza e per darle un senso.
È forse questo il sesto senso che si mescolava – a mo’ di crasi – al palinsesto paventato nel titolo? Il lettore semplice è anch’esso assente, ma solo perché non si rende partecipe dell’assenza dell’autore. Se il lettore articolato è diversamente funzionale (serve all’autore come specchio in cui riflettersi) il lettore semplice invece è semplicemente disfunzionale.
Riporto un passo di Giuseppe Zuccarino (da La scrittura impossibile, 1995): “[…] esiste una semplice lettura, oppure essa è inevitabilmente complicata da una serie di problemi e assillata da doppi fantasmatici? L’ipotesi che saremmo inclini ad avanzare è appunto quella che – se non si vuole concepire la lettura come un processo puramente subìto, che susciti in chi vi si dedica una sorta di adesione incondizionata, o magari uno stato quasi ipnotico e sonnambolico di trance – si dovrà necessariamente pensare ad una diversa e più attiva forma di coinvolgimento nelle parole scritte”. È questa la domanda che dovremmo porci. Vogliamo studiare un testo e affrontare l’ostacolo, spesso insormontabile, di un senso ulteriore nascosto nel primo senso oppure ci deve bastare la semplice lettura, per così dire, distaccata? E ancora, se l’autore in questione – così come affermava Blanchot – “riesce solo fallendo”, non dovremmo forse a nostra volta fallire? La scrittura è fallace. Il lettore più attento può coglierne la fallacia e rendersi a sua volta fallace nell’interpretarla o semplicemente mettendo sui piatti della bilancia la possibilità di una impossibilità di fondo. La serie dei significanti è inesauribile perché ognuno di essi rinvia ad infiniti altri, come ci ricordava spesso Derrida.
Conversazione da solo
ci sono delle cose che sono
di fronte a questa pagina aperta
collegate ad altre che sono dietro le spalle
ci sono delle cose di fronte a questa pagina aperta
che sono collegate
alle cose che mancano
le cose come le cose
al centro c’è il tuo posto
al tuo posto non c’è nessuno
(Corrado Costa, da Le nostre posizioni)
Ci sono delle cose che sono sopra le cose. Sono ad esse sovrapposte. Che siano scritte o incise è una cosa che non cambia i termini della questione, qualora ci fosse davvero una questione, qualora fosse necessario o urgente dirimerla. Le prime cose sono invisibili, vivono o sopravvivono nelle trame, negli interstizi invisibili della materia che compone la “pagina aperta”, nei punti infinitesimali che determinano la grammatura; sono in un certo senso simulacri che conservano e preservano una traccia ■ senza mostrarla. Le seconde cose, sempre più opinabili o (in)utili (con o senza limiti che determino una continuità o una contiguità), diventano visibili nel momento in cui un qualsiasi inchiostratore o un qualsiasi pigiatore di tasti compie il suo gesto, a tutti gli effetti, irriverente, forse perché incosciente dell’effetto che il suo gesto produrrà. Si pensi alla radice della parola irriverente e alle sue parentele etimologiche con l’irrilevanza (irrisorio, marginale, insignificante, ininfluente). È curioso notare come entrambi i termini siano derivazioni dal loro contrario: reverēri (avere riguardo) per irriverente e relevåre (determinante, importante, significante) per irrilevante, e di come entrambi, per così dire, si facciano scudo con un prefisso privativo ■ (in).
È un po’ come dire che il gesto di inchiostrare si fondi sul suo contrario. E anche questa è una forma o, se preferite, un’accezione della fatidica riconciliazione dei contrari. Quindi il suo radicamento ■ sulla carta potrebbe corrispondere anche a una dispersione ■ (la confusione originaria di Babel è a tutti gli effetti una dispersione, come vedremo meglio più avanti), o comunque a un’inversione ■ di senso: dalla confusione di una lingua unica, impronunciabile e incomprensibile, alla suddivisione in mille e più lingue, ognuna univoca e radicata in un territorio, ma che per essere comprese, e quindi deterritorializzate, necessitano di una traduzione (sorvoliamo sulla questione della traduzione come delocazione e trasformazione dei segni per non appesantire troppo il discorso).
Gli antichi sostenevano che relevåre corrispondeva allo sporgere in fuori. Praticamente, con buona pace di Heidegger e Derrida, una «gettata»■. Quindi irrevĕrens potrebbe corrispondere a uno sporgere in dentro (mise en abyme, invaginazione?). Ci troviamo di fronte a un doppio movimento (un vero e proprio double bind ■, in tutte le accezioni che volete, dal doppio legame, al doppio colpo, alla doppia colpa, alla doppia e reversibile obbligazione, ecc.), il primo estensivo ■, il secondo intensivo.
Pensiamo quindi al nostro inchiostro come una cosa irriverente e insieme irrilevante, come una cosa che si fonda sul suo contrario e che quindi non dice ciò che vorrebbe dire o comunque lo lascia solo a intendere, come una cosa votata alla sua dispersione. In tale ottica come dovremmo comportarci? In quali modalità potremmo pensare (pesare, soppesare) la sua pensabilità?
Forse non è possibile rispondere a tali interrogazioni. L’unica cosa possibile sarebbe quella di esplorare il registro dei possibili, o comunque, in via del tutto ipotetica e indimostrabile (l’ipotesi trasforma i possibili in eventuali, per quanto improbabili essi possano risultare), una piccola parte di tutte quelle stringhe (sappiamo tutti che il significato di string è corda, e che la corda equivale, semanticamente, a un «legame») che compongono il quanto della scrittura. Le stringhe vibrano in un doppio movimento di attrazione e repulsione, e ciò conferisce al legame il double bind di cui prima. Le stringhe sono in uno stato di perenne tensione. Da ciò deriverebbe il carattere estensivo e mobile della scrittura. Estensivo perché originariamente confusionario, e mobile perché costretto ad avanzare, curva dopo curva, per rigenerarsi.
Perché poi, al di là della nullificazione e dell’incompiutezza, una scrittura, per definirsi tale, deve comunque mettere al lavoro una serie di stati tensivi. Lo stesso Nietzsche diceva che “si deve saper danzare con la penna”. La danza è movimento, ma anche spazializzazione (ricordate i «bianchi»?). Abbiamo quindi individuato i due caratteri che dovrebbe possedere la scrittura, un movimento interno che veicoli una certa mobilità (da qui al trasferimento di energia da un uno a un altro il passo è lungo, ma se dovesse accadere non sarebbe cosa da disdegnare) e un movimento esterno corrispondente alla disposizione (dispersione?) grafica del testo sulla fatidica “pagina aperta”.
La pagina aperta è il corpo e l’inchiostro è ciò che distingue un corpo dall’altro.
Come se carta e inchiostro potessero trasformarsi in derma e sangue. Il pennino diventa allora ago o bisturi per incidere il derma e per rapportarsi col sangue. Il sangue prende il posto dell’inchiostro e può quindi parlare di morte o far parlare la morte. Il sangue parla della morte della scrittura o fa parlare la scrittura della sua stessa morte, anche in senso blanchotiano della scrittura come «disastro» e come krisis, se vogliamo. Beninteso, il regime non è improduttivo. C’è anzi un surplus di produzione, perché la scrittura che parla della sua stessa morte, nell’atto di farlo, rinnova la sua esistenza, perpetua il suo ciclo. Un ciclo inesauribile. Il rapporto tra morte e scrittura scivola sempre sui piani di un double bind, in cui ognuno dei due fattori si ciba dell’altro e viceversa. Ognuno dei due elementi trascende l’altro per rigenerarsi. Risulterà chiaro quindi che la morte della scrittura equivalga al suo rimanere in vita (l’ennesima riconciliazione dei contrari). Il paradosso è solo apparente. Come se crisi (krísis) e crasi (kràsis) non appartenessero alla stessa famiglia etimologica. Come se la crisi della scrittura (il passaggio da un sistema monosignificante a un sistema polisignificante non poteva che generare una crisi che, in un certo senso, corrispondeva alla necessità di trovare nuovi paradigmi o archetipi) e la scrittura della crisi (da Blanchot in poi il disastro viene assunto a paradigma, diviene il modello a cui riferirsi) non fossero paragonabili a una crasi (kràsis, mistura, mescolamento). La crisi della scrittura e la scrittura della crisi derivano proprio da questa mistura, da questa confusione.
Per definire la radice, l’origine di questa confusione dobbiamo ricorrere a Babele, a quella mitica torre (la cui invenzione fu forse desunta da una più antica ziggurat babilonese; del resto Babel e Babilonia sono praticamente sinonimi) in cui avviene la contaminazione delle lingue. Al di là del gioco derridiano tra des tours (delle torri) e détours (giri, curve), ciò che conta è che a ogni giro, a ogni curva si perdevano parti della propria lingua e si assimilavano parti di un’altra lingua. E così via, nella serialità della mescolanza, si arrivava ad una sorta di lingua anti-universale che non poteva essere compresa da nessuno. Una lingua fallace e incompiuta quindi. Così come la stessa torre resterà incompiuta. È la stessa Genesi a far corrispondere Babel con confusione. Per questo Derrida, nei giri delle sue perifrasi (Cfr. Des tours de Babel, 2008), confrontando diverse traduzioni (decostruendo l’univocità del segno originario con figure diversamente funzionali e più adattabili al contemporaneo), trasforma lingua e lingue in labbro e labbra, inaugurando in un certo senso il passaggio dalla scrittura alla voce o comunque l’equivalenza dei due elementi su uno stesso piano, come se dovessero, per forza di cose, coabitare nella stessa dimora ontologica e fenomenologica. Perché le labbra rappresentano l’organo deputato alla voce. Perché il labbro, al maschile, ha due plurali: labbri (sempre al maschile) e labbra (al femminile). Se il secondo si rivolge solo alla parte anatomica, il primo si può usare sia per la delimitazione di una ferita o di una fenditura, sia per evidenziare i confini di un perimetro o di un oggetto. Se si parla di confini, per esasperare la nostra dimensione complicativa, ci toccherà far rinvenire i margini. E qui ritorniamo sia alla “pagina aperta” che all’«essere limite». La scrittura viaggia quindi in simbiosi con l’oralità (inutile ricordare che la scrittura nasce orale; non è questo che qui ci interessa). Si può scrivere Babel, ma se c’è anche una voce che urla Babel ecco che qualcosa cambia nella ricezione del messaggio. La semplice lettura lascia il passo a qualcosa di più articolato o comunque permette l’entrata in scena dell’ascolto.
Ricordate l’auspicio di Zuccarino: “si dovrà necessariamente pensare ad una diversa e più attiva forma di coinvolgimento nelle parole scritte”. Porsi all’ascolto potrebbe rappresentare un’accezione di questa proposizione. Certo, bisognerebbe indagare almeno i registri della propagazione e della risonanza. Cosa che non è fattibile in questo contesto.
Proviamo adesso a raggruppare tutti quei piccoli quadrati neri che abbiamo disseminato nell’ultima parte del testo. Sono neri perché il nero rappresenta il «canone» dell’inchiostro, la sua riconoscibilità e il suo inquadramento. Sono il mezzo (non un tramite ma un segno) per evidenziare una serie di quelle che Nancy avrebbe definito «medaglie verbali». Elenchiamole, nell’ordine in cui si sono impresse (inchiostrate) su questa nostra pagina digitale: traccia, privazione, radicamento, dispersione, inversione, gettata, double bind, estensione…
Ognuna di queste medaglie verbali rappresenta un’impennata, una sorta di innalzamento del livello del testo, una delocazione dal significato al significante (ma anche il contrario perché il processo, a seconda del punto di vista [o punto di partenza dal quale si dipana l’approccio concettuale e/o filosofico] è assolutamente reversibile), una stringa volta ad evidenziare la possibilità che il discorso si diriga altrove. A solo livello nozionistico, è doveroso notare come impennare (sebbene sia un termine antico e raro) significasse l’atto (il nostro fatidico gesto dell’inchiostratore) di intingere il pennino nell’inchiostro e, cose ben più importanti, quanto inchiostro il pennino può assorbire ogni volta che s’intinge e quante parole si possono scrivere con quella quantità di inchiostro assorbita. La portata massima del pennino e la quantità di parole che possono essere gettate. Qualora non fosse chiaro si (s)parla di autonomia e di peso (sarebbe più consono estendere il concetto verso lo spessore) della scrittura. Ne converrete che l’intero discorso rischia sempre più di indirizzarsi verso una dimensione complicativa. Una scrittura non può essere autonoma perché deriva sempre da un’altra scrittura che l’ha preceduta. Non c’è cambio di paradigma che tenga il passo coi tempi. E il peso, letteralmente inteso – a partire dalle tavolette d’argilla sumere, passando attraverso i papiri egiziani (ottenuti facendo essiccare i filamenti interni di una pianta) e le pergamene (ricavate da pelle di pecora e con le quali furono scritti i primi codici), per arrivare alla carta, più o meno moderna e per finire con la pagina digitale (che non esiste fisicamente) – nel corso del tempo ha progressivamente perso spessore conclamando lo status della sua stessa dispersione. Per sopperire a questa mancanza alcuni sono ricorsi alla voce. Una scrittura detta (diktata), e quindi quantificata, può far traslare il senso da un significante a un altro significante con la sola intonazione, con la portata della sua voce che equivale, semanticamente, alla portata del pennino (così tanto per ritornare a quanto già detto sull’equivalenza tra scrittura e oralità). Così il flusso di parole che possono essere dette tra un respiro e l’altro corrisponderebbe all’intervallo tra due assorbimenti d’inchiostro del pennino nel calamaio. Calamaio (contenitore, deposito, ricettacolo), un’altra parola etimologicamente multipla e la cui potenza significante ci permette di percorrere l’asse Platone-Derrida ricorrendo non solo alla figura del porta-impronte ma anche idealizzando una sorta di terra-madre (nutrice) da cui attingere (in cui intingere?) linfa vitale. Alcuni fanno derivare la parola calamaio da kalamrk (in copto significa calamaro) per via del liquido nero in esso contenuto. Non vorrei ricorrere sempre a Nancy, ma ciò che conta nella scrittura è che “bisogna lasciar correre l’animale nel discorso” (Cfr.Corpus, 1995). Il concetto viene argomentato nella mia ultima produzione scritta a quattro mani con Sonia Caporossi: Le nostre (de)posizioni (in fase di pubblicazione per Bonanno Editore) prendendo come riferimento, tra le varie animalìe, le lepri di Mariangela Guatteri e Corrado Costa, il gallo da combattimento di Gian Ruggero Manzoni, l’ornitorinco di Lorenzo Mari, ma sviluppando anche altre tipologie di animalìe non propriamente letterali e riconducibili ad una sorta di status fenomenologico che investe la struttura significante di uno spessore a metà tra il psicologico e il patologico che, se a prima vista, potrebbe sembrare intriso di una crudeltà idealizzata a modus vivendi, non fa altro che determinare e qualificare l’ordine del discorso. Quello che intendevo, in linea generale, verte proprio su un ordine del discorso mobile e tensivo e la cui animalìa di fondo rappresenta il tramite per il dispiegamento di un concetto che altri non è, ricordando Deleuze, che un ‘immagine di pensiero, una figura che si abbandona nella figura di un qualcosa (o di un qualcuno) che corre all’inseguimento di se stessa o, per meglio dire, che insegue l’immagine di un qualcosa che corre verso la figura di un qualcosa che corre. Non è un gioco di specchi, né riflettente né auto-riflessivo, è un concetto che pretende il suo dispiegamento improduttivo. Ma la domanda è un’altra. Cosa accade quando l’animale invece di correre nel discorso si presenta a noi («viene» a noi) ancor prima che il concetto si manifesti imprimendosi su un supporto? L’animale è nella chōra (calamaio) da cui dobbiamo incamerare l’inchiostro, ci precede temporalmente, è il nostro avo che ci trasmette l’arte da sviluppare informandoci sul carattere originario del mezzo che ci apprestiamo ad usare e di cui sicuramente abuseremo trasferendo una serie di segni. Allora ciò che conta non è solo il primo animale, il serbatoio (calamaio) ma, anche e soprattutto, il supporto che ci permette di svolgere il nostro compito. Chi ci assicura che il rosso delle grotte di Lascaux non fosse ricavato anche da sangue animale? E le pergamene che venivano ricavate da pelle di pecora o di capra? Il lapis di piuma non veniva forse divelto dal derma di un uccello? Ci sono degli animali che si sono sacrificati (ricordate l’istrice derridiano?) per permetterci di lasciar correre il nostro nuovo animale nel discorso, ma……………………… (incompiuto, e quindi: fallace).
ALESSANDRA GRECO
da NT
Ci sono aperture immediate che lasciano passare con facilità altre porte vagliano nient‘altro che fili
sottili come la seta i più piccoli cambiamenti
e questa continuazione
I commenti a questo post sono chiusi


Grazie Giorgiomaria per questo “corposo” lavoro di raccolta di voci che stai facendo, e grazie per farlo su NI.
Tutti i discorsi che si fanno oggi sulla poesia sembrano, alla fin fine, discorsi sulla libertà, sulla troppa libertà che rende(rebbe) il poeta schiavo e il lettore disorientato (ci si incontra – più o meno virtualmente – per la situazione, per dire: “ancora ci siamo e in qualche modo ci riconosciamo”). Ma la necessità della scrittura poetica (non la necessità dello scrivere in sé) è insindacabile: come il vibrare della natura così il grido dello spirito. E nessun discorso ozioso sulla crisi della parola potrà mai inficiare il valore del gesto autentico di chi, nonostante tutto, si prodiga con tutto sé stesso per produrre senso e bellezza e una, seppur minima, speranza per sé e per il mondo. Se poi vogliamo dire che si tratta di credere o non credere, allora chi non crede ha già perso in partenza e non dovrebbe vergare un solo emistichio.