«Avrai i miei occhi», di Nicoletta Vallorani
Da oltre un decennio, il fenomeno letterario e editoriale è «macroscopico» (per riprendere Carla Benedetti): (auto)biografie, reportage, memorie, cronache, inchieste, testimonianze, basta siano storie vere, fattuali, reali, ed esibiscano pegni documentari della loro autenticità, si rivendichino vissute, esperite. Io c’ero. Io so. Eppure, a dire qualcosa sul mondo, qualcosa di importante e di altrettanto vero, è anche un’altra letteratura, quella in cui predominano immaginario, invenzione, creazione, fantasia. Ne è una prova bella e convincente il recente romanzo di Nicoletta Vallorani, Avrai i miei occhi, una forte e cupissima distopia, ascrivibile alla letteratura di fantascienza più che al noir (anche se ci sono un detective e un intrigo criminale), entrambi generi comunque ormai sdoganati da presunta “inferiorità”. Avrai i miei occhi racconta storie di segregazione sociale, in una Milano soffocata da nubi pulviscolari, divisa in zone da alte mura, nelle cui strade si incrociano ragazzini stracciati e mucchi di cadaveri. Di donne. Perché Avrai i miei occhi racconta soprattutto la violenza sul corpo della donna, sia essa umana, cavia, clone, replicante, cyborg: stessi soprusi, stessa sofferenza. Nicoletta Vallorani, primo premio Urania femminile per Il cuore finto di DR (1992), da allora ha continuato a scrivere fantascienza, noir, fantasy, e romanzi che amo definire femministi, al cui centro stanno tormentate storie di donne, oggetto di rapporti di oppressione, costrette in ruoli sociali imposti con la forza dell’ordine simbolico e fisico.
Nicoletta Vallorani ha gentilmente accettato di rispondere alle mie domande.
S.C. Avrai i miei occhi esce per i tipi di Zona42, che ritengono «la fantascienza uno degli strumenti più utili a riflettere sulla contemporaneità». Non so se definiresti il tuo romanzo fantascientifico, né se ti situi anche tu nella medesima prospettiva. Ti chiederei anche com’è cambiato, se è cambiato, il tuo rapporto con il genere, in quasi trent’anni dal tuo debutto.
Vallorani. La premessa necessaria è che non ho una passione per le etichette: le uso funzionalmente a uno scopo, spesso di natura critica oppure organizzativa. Ma non ritengo siano scolpite nella pietra: al contrario, sono categorie instabili, che per funzionare vanno revisionate nel tempo. L’etichetta “fantascienza” ha cambiato significato molte volte nella storia del genere letterario, senza perdere alcune specificità importanti e definitorie, ma anche dimostrando una duttilità rara, soprattutto a partire dagli anni ’70 in avanti. Dunque, per farla breve: sì, Avrai i miei occhi è fantascienza, a tutti gli effetti, come lo sono i romanzi pubblicati da Zona42, e che probabilmente altri editori di fantascienza italiani considererebbero fortemente apocrifi. E sì, ho lavorato al romanzo cercando di fare in modo che fantascienza fosse, per rispetto al lettore cui si rivolgeva e per il desiderio di costruire un ponte, attraverso il quale raggiungere sponde di lettori che, per esempio, di donne cose sentono parlar poco. Ma questi stessi lettori leggono di “alieni” da innumerevoli anni, dunque perché non introdurre un discorso sul femminile, rispettando però alcune formule? La scrittura è talento e mestiere. La seconda parte della frase non si può dimenticare, per arroganza o per ignoranza. E così veniamo alla seconda domanda: che cosa è cambiato? Penso di essere cresciuta io come scrittrice, navigando in acque diverse e cercando di imparare da chi era più bravo di me. E penso che sia cambiato il genere in Italia. O che stia cambiando. Zona42 ha fatto da apripista con scrittrici e scrittori stranieri “difficili”. Per questo loro sono una casa “giusta” per il mio romanzo. Ma penso che non ci fermeremo qui. Sono fiduciosa. I fantascientifici italiani sono lettori esigenti e critici, che non accettano di essere truffati. Si può non essere d’accordo col loro giudizio, ma esso è sempre documentato. E secondo me è un bene. Scrivere è una attività dialogica, e dialogare col proprio ombelico non è sano per nessuno scrittore.
S.C. Nel romanzo, mi hanno colpito moltissimo tre aspetti, correlati, certo, ma sui quali ti chiederei di esprimenti distintamente: l’ambientazione in una Milano riconoscibile ma plumbea, disperata; la violenza sulla donna, ancora più grave di oggi nel futuro in cui si svolge la storia; i rapporti di classe brutali su cui si profetizza strutturarsi una società di esclusione e di sorveglianza
Vallorani. Sono i tre fili tematici principali, deliberatamente ma anche in modo naturale, nel senso che si connettono senza forzature. Per prima, la città, ricostruita a partire da quella che è e che conosco, ma in una proiezione futura che ne enfatizza l’aspetto postindustriale: a parte l’omaggio all’iconografia urbana del cyberpunk, l’idea centrale era quella di raffigurare una dimensione architettonica e topografica nella quale ogni organicità e ogni coerenza fossero perdute. Non vi è luce in questa Milano, e l’unico collante è il pulviscolo che ne invade l’aria. Le architetture sono inaffiancabili, i paesaggi urbani per nulla coesi. Non è la città ideale degli utopisti, ma neanche il suo esatto contrario: le topografie concedono inattese solidarietà, tipo San Vittore, che da carcere si è fatto luogo-famiglia, e Rogoredo, che da stazione diventa rifugio di Ariel. Poi ci sono le donne, o, per meglio dire, le cavie. Qui l’idea – che è centrale nel romanzo, almeno nelle mie intenzioni – era quella di mostrare come il corpo femminile violato smetta di essere, nelle intenzioni di chi lo viola, una cosa organica. Esso diventa una cosa, in quanto tale subumana, e in quanto tale idonea a ogni genere di tortura. Con uno slittamento concettuale appena percepibile, ho usato una scienza consueta (anche se non ancora così sviluppata) per conferire a queste cose un’anima, e per ragionare un po’ su come sia sfuggente questa autorizzazione alla violenza contro le donne. Mi premeva molto parlarne. Spero di esserci riuscita. Infine, i rapporti sociali: si trattava di descrivere una polis che è andata in pezzi. Non c’è ombra di comunità in Avrai i miei occhi. Ci sono tentativi di solidarietà tra naufraghi, ma, se sopravvive l’amicizia, la nozione di comunità è andata completamente perduta. Quindi, alla fine dei conti, tutti e tre i filoni tematici girano intorno alla nozione di corpo come entità coesa, fatta di una superficie visibile e di una sostanza. Tutti hanno a che fare con la perdita di coesione che rischiamo di sperimentare in tutti e tre i campi. E tutti e tre parlano di forme di resistenza a questo processo.
S.C. Come ha osservato anche Valerio Evangelisti, nella sua recensione sulla Stampa (http://www.zona42.it/wordpress/avrai-i-miei-occhi-recensioni-3-tuttolibri/), la narrazione poco si conforma ai codici del genere fantascienza. Noto per esempio, l’uso alterno di prima e seconda persona, riflessioni introspettive che sospendono il ritmo dell’azione, un fraseggiare nervoso, descrizioni evocative. Insomma, un alto tasso di letterarietà, una scrittura lavorata. Che comunque coinvolge molto il lettore, lo tira dentro un mondo angoscioso.
Vallorani. Non so dire. Nel senso: ho sempre pensato che la scrittura sia scrittura, in qualunque genere essa scelga di declinarsi. Io so bene che potrei scrivere in modi più semplici, e probabilmente avrei anche maggiore successo, non so. Ma penso che la letteratura debba avere come suo requisito fondamentale il rispetto del valore delle parole, della musica attraverso la quale esse si compongono, del significato che si portano appresso, e che muta a seconda di come le combiniamo. Dunque non mi sono posta il problema. Mi piace molto che tu dica che il lettore si sente tirato dentro. È quello che voglio. La lettura deve essere esperienza, altrimenti non è nulla.
S.C. Tanta violenza, tanta cupezza, nel mondo di Avrai i miei occhi. Ci vedi davvero proiettati in un futuro così disperato?
Vallorani. Non faccio previsioni. Scrivo visioni, o almeno spero. Questa è una possibile visione, che mi spaventa molto, ma che c’è. Non vuol dire che accada. Non sono un profeta. E se devo dire quel che penso io, ecco, ritengo che Milano – persino ora che somiglia di fatto alla Città Murata – abbia moltissime chance di avere un futuro diversissimo da quello che descrivo. Però davvero penso che sia irrilevante. Questa è Milano come potrebbe essere, non come sarà. Il futuro lo costruiamo noi come comunità, non lo anticipano gli scrittori.

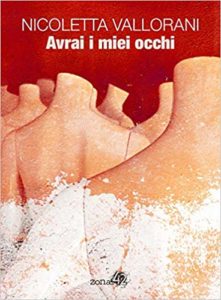

Non ho ancora letto il libro di Nicoletta, ma mi fido ciecamente! ;-)