Da «Il male in corpo»
di Marisa Fasanella
[Pubblichiamo una pagina dal romanzo di Marisa Fasanella Il male in corpo, Castelvecchi 2019].
***
Mercoledì, 18 maggio. La stanza della memoria
Alle sei del mattino, nella clinica dormono tutti. L’infermiera veglia sul suo sonno, seduta sul letto è la sua ombra. È allarmata come un faro, va avanti e indietro e cerca il cellulare.
Svuoto gli armadi e mi porto via i vestiti con tutte le grucce: non c’è tempo. Le guardie chiamano il direttore e l’infermiera grida che non posso portarmelo via senza prima parlare con lui. Le valigie sono spalancate, piego ogni cosa con cura. Poi sono chiuse, sono gonfie come barili, sono pronte. Alzo mio padre e lo siedo sulla carrozzina: guarda fuori dalla finestra e non cede alla mia voce né ai miei sguardi. Frugo nel legno dei cassetti, nell’armadio, apro ogni pertugio, sotto il materasso nelle pieghe dei cuscini, osservo le cuciture con cura. Guardo persino dietro i quadri appesi alle pareti, dietro lo specchio, ma pesa come un morto. «Mi aiuti, non se ne stia lì impalata» grido alla guardia. Lo depositiamo sul pavimento e dietro c’è un vuoto, una nicchia, ci sono i suoi disegni arrotolati e chiusi in una federa. L’infermiera ha trovato il cellulare e si allontana, la fermo.
«A chi sta chiamando?» chiedo.
«A nessuno», e sceglie una delle tasche del camice per liberarsi le mani.
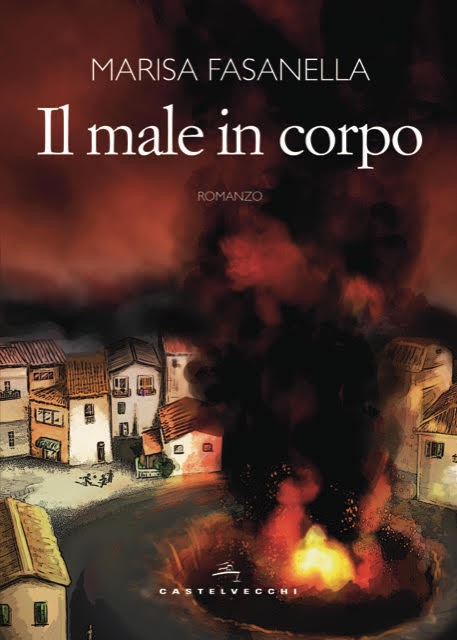
Mio padre trema, si aggrappa alle mani dell’infermiera come un naufrago. Gli infilo la giacca e gli infilo i pantaloni sul pigiama, gli copro la testa col cappello e le mani con i guanti. Esco nel corridoio, trattengo le lacrime, nascondo gli occhi dietro un paio di occhiali scuri. L’uomo di paglia allunga il passo sul viale, si passa le mani nei capelli. L’ho chiamato. Gli ho chiesto di venire. All’infermiera, ieri, è sfuggito il suo nome.
Scompaio dietro una colonna e aspetto: parla con l’infermiera, gesticola, chiede di me, dei disegni, del disordine. Abbraccia mio padre, gli sussurra qualcosa nell’orecchio, spiana le sue rughe.
Con le punte delle dita accarezzo i disegni: la carta è ruvida, strati di polvere mi separano dal tratto della matita. Perché non erano con gli altri?
Il direttore della clinica ha ceduto all’uomo di paglia e ci lascia andar via. Le mani di mio padre si agitano e la sua testa ciondola e digrigna i denti e grida e l’infermiera dice: «Arrivederci!».
I facchini dispongono la sua vita nel bagagliaio della station-wagon di Fabio: è di colore grigio con i sedili reclinabili e il tettuccio apribile, non ha più la vecchia cabriolet.
Mio padre ha gli occhi stretti e si lascia trasportare sulla sedia a rotelle e sale sull’auto e segue con lo sguardo il dito di Fabio che gli indica il cielo. L’infermiera si sporge dalla portiera e ripete ancora quella parola: «Arrivederci!». Guardo la clinica fino a quando non svoltiamo in una piazza e ce la lasciamo alle spalle.
Nella corte solo qualche gatto randagio, la attraversiamo e parcheggiamo sotto le finestre, nessuno bada a noi. Fabio lo solleva, ha il peso di una creatura, i farmaci dell’assenza lo hanno risucchiato. Lo siede sulla carrozzella e lo trasporta all’ascensore. C’è solo il mio appartamento e la scala che sale in soffitta e l’ascensore che si ferma al piano e guardo la cabina salire e mi affanno e lo guido nella casa. Abiterà la stanza degli ospiti, è di fianco alla mia e ha il bagno in camera. Rebecca e Cecco hanno dormito qui, ma in un’altra vita. Vado avanti e indietro, apro l’armadio, i cassetti, rimetto ordine nella vita che pesa nei cartoni e nelle valigie, rifaccio il letto. Il signor B non segue il mio periplo, si acciambella sulle ginocchia ossute e lo tiene caldo, lecca le sue mani artritiche.
L’uomo di paglia apre il frigo e scuote la testa: «Vado a fare la spesa, per farti perdonare mi inviterai a cena. Cucinerò io, naturalmente».
Non lo fermo, lo guardo dalla finestra, sale in auto, scompare. L’uomo di paglia conosce l’infermiera. L’uomo di paglia ha sempre saputo dove trovare mio padre. L’uomo di paglia legge le sue labbra.
Nessuno aveva pensato alla sua lingua, dopo l’incidente, la tata aveva curato con le sue erbe quello che sembrava il morso di un cinghiale, ma non era un morso. Maria Schiavone, dopo la morte di Margherita, era andata a trovarlo, la sua lingua era sporta dalla bocca come la bava di una lumaca e ne mancava un pezzo. L’aveva riferito alla tata quando era tornata, me lo ricordo come fosse oggi, e la tata si era segnata la fronte e aveva chiuso le finestre come per un nuovo lutto.
L’uomo di paglia ci proteggerà, padre: ha dato lavoro all’orfana di Margherita, l’ha allontanata dalla verità, ha bruciato l’archivio della fabbrica per non permetterle di frugare tra le vecchie carte. Custodivano la firma di Mimì Ferraro? Allunga le mani sulle ruote della carrozzella e si avvicina alla finestra, guarda attraverso le tende i tetti delle case e una forma di azzurro che forse è il cielo. La barba di un giorno cresce spaiata sul viso rinsecchito, sono peli bianchi distanti l’uno dall’altro, spoglio le finestre. Che succede, padre? Sono un animale notturno, solitario, ma sto guardando il cielo.
Mi siedo sul divano, prendo i disegni dalla borsa e li apro, la carta è ruvida, liscio i fogli a uno a uno, guardo con attenzione: gli agnelli camminano in coppia, ma su righi diversi, il caprone li guida. Gli altri disegni, quelli che si sono portati via, erano solo pecore smarrite, scancellate. Si alza, all’improvviso, e cammina sbilanciato in avanti, si ferma davanti alla libreria, guarda gli scaffali, si volta e i suoi occhi sono sguardo. Un attimo dopo trema, muove la testa, faccio appena in tempo a metterlo seduto e svolta gli occhi. Preparo una fiala di Valium e gliela inietto. Va tutto bene: parlo agli occhi sbarrati, alle pupille ferme. L’uomo di paglia avrà cura di noi, padre, quelli là fuori si fidano ancora di lui, è il custode della tua memoria. Massimo era uno dei tuoi agnelli? Se n’è andato, padre, è morto. Hanno ucciso anche Margherita. Non può ascoltarmi, il Valium lo ha fatto suo.
Raccolgo i disegni, li chiudo in una cartella, li affido alla prima vita, nella stanza della memoria. La porta ha la consistenza del muro, dello stesso colore bianco delle pareti, nessuno è mai entrato in quella stanza.

