Discorrere di case
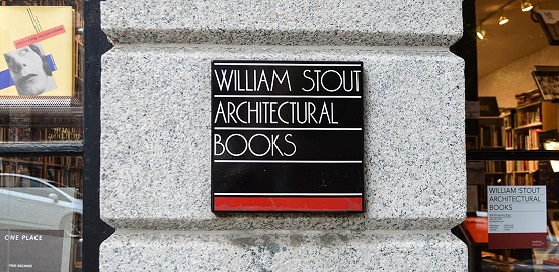 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
La prima volta che andrò a San Francisco so già che passerò un’intera giornata a perdermi fra i corridoi e gli scaffali della William Stout Architectural Books, alla ricerca di libri introvabili, di tavole misteriose, di scoperte inattese: architettura e libri in un solo luogo, per me praticamente il nirvana. Testi critici, disegni, corrispondenza, tutto il pensiero e l’immaginario dell’architettura mondiale, con la malcelata speranza di trovarci persino uno dei miei libelli, mai tradotti in inglese. O magari ce lo porterò io per poi abbandonarlo su qualche pigna di tomi, per il puro piacere di sapere d’essere in buona compagnia.
E invece so che anche quest’anno, come al solito, alla Biennale di architettura di Venezia non ci andrò, nonostante sia a poche ore da casa. Ogni volta accampo scuse implausibili, ogni volta trovo una ragione per non passare. Ciò fa di me un pessimo architetto, lo so. La Biennale è come una tassa, inderogabile, anche solo per avere argomenti di discussione se si incontra qualche collega. La mia fortuna è che, per quanto ancora iscritto all’Ordine, nei fatti sono visto e riconosciuto come scrittore. Posso permettermelo, insomma, di non andarci. Ma io alla Biennale non ci andavo neppure quando per lavoro disegnavo, discutevo con i tecnici comunali o m’infangavo le scarpe nei cantieri. Se poi penso alla particolarità di quest’anno, due donne che curano la mostra e, fra gli altri, una cara amica, Laura Peretti, che espone il suo lavoro di rigenerazione del Corviale, so che mi sto perdendo qualcosa di interessante. È un problema mio, ben inteso, non della Biennale. Quelle poche volte che mi ritrovo dentro una mostra d’architettura – che sia a Milano, Londra, New York – non ostante sia argomento che mi appassiona e che reputo fondamentale per tutti noi, quando ne esco, quasi vergognandomene mi tocca ammettere a me stesso, rosso in volto, che le mostre di architettura in definitiva, diciamocelo, mi annoiano.

Perché, inutile negarlo, quello che andiamo a vedere non è l’architettura ma un suo vago simulacro. Manca l’esperienza sensoriale dello spazio, del percorso, dei materiali, dello scambio simbolico. È come una mostra d’arte che al posto delle opere espone le recensioni dei critici o una retrospettiva cinematografica che esibisce le sceneggiature e qualche rara fotografia del set al posto di proiettare i film. Una noia mortale. Ci si sente truffati, in un certo senso.
Non è mica colpa dei curatori, ben inteso, il difetto sta nel manico e non c’è soluzione. Ogni mostra di architettura è obbligata ad appoggiarsi ad altre discipline per raccontarsi – cinema, fotografia, allestimento, etc. -, e l’architettura diventa l’intangibile buco della ciambella, la grande assente. Delle rare Biennali veneziane che ho visitato, a ripensarci, ricordo con emozione il padiglione del Venezuela di Carlo Scarpa, chiuso e abbandonato, piuttosto che le declinazioni del tema voluto dai curatori del caso e realizzate dagli architetti invitati, che sembrano più vicine all’arte contemporanea che alla architettura stessa.
C’è una frase, attribuita di volta in volta a qualcuno di diverso (fra questi Frank Zappa) che dice: “Scrivere di musica è come ballare di architettura”. Non ha senso. Se non si fa esperienza della musica non la si può capire per davvero. Le emozioni che fa scaturire sono possibili solo ascoltandola. Altrettanto è con l’architettura. Fu Bruno Zevi, nel suo imprescindibile Saper vedere l’architettura, a spiegarci che l’essenza dell’architettura sta nel suo essere spazio attraversabile, percepibile con tutti i sensi. Fregi, modanature, simmetrie, disegno, ordini, facciate, sono tutte cose che vengono dopo. L’architettura è innanzitutto spazio. E non ci sarà mai fotografia che potrà restituirmi l’esperienza emotiva che posso vivere attraversando un’opera di Hans Scharoun o di Luis Barragan. L’elemento fondamentale che definisce l’architettura è proprio quello che nessuna mostra potrà mai restituirci: il rapporto di scala fra l’essere vivente e lo spazio.
Lo spazio architettonico è quello che permette a un vuoto di diventare luogo. Di renderlo, cioè abitabile. Le parole, per uno scrittore, sono importanti. “Abitare” viene da Habere, avere consuetudine in un (e di un) luogo. Abitare è un’abitudine. Ma, attenzione, anche “Abito” ha la stessa origine etimologica: Habere, avere con noi, portarci dietro, come una disposizione dell’animo. In pratica l’abitazione dovrebbe essere come l’abito di una persona, fatta su misura.

Non a caso si raccontano spesso aneddoti feroci sul rapporto fra architetti e committenti. Rapporto conflittuale, quando le sensibilità degli uni e degli altri non riescono ad incontrarsi a metà strada. Quella serpe di Adolf Loos, per dire, raccontava con ferocia che Henry Van De Velde non solo disegnava le case ma obbligava i suoi ricchi commitenti a vestirsi in modo confacente al suo progetto. Ciabatte comprese. La famosa casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright, capolavoro del XX secolo, veniva chiamata con malcelato disprezzo dal ricco proprietario Edgard Kauffmann “la casa dai sette secchi”, date le continue infiltrazioni d’acqua. E che dire del psicodramma sorto attorno alla costruzione di Farnsworth house? Ludwig Mies van de Rohe aveva progettato un platonico cristallo minimalista sospeso su candidi pilastri d’acciaio. La dottoressa Edith Farnsworth, la proprietaria, viveva con imbarazzo l’idea di girare in una casa dove tutti da fuori potevano osservarla. Il braccio di ferro fra i due si risolse con la progettazione di tendaggi oscuranti, fatture non pagate, cause, processi, maschiliste maldicenze sulla dottoressa invaghita e tradita dal “genio”.
 Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria).
Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria).
 Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente.
Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente.
Abitare un ambiente ecologico, traducendo, significa fare un discorso sulla casa che sappia mettersi in relazione l’intorno: le nostre consuetudini ricadono sulla città. Luca Molinari nel suo agile Le case che siamo racconta come il telelavoro abbia annullato la differenza fra casa e ufficio, al punto che ogni luogo può diventare quello della produzione, e come la reazione a un lavoro domestico sempre più solitario e alienante fa sì che molti colletti bianchi colonizzino bar e locali pubblici con i loro computer, lavorando e allo stesso tempo non perdendo il contatto con la gente, con la realtà.
 Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.
Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.
Questo significa che non avremo più mobili in casa? Ovviamente no. L’abito lo indossiamo noi, abbiamo un limite antropologico: il nostro corpo. Ce lo insegna l’erogonomia. Entrare in relazione con le tecnogie significa renderle usabili. Personalizzarle. Oggi si dice customizzare (parola che odio). Credo sia questo il compito del design del futuro: far interagire corpo e tecnologie in modo personale. Non dobbiamo avere 10, 20, 50 tipi standard di prodotti che ognuno di noi poi sceglie da un catalogo. Dobbiamo progettare processi produttivi che possano adattarsi alle esigenze di ogni singolo. Ognuno avrà la sua sedia, il suo letto, la sua parete attrezzata. “Customizzata”. Già si può fare. È quella che oggi si chiama l’industria 4.0. È il futuro della produzione manifatturiera che riallaccia i rapporti con l’artigianato. Ad ogni persona il suo abito. Ad ognuno la sua abitazione. Il futuro dell’abitare non sarà uguale per tutti, ognuno deciderà come abitare. Su misura.
*
(precedentemente pubblicato in una versione leggermente differente su Lampoon n°15, novembre 2018)


Che bel pezzo, Gianni. Nella mia tesi sul Kitsch parlavo anche dell’abitazione come specchio di chi ci vive. Mi è tornato in mente quel passaggio di “Filosofia dell’arredamento” di Edgar Allan Poe, quando lui stabilisce un atteggiamento negli arredi interni specifico per ogni popolo. Lo cito per il piacere di citarlo, lo conoscerai sicuramente:
“Nella decorazione degli interni, se non nell’architettura esterna delle case, gli inglesi sono insuperabili. Gli italiani non capiscono granché appena si va al di là dei marmi e dei colori. In Francia meliora probant, deteriora sequuntur. Sono troppo una genia di bighelloni per attenersi a quelle convenienze domestiche per cui manifestano, invece, un gusto raffinato, o almeno le basi di una comprensione corretta. I cinesi, e la maggior parte dei popoli orientali hanno una fantasia accesa, ma fuori luogo. Gli olandesi hanno forse un vago sentore del fatto che una tenda non è un cavolo. In Spagna non ci sono che tende : sono un popolo di impiccatori.”
(I traduttori del volumetto Einaudi “Serie trilingue” sono vari, non ricordo chi abbia tradotto questo saggio)
Ornella ci fosse il modo ti metterei un cuoricino. ;-)
Un buon esempio di “narrazione” dell’architettura. Effettivamente non so se può essere anche esposta, non so