Mia madre è il Novecento. Dialogo con Natascha Wodin
di Davide Orecchio
Lo scorso dicembre Natascha Wodin ha presentato Veniva da Mariupol (L’Orma editore 2018) a Roma, nell’ambito di Più libri più liberi. È stato il primo appuntamento italiano per l’autrice tedesca e il libro, dunque un’occasione per conoscerla e ascoltarla. Trascrivo qui stralci dalla nostra conversazione. Con una precisazione. Le mie domande erano preparate, quindi scritte. Mentre Wodin ovviamente ha risposto a braccio, ed è stata poi tradotta da Marco Federici Solari.
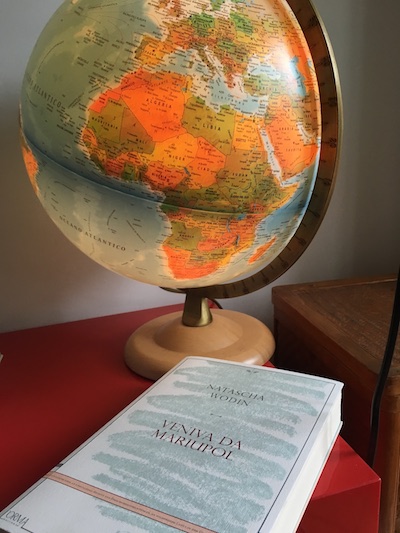
→ → → Natascha Wodin è nata in Baviera nel 1945 da genitori ucraini deportati come forza lavoro durante la Seconda guerra mondiale e ha trascorso l’infanzia in un campo per sfollati. Nella sua opera si è confrontata a più riprese con il materiale autobiografico. Ha conseguito, tra gli altri, i prestigiosi Hermann-Hesse-Preis e Alfred-Döblin-Preis. Veniva da Mariupol ha vinto il Premio della Fiera di Lipsia 2017. È il suo decimo libro. In Italia è uscito un altro titolo: Avrò vissuto un giorno (Einaudi 1995, traduzione di Paola Albarella). Poi una lunga parentesi che si chiude con la pubblicazione di Veniva da Mariupol, nella traduzione di Marco Federici Solari e Anna Ruchat.
Straordinario romanzo-ricerca sul passato, Veniva da Mariupol ricostruisce l’epopea di una famiglia di origini russe e ucraine prima incenerita dal regime sovietico, poi ridotta in schiavitù, insieme a migliaia di Ostarbeiter, nei lager e nelle fabbriche dei nazisti. È la famiglia della scrittrice. Sua madre, suo padre; e poi, lasciati indietro nel tempo e nelle geografie: cugine, zie, nonni ucraini, russi, italiani… Una storia che riemerge dalla memoria e dall’uso sapiente di Internet. Una vera e propria inchiesta digitale che consente all’autrice di ritrovare vicende e persone. Navigando su un sito internet russo, Wodin si imbatte in una traccia della madre, morta da decenni, di cui ignora pressoché tutto. Digita il suo nome e le appare un risultato che restituisce la sua data di nascita, il 1920, e il luogo, Mariupol, porto ucraino del Mar Nero. Inizia così una quest tanto appassionante quanto inevitabile per l’autrice tra le peripezie di una donna e della sua famiglia dispersa e travolta dalle guerre, dalla rivoluzione e infine dal crollo dell’impero sovietico. Per approfondire i temi del libro si vedano la recensione di Valentina Parisi, Il trauma e le radici (Nazione Indiana, 2018), e il saggio di Paola Albarella, Mariupol e l’oblio della storia (Doppiozero, 2017). ← ← ←
D.O. Possiamo definirlo un romanzo?
N.W. È il libro più autobiografico che ho scritto. Non c’è quasi niente di inventato. Ho fatto molte ricerche per scriverlo e tutto quello che ho scoperto l’ho messo nel libro. Ma, inevitabilmente, la ricerca non era completa. Ci sono dei buchi che ho dovuto riempire con la fantasia. Con una fantasia, però, molto realistica, attenta alla verosimiglianza. Per questi motivi credo che si possa definire un romanzo.
D.O. Quando inizia questo viaggio nell’archeologia familiare? Forse potremmo trovare un indizio in una pagina del libro, dove lei racconta che i suoi genitori possedevano una scatola nella quale conservavano gli unici documenti salvati nella fuga dall’Ucraina, le uniche carte che provassero la loro identità e vita passate. Era una scatola preziosa, come immaginerete. «Un giorno – scrive Wodin -, a circa otto anni, decisi che non avevamo più bisogno di quelle vecchie cartacce, o perlomeno che non ne avevo più bisogno io. Quando per l’ennesima volta fui mandata in cantina a prendere il carbone commisi uno dei peggiori crimini della mia infanzia. Sollevai la scatola con i documenti e la gettai nel bidone della spazzatura nel sottoscala. Nessuna prova delle mie tanto odiate origini doveva sopravvivere, ogni traccia doveva scomparire per sempre». Forse il viaggio alla riscoperta delle sue origini inizia subito dopo quel gesto così lontano nel tempo, e così determinato nel volerle cancellare per sempre. Le origini: prima gettate nella spazzatura, da bambina e figlia di sfollati. Poi, per il resto della vita, inseguite e recuperate nella memoria e nella scrittura…
N.W. In realtà non è stato così. Da giovane non volevo avere niente a che fare con la Russia. Volevo eliminare dalla mia vita tutto ciò che riguardava la Russia. In quel tempo è come se avessi dormito. È stata la generazione del ‘68, il movimento, a risvegliarmi. Nella scuola tedesca ti insegnavano che era stata la Russia ad avere attaccato e invaso la Germania. Per questo sentivo la mia provenienza come una colpa. Solo a partire dal ‘68 si è cominciato a parlare in modo diverso dell’Urss, e ho scoperto che era stata la Germania a invaderla. Però è dovuto trascorrere molto tempo prima che riuscissi ad affrontare la storia dei miei genitori, che di loro stessi raccontavano solo di essere degli emigranti. Cinque anni fa, quando ho cominciato le ricerche per questo libro, già sapevo molto di più sulla mia famiglia. Sapevo che erano stati lavoratori forzati. Mi ero informata. Conoscevo la storia degli Zwangsarbeiter in Germania. Avevo cominciato a comprendere i numeri spaventosi di questo fenomeno. In Germania durante la Seconda guerra mondiale c’erano 42.500 campi. L’intero paese era un lager a cielo aperto. Nel lavoro coatto fu impiegata una percentuale molto alta di slavi, che erano considerati al livello più basso della società, appena prima degli ebrei. Ma per l’opinione pubblica tedesca questa storia quasi non esisteva. Abbiamo avuto moltissime riflessioni e testimonianze sulla Shoah, ovviamente, ma dell’enorme ingiustizia subìta dagli Ostarbeiter non si sapeva nulla. Mi sono detta: chi, se non io che ho questa storia alle spalle, può raccontare tutto ciò? Così ho pensato di scrivere la storia di mia madre, e attraverso la sua di raccontare la vicenda degli schiavi dei nazisti deportati dall’Europa dell’Est. Mentre pensavo a questo progetto, in una notte di mezza estate, ho davvero un po’ per gioco digitato il nome di mia madre in un sito russo, e sono rimasta scioccata nel trovare informazioni su una donna nata settant’anni fa.
D.O. Non posso soffermarmi su tutti i personaggi del libro. Ho pensato di proporvene solo due, a mio parere speculari. La madre, Evgenia. E sua sorella Lidia. Hanno due destini comuni ma opposti. Ci mostrano come di fronte allo sterminio, alla violenza, alla guerra non si hanno terze vie a disposizione: o si soccombe, o si lotta per sopravvivere. Insomma il codice di questa storia è binario. Evgenia soccomberà. Non resiste alla duplice violenza, prima sovietica e stalinista, e poi dei nazisti e dell’esilio in Germania. Lidia invece sopravvive al Gulag. Trova un compagno. Morirà solo nel 2001. Se una sorella si arrende e si toglie la vita, l’altra invece si ostina a durare.
N.W. Tra le due sorelle c’era una grande differenza caratteriale, e anche di età (8 anni). Mia madre era l’ultima figlia. E’ stata per certi versi la cocca di casa. Se avesse vissuto almeno un poco del benessere e della sicurezza goduti dalla sua famiglia benestante, se avesse camminato su fondamenta più solide, la sua sarebbe stata un’infanzia protetta. Ma nacque in un mondo pericoloso, tre anni dopo la rivoluzione bolscevica, in un momento in cui essere ricchi e nobili equivaleva a un crimine e comportava la persecuzione come nemici del popolo, se non addirittura il rischio di perdere la vita. Quanto a mia zia Lidia, ho avuto la fortuna, o la bravura, di trovare tre suoi diari finiti in Siberia, su un armadio. Ricostruiscono la sua vita da studentessa a Mariupol, e poi gli anni della deportazione. Mi hanno consentito di raccontare la sua biografia accanto a quella di mia madre, e poi di raffrontare i due sistemi concentrazionari, quello nazista e quello sovietico, il che mi è parso molto interessante. Lidia fu senz’altro più fortunata di mia madre. Nonostante quanto passò nel regime stalinista. Visse fino a 91 anni. Di mia madre invece – e l’ho scritto anche nel libro – ricordo ancora la frase con la quale mi salutava ogni giorno prima di uscire: “Vado nell’acqua”. Come se stesse annunciando il suicidio. Mia madre davvero non resse a tutto quello che le toccò di vivere. La guerra civile dopo la rivoluzione d’ottobre, la perdita della madre, la distruzione di tutta la famiglia, il lavoro forzato, l’essere una sfollata. Soprattutto, una volta divenuta displaced person, ebbe la percezione netta che non ci fosse più alcuna prospettiva, che quello per lei fosse il capolinea. Una volta usciti dal lager, tutti noi eravamo come dei reietti nella società tedesca. Ci lanciavano addosso le pietre. Ci insultavano. Era una situazione insostenibile. E mia madre non ce l’ha fatta.
D.O. [Un ragazzo dal pubblico chiede a Wodin che rapporto abbia con la cittadinanza. Se si senta più russa o tedesca o italiana. A questa domanda aggiungo una considerazione che non ho avuto il tempo di fare]. Si può trovare rifugio in una lingua. W. scrive che sin da bambina si ostina ad apprendere il tedesco perché le appare come «una corda sicura e resistente a cui aggrapparsi per saltare dall’altra parte». Allo stesso modo la storia della zia Lidia mostra come ci si possa trarre in salvo adeguandosi tra le lingue: il russo e l’ucraino tra i quali la donna oscilla per sopravvivere al nuovo potere rivoluzionario e alle sue regole. Dunque una lingua, seppure non quella materna, può essere la salvezza di una persona, e può diventare il suo territorio di asilo.
N.W. Sono nata e cresciuta in Germania. Parlo tedesco. Penso in tedesco. Sogno in tedesco. Scrivo in tedesco. Da quando è caduto il Muro, però, ho anche una vita russa. Perché in Germania, a Berlino, sono arrivati molti russi. Così ho ripreso a parlare quella lingua ogni giorno. Ho la fortuna di vivere in due mondi contemporaneamente. Ma sono un po’ italiana, pure. Amo l’Italia e la sua lingua, che purtroppo non parlo bene come vorrei. E sento una forte affinità con l’Ucraina, paese di origine di una parte della mia famiglia.
D.O. [Anche questa domanda, purtroppo, non ho avuto il tempo di farla. La aggiungo qui in conclusione]. W. scrive: «Da che ho memoria, ho sempre avuto voglia di andare via, solo andare via, per tutta la mia infanzia non ho desiderato altro che diventare adulta per poter finalmente andare via. Volevo andare via dalla scuola tedesca, via da “Le case”, via dai miei genitori, via da tutto ciò che mi definiva e che mi sembrava un errore di cui ero prigioniera. Se anche avessi potuto sapere chi fossero i miei genitori e i miei avi, non avrei voluto saperlo, non mi interessava, non mi importava proprio, era una cosa che non mi riguardava in nessuna maniera. Volevo solo andarmene, lasciarmi tutto alle spalle, strapparmi da quel luogo e rifugiarmi in un’esistenza tutta mia che da qualche parte là fuori doveva starmi aspettando».
La vita dipende dal movimento. Tutta la genealogia di questa famiglia si regge sul movimento. Si muovono gli antenati: i nonni italiani, navigatori e commercianti. Si muove Lidia per salvarsi dal regime staliniano. Si muovono il padre e la madre dell’autrice. È una giostra di fughe, di traiettorie nella storia, nella guerra, nella geografia. Anche lei, l’autrice, come emerge dalla citazione che ho letto, avrebbe forse desiderato movimento. Ma la sua voce, che si prende sulle spalle questa storia, appartiene invece a un presente fermo, che ha il privilegio dell’immobilità, della calma, che naviga e si muove solo nella rete virtuale, un presente dunque che può essere introspettivo, che può concedersi il tempo del racconto. A me pare che ci sia un equilibrio necessario tra il movimento delle storie, le fughe illustrate, e la calma statica della voce narrante, della stessa autrice. Ma è davvero così?

