off/on
(come spesso, la domenica pubblichiamo un post dell’archivio, questo fu pubblicato da Franz l’11 agosto 2008, red)
di Franz Krauspenhaar
off
Con quella maglia di Snoopy
versante calamaro
mi viene da piangere Warhol
minestra, da una siepe maestra
nasconditrice di falsi.
Sembri uscita da una lavatrice,
da una confezione Zuegg
o cornflakes, da una piramide
di latte, da un fiore esploso.
Mi sembra di conoscerti:
non giudiziosa, cadaverica,
spongea, matrale, cutrunuta,
ringhiosa e arbitrale.
E arrabbattona, succulenta ai
soldi, leccalecca ai non fastidi.
Semplice da bere, come sciroppo
d’acero abbattuto al breakfast.
Mi sembri scemunita con scimmie
da zoo calvo, da zio indegno,
da Pino Insegno blatta ‘s speaking.
Quando morì Stefano l’unico
che mi scriveva lettere era un nazi.
Non dimenticherò questo scherzo,
che nel male c’è un pugno di bene
a volte. Ascoltando Ladyhawke
cantare, mi pareva di sentire
una lavanderia a gettoni frinire
male, con getti d’aria calda.
La Nuova Zelanda è il paese
del pesce bollito. Il brodo di serpente
è il tuo prossimo beverone per pulirti.
on
Come zio Renny, berrò beveroni al cacao
prima del tennis, fino alla morte,
lancio dell’anima nello spazio
1999, a 80 anni, Stato di New York. Se ci sei
batti un colpo, solleva una coscia
al mare monstrum dei ricchi, allo yacht
di George Clooney. Si alzi la matrace
curvilinea mossa del mare sporco
in una estate di scogli avanzati,
di ciclopiche isole-davanzale, poste
davanti a tramonti-mare estate 2008,
con trent’anni di ricordi subissanti.
Sei nell’oblio-mutanda fiore. Non hai
che da scegliere il lingotto dove fondere
le tue catene forza otto. La chiglia afro
del mio orologio d’oro balena al sole,
come orafo squillo di luce, nel ricordo
d’un padre Nettuno, spoglio a falcata
doppia dalle acque. Kalabrian sound
nella sera sorda, rimembro il decollare
dei sogni già finiti, confezione famiglia.
****
Era leggendo il vittimario blog,
pieno di raspe leccanti e velenosi
piccanti ambasciatori del nulla,
che mi venne l’idea del taglio.
Stop, finis, Ende, The end, il curtain
velo pietoso, su tutto e anche tutti.
Tristesse bonjour, arrivederci Poma
nel senso della via del delitto
della mela bacata d’ingiustizie
di giudizi trancianti da robespierri
letterali. In culo al kilo, tutti quanti,
pieni di bile e di bava d’impotenti
l’ultimo cazzo ritto fu quello del padre
quando ve lo sfaccimme
a vostra madre.
E così, quando il libro fu scritto
e pronto alla distribuzione,
si riaccese la pera Osram della luce.
On, su tutta la mia vita bigia
altezzosa, bassofondalica.
Venne dalle rocce papà, nero
tedesco e muto, soldato fantasma
d’acqua marina sorto dai mulinanti
fiumi centroeuropei, scuri, duri,
dall’Elba. Comignoli tra l’acque,
fumo di ciminiere e nere coltri
di passato esploso in una guerra.
Oggi lo sogno ancora. Faccio -così-
a cazzotti con i morti, i miei.
Picchio mio padre, e mio fratello
che lo seguì, quasi dieci anni dopo,
nel loro triste regno, triste per chi
non c’era. Morti che sorridono
oltre la schiuma della vita, e dentro
piangono. Quei morti siamo noi.
****
Fino al peso morto, stecchito
della storia. Fino ai noi, i tutti
superstiti. Dai Sessanta io
vago in pena per il quartiere. Ora
polpa di estraneità, cuori soltanto
neri, gialli Cina e Indocina,
come pesci, tra i coralli e la gomma,
e nei bar, verso San Siro, Marocco, Algeri
gutturale. Voi non ci siete più, da tempo.
E’ una piramide di parole secche e di ciglia, di gesti,
mentre le mani gonfie toccano michette dei frati,
alla mensa dei poveri. Il venditore indiano di fiori,
il barista cinese col nome italiano, mai vacanza,
mai imparata la lingua, e il marocchino sbronzo
alle sette: mi dice che siamo della stessa razza,
chissà; e parla di Lampedusa, come di una storia
a fumetti. Che pena il quartiere, polpa di vecchi
che sputano artrosi dalle vene, di stranieri ubriachi
nel giardino, urlanti a notte brilla, dove noi bimbi, al dribbling
successivo, sognavamo Pelè. Tempi sgretolati,
voi c’eravate, giovani e assolati. Ora non siete più.
Quartieri senza più quartiere, stranieri e vecchi smessi,
vino che piscia dai cartoni, rosso come il corallo falso
del sole a picco su mani sbianchite. E voi niente,
non vedete più, morti e ciechi rimproverati dal tempo
che scorre, che è scorso, che è morto.
Non voglio più morire, qui
– qui non sono mai nato.
(La prima immagine è di Giovanni Cossu. La seconda è di Gianfranco Ferroni – Autoritratto. La terza: inquadratura da “Milano calibro 9”, di Fernando Di Leo, 1972. All’amica Nina Maroccolo.)


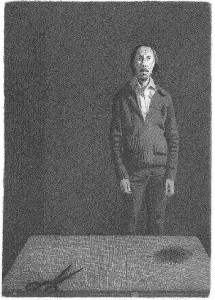


penose.
Ciao Franza, ti chiedo pubblicamente scusa qui per il commento precedente, solo la prima non mi convince, perché secondo me è troppo “pop”, ma ti riconosco fratello in molti degli altri versi. Ti rinnovo le mie scuse. Sincere. anna.
Ci mancherebbe, sei una vera signora. Ciao!