Quel diablo di Baldrati
di Mauro Baldrati
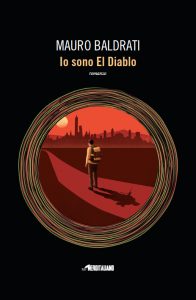 L’inglese camminava veloce, col suo passo regolare.
L’inglese camminava veloce, col suo passo regolare.
Marcia sostenuta, livello 3, uno-due, uno-due, braccia sincronizzate con gambe e respiro. Mani semichiuse. Zaino bilanciato.
Percorreva il vialetto che costeggia il canale tagliando un parco lungo e stretto, immerso nel bosco delimitato da case e da una strada molto trafficata. Quell’itinerario, che partiva dal campo abusivo nella periferia nord di Bologna e arrivava fino alla cittadina di Casalecchio di Reno, era lungo una dozzina di chilometri. L’inglese col suo allenamento lo percorreva in circa 90 minuti. Aveva alle spalle migliaia di chilometri di marcia, su strade di città, lungo fiumi fangosi, su terreni incolti, sulle sabbie roventi di deserti sferzati da venti crudeli.
Si massaggiò l’orbita vuota, sotto la benda di cuoio nero. Alle prime avvisaglie di primavera gli prudeva sempre. Chissà perché. E con la protesi di vetro era anche peggio. In inverno diventava come un cubetto di ghiaccio piantato in faccia, per cui preferiva tenersi il buco coperto dalla benda da guercio. Anche la placca di metallo che avevo al posto dello zigomo sinistro sotto la profonda cicatrice che partiva dalla radice del naso e arrivava fino all’orecchio strappato sentiva la primavera: prurito, ma anche indolenzimento, o dolore, come se una tenaglia cercasse di strappargli un pezzo di faccia.
Si grattò la cicatrice e si massaggiò lo zigomo. Come li chiamavano quelli come lui gli scrittori di fantascienza? Cyborg. Esseri umani con innesti di organi artificiali.
Esseri umani potenziati.
Lui era un piccolo cyborg
con uno zigomo di acciaio inossidabile.
Ma un cyborg guercio.
Potenziato da un lato
indebolito dall’altro.
Decise di fare una piccola sosta.
Non si sentiva stanco in verità.
Il passo regolare e monotono lo rilassava, anziché stancarlo.
Si sedette su una panchina al sole. Si sfilò lo zaino di tela mimetica e prese la borraccia di alluminio. Bevve una lunga sorsata. L’acqua fresca, quasi gelida, aveva il sapore ferroso della fontana del campo, quel vecchio rubinetto incrostato di calcare e di ruggine. Non della borraccia, perché già a quei tempi le rivestivano di vetro per proteggere il liquido dall’ossido del metallo. Curavano molto le dotazioni, questo andava detto. Come gli anfibi, di cuoio spesso, che nel corso di quasi trent’anni di attività ininterrotta avevano assunto un colore scuro, un non-colore che tendeva al marrone nerastro, con striature verdognole.
Anfibi indistruttibili.
Anfibi da guerra.
Aveva sostituito le suole da un artigiano di Milano, uno che, si vantava, costruiva a mano le scarpe per le star di Hollywood, Stallone, De Niro, Al Pacino, George Clooney. Gli erano costate 200.000 lire nel 1999 e ancora resistevano.
Suole italiane.
Suole top gun.
Ripose la borraccia. Lanciò occhiate distratte alle case di quattro-sei piani che racchiudevano quel parco come palizzate di un fortino militare in disarmo. Lo sguardo correva ai tetti e ai terrazzi di copertura, cercandola.
La cercava.
Forse sperava di vederla.
Come un oggetto rassicurante.
Una conferma. Come una ripetizione.
Un ritorno del tempo morto.
La bandiera nera che garriva sul tetto, frustata dal vento.
La bandiera che in passato sventolava sugli antichi coppi della sua casa che lui non riusciva a vedere perché era invisibile come il vento che la gonfiava.
Eppure c’era. La sentiva.
La bandiera nera della sventura piantata sul colmo della mansarda dove aveva la sua camera.
Riprese il cammino.
Attraversò il viale intitolato al pittore Caravaggio, costeggiò il centro sociale dove gli anziani giocavano a carte e cuocevano quelle frittelle chiamate crescentine e imboccò il tratto di strada lungo il canale proveniente dal fiume Reno. Sulla sinistra, muri di pietra chiazzati di umidità rivestiti da strati di rampicanti contenevano edifici residenziali coi loro cortili e una casa di cura. L’acqua scorreva sulla destra, racchiusa da argini a picco con un camminamento sopraelevato che sembrava una copia dell’antica muraglia cinese, con tanto di casematte simili a torrette di guardia. Dominava un color mattone di tonalità calda, l’erba cresceva nelle fessure delle pietre e le anatre nuotavano nell’acqua bassa, seguite da file di anatroccoli. Quando apparve il ponte pedonale di metallo bianco che attraversava il Reno, sostenuto da tiranti d’acciaio come un modellino del ponte di Brooklyn, capì che era quasi arrivato a destinazione.
Scese la scala di sassi e percorse l’ultimo tratto di vialetto quasi a livello dell’acqua. Attraversò il canale sul vecchio ponte di mattoni e raggiunse il bar Melody, sotto al portico di un palazzo pietra a vista.
Fuori dalla doppia vetrata sostavano i soliti tipi di varie età, coi bicchieri in mano.
“Inglese” disse uno, mimando un brindisi.
“Inglese.”
“Inglese.”
Non si fermò.
Non si fermava mai.
Salutò tutti con un cenno del capo ed entrò nel bar.
Il proprietario, un uomo di circa quarant’anni col grembiule e gli occhiali gli batté sulla spalla.
“Inglese. Dai che ti aspettano”.
Tre uomini erano seduti a uno dei tavolini di fòrmica marrone. Subito lo invitarono a sedersi per la serie di partite a carte che costituiva il loro evento pomeridiano del mercoledì.
L’inglese si accomodò mentre ordinava una birra. Uno degli uomini, un pensionato dai modi bruschi, iniziò a distribuire le carte. Partivano con le briscole, due e la bella, cui seguivano due e la bella di tressette, fino all’eventuale spareggio con due e la bella di briscola.
Due e la bella di tutto.
Nessun saluto, né convenevoli. Gli piaceva quello stile rude, sbrigativo. Nessuno gli aveva mai chiesto nulla, da dove veniva, se era in pensione e perché lo era così giovane. Oppure se era un vagabondo disoccupato capitato a Bologna per chissà quale gioco del destino.
Lui e il suo socio, un pensionato svelto piccolo di statura che ricordava a memoria tutte le carte, vinsero le briscole. Vinsero anche i tressette. Nessuno spareggio.
“Certo che te, inglese, ci hai un culo esagerato” disse il pensionato che distribuiva le carte. L’inglese confermò con un cenno del capo.
Poiché era presto partì una serie di ramino, poi scala 40 e un’ulteriore serie di briscole. A fine pomeriggio, all’ora dell’aperitivo, aveva totalizzato quasi venti euro di consumazioni.
Finito l’ultimo giro i pensionati sbraitarono ancora per una decina di minuti, poi scapparono tutti, per la cena.
L’inglese si massaggiò l’occhio. Lo sentiva gonfio, stanco. Aveva fissato troppo a lungo le carte. Desiderava chiuderlo, coprirlo con un batuffolo di cotone umido. Era il metodo di riposo più efficace.
Guardò l’orologio. Le 19.30. Gli conveniva mangiare qualcosa nel bar, usando i soldi delle consumazioni. Ordinò due panini e due bottiglie da mezzo litro di acqua minerale. Una l’avrebbe bevuta subito, l’altra portata con sé nello zaino per la marcia di ritorno.
Mangiò nel bar deserto, col barista che seguiva un programma di sport alla televisione.
Restò qualche tempo seduto immobile di fronte alla vetrina, guardando fuori, senza fare nulla, ascoltando i suoni, fissando i rari passanti che sfilavano al di là del vetro.
Si alzò prima che il barista lo informasse gentilmente che il locale stava chiudendo.
Uscì, nel piccolo quartiere già deserto.
Camminò fino al ponte bianco, sostando sulle grosse assi da muratore che formavano la passerella. La struttura vibrò, per il passaggio di un podista. C’era gente che correva sempre, a tutte le ore, anche di notte.
Si appoggiò alla balaustra di metallo, osservando i numerosi lucchetti appesi ai tiranti di acciaio. Erano giuramenti d’amore, gli avevano detto, una moda che si era diffusa da un romanzo giovanile.
Amore eterno. Come un lucchetto chiuso le cui chiavi erano state buttate via.
Sotto al ponte l’acqua limacciosa ruggiva veloce. Il fiume era gonfio. La corrente formava una rapida contro lo sbarramento di rocce del fondale. L’acqua marrone diventava nera mentre si perdeva in lontananza nella notte.
La notte, il buio.
Come la sua casa, con la tromba delle scale senza luce. E il rombo dell’acqua sembrava riempire quel vuoto della casa fredda, quel silenzio rotto solo dai singhiozzi lontani e monotoni di una donna sempre vestita di nero.
Una donna già in lutto anche se nessuno era ancora morto.
Il rombo dell’acqua gli piaceva. Amava addormentarsi con quel suono. Talvolta lo faceva, in estate, sulle rive del fiume in Sicilia dove passava le estati.
Sotto al ponte c’era una panchina. Con una coperta avrebbe potuto sdraiarsi e perdersi nel frastuono della cascata. Ma la serata era fredda e umida, e non aveva una coperta. Spesso al mattino usciva col sacco a pelo legato sotto lo zaino, perché dopo le giornate di vagabondaggio per la città non rientrava, dormiva in un parco o sotto a un portico svegliandosi intontito, barbone tra i barboni, straniero tra gli stranieri.
Tornò indietro e riattraversò il quartiere. Le strade erano vuote. Dalle case, alcune con le finestre socchiuse, provenivano i suoni delle televisioni. Qualche voce. Una risata. Sbattere di piatti e pentole.
L’inglese si sistemò lo zaino sulla schiena, infilò le mani in tasca e si apprestò a percorrere i 12 chilometri del ritorno, nel buio pieno del parco lungo il canale.
NdR Questo è l’incipit del nuovo romanzo di Mauro Baldrati, “Io sono el Diablo”, appena uscito con l’editore Fanucci; e qui di seguito rispettivamente la presentazione di Valerio Evangelisti sulla quarta di copertina e la scheda preparata dall’editore:
“Spesso si scambia il genere noir per una variante del poliziesco. Non è così: il noir è una tragedia moderna, in cui le tinte scure della vicenda rispecchiano quelle ancor più cupe della società. Mauro Baldrati, con il suo linguaggio parco, privo di compiacimenti, percorre un’Europa che si preferirebbe non esistesse. Invece c’è, l’abbiamo sotto gli occhi. Quella dei traffici di tutto, dalle merci più o meno illegali agli esseri umani. Pochi saprebbero rendercela evidente con la violenza di uno schiaffo. Serve un virtuosismo non comune. Baldrati ci riesce, con brutalità stilistica mista a echi poetici tutt’altro che inconsapevoli.”
“Il passato e il presente dell’inglese, con il suo enigmatico volto sfigurato da un solco sghembo che gli attraversa l’occhio coperto da una benda nera, sono avvolti nel mistero. Le sue giornate seguono una disciplina marziale: pur non essendo un clochard, dorme in un campo nomadi abusivo, si sveglia all’alba e cammina tutto il giorno per le strade di una Bologna degradata e sconosciuta ai più, macinando chilometri senza un’apparente meta. La sua vita scorre così, uguale da anni, finché una sera si imbatte in Violeta, una donna albanese in fuga da un passato pericoloso. È l’incontro tra due solitudini, due anime perse, oscure e affini. Per aiutare Violeta, l’Inglese recupera il suo vecchio nome di battaglia, El Diablo, e si immerge in un frenetico vorticare tra Italia, Inghilterra e Albania, tra legami nocivi con la criminalità organizzata, anime corrotte, botteghe a luci rosse, traffici di merci ed esseri umani Per portare a termine la sua complicata e rischiosa missione, El Diablo si troverà scaraventato in un abisso in fondo al quale pulsa il cuore nero del male. Allora sapremo chi è davvero l’inglese.”


‘Una donna giá in lutto anche se nessuno era ancora morto….’ . Ma il senso? Nuova prosa, nuova letteratura? Non certo poesia…..Un libro intero con questa sorta di collage di frasi, di situazioni asistemiche….Boh, bah, beh…..
Carlo, rispetto il tuo giudizio (immagino tu l’abbia per intero per poter dire che è un libro intero di quel genere), ma di per sé a me vien voglia di saperne molto di più di quest’inglese, di farci un giro per la città, di saperne di più su quell’aria nera che si porta dietro la donna. Quanto alla poesia, perché deve per forza esserci? immagino ci sia invece una buona trama, ma anche lì, perché ci dev’essere per forza la trama? un giornalista olandese ha chiesto a Banville perché non c’è la trama nel suo romanzo, e la risposta è stata perché, la vita ha una trama? Una cosa rimprovero a Baldrati. Dai, l’inglese non è un giocatore da briscola, dai, neanche da tresette, almeno la sua forma raffinata e non facile che è il chiama il tre…