Iconoclastia artistica e concetto di littéralité
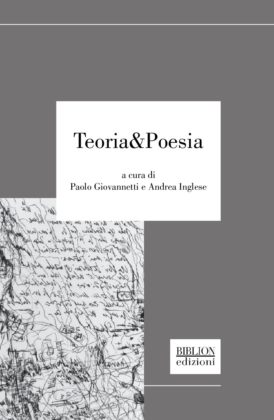 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese
(Questo testo è incluso nel volume Teoria e poesia, curato da Paolo Giovannetti e me, per le edizioni Biblion di Milano. Il volume raccoglie 11 testi di altrettanti autori che su invito dei curatori hanno realizzato una giornata di studio, con interventi e discussioni, alla Libreria Claudiana di Milano il 16 settembre 2017. Gli autori sono Giulio Marzaioli, Florinda Fusco, Vincenzo Frungillo, Stefano Ghidinelli, Italo Testa, Mariangela Guatteri (responsabile anche dell’immagine di copertina), Lorenzo Cardilli, Luigi Severi, Stefano Versace, Simona Menicocci.)
Ideologie del testo
Nel regime moderno delle letteratura, così come in quello delle arti, lo statuto di un testo, la sua appartenenza all’universo letterario, o a un genere specifico, nonché il suo funzionamento, e i suoi eventuali meriti e demeriti, non sono determinabili in modo esclusivamente consuetudinario, ma esigono periodicamente delle nuove forme di legittimazione. Il testo da solo non garantisce come debba essere letto, ma neppure le abitudini di lettura lo garantiscono una volta per tutte. Di qui l’importanza, nel caso del testo poetico ad esempio, di ideologie del testo, ossia di un sistema più o meno solidale di idee e valori che ne accompagnino e orientino la lettura. Questo non vale ovviamente solo per quelle che chiamiamo “poetiche”, ossia prese di posizioni dogmatiche che autori singoli o gruppi di autori esprimono nei confronti del loro lavoro letterario, né vale solo nei casi di rotture delle consuetudini di lettura di tipo avanguardistico. La presenza di “ideologie del testo” emergono anche laddove abbiamo a che fare con veri e propri generi, come ad esempio la poesia visiva o la poesia sonora, e naturalmente, seppure più attenuate o mascherate, le ideologie del testo emergono anche nei lavori in apparenza più spassionati della critica accademica.
Nonostante la varietà storica delle ideologie del testo, mi pare ipotizzabile ricondurre queste ultime a poche grandi famiglie. Jacques Rancière, ad esempio, ha realizzato un lavoro importante sul regime moderno della letteratura, a partire dall’ormai assodata discontinuità storica rappresentata dall’epoca romantica. Penso in particolar modo al suo tentativo di definire le contraddizioni costitutive del campo letterario moderno, realizzato in La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature (Hachette, 1998). Per quanto mi riguarda, mi limiterei a evocare uno dei paradossi cruciali analizzati da Rancière, quello che oppone l’assoluto dell’espressione individuale allo “spirito” collettivo di un’epoca e di un popolo. Vi è paradosso, in quanto, come scrive Rancière, “Il genio romantico non appartiene a un individuo che nel momento in cui appartiene a un’epoca, a un popolo, a una storia. La letteratura non è la realizzazione della potenza senza norme della poeticità che nel momento in cui è «espressione della società»” (traduz. mia, p. 51). Prendo spunto da tale contraddizione, ma anche da altre considerazioni che non posso qui sviluppare, per ipotizzare due grandi matrici che si trovano alla base delle diverse ideologie del testo poetico: la prima riconducibile alla nozione di “integrità” e ai valori ad essa associati, la seconda alla nozione di “emancipazione”. In molteplici casi, possiamo rintracciare nel corso del Novecento il tentativo di giustificare l’importanza sociale del linguaggio poetico, in ragione della sua capacità se non di restituire, di promettere almeno un’esperienza “integrale” del mondo, esperienza che la vita in società per lo più rende impossibile. Utilizzo appositamente una formulazione vaga, perché essa può accogliere un certo numero di esempi concreti: l’integrità a cui si tende è quella del contatto con la propria psiche profonda, o con la realtà naturale nella sua pienezza, o con l’essere in senso metafisico e totalizzante. Similmente, il Novecento è disseminato di esortazioni a “liberarsi” da svariati condizionamenti grazie alla pratica della poesia, in forme che possono essere diverse: scritte, visive, gestuali, sonore. La poesia permette di emancipare il poeta e il suo pubblico dagli schemi mentali e linguistici di una società conservatrice, repressiva, inegualitaria, ipocrita, ecc. Di primo acchito, si potrebbe pensare che gli ideali dell’integrità siano tipici di una poesia lirica, incentrata sulle capacità espressive del soggetto, laddove gli ideali di emancipazione siano prerogativa di tutte le forme contestatarie, anti-liriche e sperimentali, di poesia, legate alle tradizioni delle avanguardie. Le cose sono evidentemente più complesse, e spesso integrità ed emancipazione appaiono ideali interconnessi.
Perché la littéralité?
La nozione che qui vorrei esplorare è quella di letteralità, da distinguersi ovviamente da quella ben più celebre di letterarietà. In italiano il concetto suona inusuale, ma nella sua formulazione francese (littéralité) rinvia immediatamente a un contesto di riflessione critica e teorica sulla poesia, che ha tra i suoi maggiori rappresentanti lo scrittore e critico Jean-Marie Gleize. Ho scelto il concetto di letteralità, perché esso ha senza dubbio confortato e nel contempo rafforzato delle pratiche che appartengono, nel campo poetico italiano, all’ambito più o meno frontaliero delle scritture di ricerca. Se ciò è un dato senz’altro positivo, questo stesso concetto merita una lettura non unilaterale e riduttiva, nel momento in cui viene finalmente recepito all’interno del dibattito sullo statuto e i confini della poesia. Per realizzare questo obiettivo adotterò una duplice strategia: da un lato, inserirò la teoria “letteralista”, inedita per il mondo letterario, nel filone dottrinario delle arti moderne a cui è riconducibile, ossia in quello dell’utopia iconoclastica; dall’altro, giocherò Francis Ponge contro Gleize, mostrando come l’opera ispiratrice sia più ricca e sfaccettata delle dottrina che la celebra e se ne serve.
Non voglio entrare più di tanto nella storia e nella forma che hanno assunto da noi le influenze di Gleize e di altri autori di area francese. Mi limiterò a individuare due momenti nella storia di questa rapporto di fascinazione: uno di “entrata”, per così dire, e uno di “uscita”. (Con questo intendo definire un tempo di latenza, durante il quale un’influenza letteraria si fa strada, fino ad acquisire una sorta di radicamento e di maggiore ovvietà.) Il momento di entrata può essere costituito dal volume collettivo Prosa in prosa, del 2009 1, in cui in modo programmatico un gruppo di sei autori (tra cui il sottoscritto) e due critici decidevano di riferirsi a una formula coniata appunto da Jean-Marie Gleize, imparentata con il concetto di letteralità, e valida sia come manifesto di poetica sia come strumento euristico per leggere e comprendere certi testi della produzione contemporanea. Il momento di uscita potrebbe essere rappresentato – ma siamo ovviamente a indicazioni abbastanza arbitrarie – da un articolo della scrittrice e critico Gilda Policastro apparso nel 2016 per “il verri” 2, in cui la conoscenza di certi autori francesi viene considerata come cruciale per elaborare nuove pratiche di scrittura e lettura in Italia. Non mi sembra che nulla situasse una scrittrice come Gilda Policastro in prossimità di quelle scritture francesi, almeno al momento della pubblicazione di Prosa in prosa. Penso che, di tali scritture, sia stato fatto da lei, come da altri autori in anni recenti, un lavoro lodevole di scoperta e progressiva integrazione nel proprio universo teorico e creativo. Una nozione come quella di letteralità, allora, pur circolando all’origine entro un raggio di autori e critici apparentemente ristretto, ha potuto in seguito avere un’influenza più ampia su tutta l’area della cosiddetta poesia di ricerca e persino oltre.
L’utopia di un realismo integrale
Il termine “letteralità”, nel suo uso corrente italiano, ha un significato positivo e uno negativo. In quello positivo, viene sottolineata l’assoluta e oggettiva fedeltà a una fonte: “Ho trascritto alla lettera quanto hai detto”. In quello negativo, si segnala un’ottusità interpretativa: “Ti fermi alla lettera, senza coglierne lo spirito”. Nell’uso che ne fa la teoria letteraria di Gleize, la poesia “letterale”, invece, “è una poesia della sottrazione o della neutralizzazione delle immagini” 3. Le immagini, intese in senso ampio, costituiscono il nemico, l’ostacolo nei confronti di una poesia pienamente realizzata. “Non si tratta soltanto di quella famiglia di figure che denominiamo metafore, o della similitudine, ma della questione dell’immagine in generale, della rappresentazione visiva o immaginaria, della possibilità stessa della rappresentazione” 4.
La poetica della letterarietà emerge in Gleize attraverso un’ampia indagine di natura critico-teorica, che sedimenta in due libri, Poésie et figuration del 1983 e A noir. Poésie et littéralité del 1992, raccolti recentemente in un unico volume intitolato Littéralité. Nel corso di questa indagine Gleize analizza un certo numero di autori della tradizione francese, da Lamartine a Anne-Marie Albiach, passando per Rimbaud, Ponge, Denis Roche e molti altri. Le letture dei poeti conducono puntualmente a una riflessione sulla loro concezione della poesia. Infine questo ricco e penetrante lavoro da studioso di letteratura sfocia in un gesto di poetica, che tende ad essere ovviamente più arbitrario, ma anche più elusivo e sfuggente. Io vi riconosco comunque le due componenti principali delle ideologie del testo che sono riscontrabili tra romanticismo e modernismo: l’aspirazione all’integrità e quella all’emancipazione. Le precedenti citazioni di Gleize hanno già indicato in che senso la scrittura della letteralità intraprende la via dell’emancipazione: bisogna liberarsi di quell’enorme deposito d’immagini e di significati che impregnano costantemente il linguaggio, per giungere a una sorta di nudità, ma anche di scaturigine della parola. L’immagine che scivola nei nostri versi è sintomo di schiavitù molteplici: nei confronti del vocabolario poetico ereditato, nei confronti degli schematismi percettivi della cultura in cui si è stati educati, nei confronti, infine, della natura ideologica di tutti gli usi linguistici, interiorizzati nel corso della riproduzione sociale. E l’esercizio apparentemente anarchico dell’immaginario – lo slancio fantastico – non sfugge a questi svariati condizionamenti.
A questo versante negativo – “sappiamo ciò che non vogliamo” – è possibile però affiancarne uno positivo – “sappiamo dove vorremmo essere”. Gleize è un realista in senso forte, radicale, ossia è un autore che combatte perché sia ristabilito un possibile rapporto con il reale nella sua integrità. “Non l’ho imparato che molto lentamente, l’esperienza della poesia riguarda il ‘reale’. So che non potrò mai definire questo termine.” Sono affermazioni che troviamo nelle pagine iniziali di A noir, dove vengono convocati diversi poeti a legittimare questa concezione di un “realismo integrale” 5 della poesia: i più prevedibili Rimbaud e Ponge, ma anche i più inattesi Yves Bonnefoy e Philippe Jaccottet. La poesia, insomma, vorrebbe produrre un accesso al reale, al di fuori di tutti i filtri che ogni sistema culturale e ideologico impone agli individui che ne sono membri. Sia ben chiaro, però, che nella poesia pienamente consapevole di sé questo accesso al reale non può darsi che in forma negativa. In altri termini il “realismo integrale” funziona come utopia, come aspirazione radicale e inattuabile, e per Gleize è imparentato con l’esperienza mistica e la teologia negativa.
Breve antologia del “letteralismo” artistico novecentesco
Il binomio “realismo integrale” e “emancipazione dalle immagini” costituisce uno dei nuclei più produttivi delle varie dottrine artistiche del Novecento, dottrine che a loro volta potrebbero rientrare nei capitoli della più ampia storia dell’iconoclastia religiosa e delle sue forme secolarizzate. Mi limiterò a presentare quattro brevi testimonianze autorevoli, a dimostrazione dell’esistenza di una tradizione “letteralista” nel campo delle arti.
Nel 1930, a Parigi, esce il primo e unico numero della rivista “Art concret”, realizzato da Theo Van Doesburg e altri quattro pittori. In esso, è presente un manifesto dal titolo Basi della pittura concreta. Al punto 2, si legge: “L’opera d’arte deve essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima delle sua esecuzione. Essa non deve accogliere nulla dei dati formali della natura, della sensualità, della sentimentalità. Noi vogliamo escludere il lirismo, la drammatizzazione, il simbolismo, ecc.” Al punto 3: “Il quadro dev’essere interamente costruito con degli elementi puramente plastici, ossia piani e colori. Un elemento pittorico non ha altro significato che ‘se stesso’, di conseguenza il quadro non altro significato che ‘se stesso’.” Quanto ai procedimenti di realizzazione, se ne parla al punto 4: “La tecnica deve essere meccanica, ossia esatta, anti-impressionista”.
All’inizio degli anni Sessanta, alcuni autori del minimalismo, come Donald Judd, vollero marcare una discontinuità forte tra i presupposti modernisti dell’espressionismo astratto e le loro pratiche nuove, che realizzavano una concezione pienamente “letteralista” del prodotto artistico. Altri autori, però, come Robert Morris, riconoscevano istanze “letteraliste” già nel costruttivismo, ossia nel primo modernismo. Di queste istanze, il manifesto del 1930 di Van Doesburg e compagni è una matura espressione.
Nel 1957, in un pieghevole prodotto per una sua mostra personale a Como, Pietro Manzoni scrive: “quanto più ci immergiamo in noi stessi, tanto più ci apriamo, perché quanto più siamo vicini al germe della nostra totalità, tanto più siamo vicini al germe della totalità di tutti gli uomini” 6 Ritroviamo qui l’aspirazione a un’esperienza integrale del sé, e dunque della realtà umana universale. E anche in questo caso, essa si accompagna a un processo di emancipazione – di “autoanalisi” lo definisce Manzoni – che ne costituisce la condizione necessaria. Tramite tale processo: “noi ci ricollochiamo alle nostre origini, eliminando tutti i gesti inutili, tutto quello che vi è in noi di personale e letterario nel senso deteriore della parola: ricordi nebulosi d’infanzia, sentimentalismi, impressioni, costruzioni volute, preoccupazioni pittoriche, simboliche o descrittive (…); l’importante è non attribuire mai valore a ciò che è condizionamento soggettivo”. L’argomentare di Manzoni si conclude con una definizione “letteralista” dell’immagine, di cui deve d’ora in poi tener conto l’artista: “Qui l’immagine prende forma nella sua funzione vitale: essa non potrà valere per ciò che ricorda, spiega o esprime (casomai la questione è fondare) né voler essere o poter essere spiegata come allegoria di un processo fisico: essa vale solo in quanto è: essere”.
In quegli stessi anni, in Francia, Yves Klein è alla ricerca dello “spazio pittorico reale”, un concetto limite, al quale il gesto artistico non può avvicinarsi che idealmente e a patto di negare l’intera storia della pittura, abbracciando in modo rigoroso la pratica della monocromia. In uno intervento del 1958, intitolato La mia posizione nel combattimento tra la linea e il colore, scrive: “Un dipinto ordinario, come lo si comprende nella sua materia generale, è per me come una finestra di prigione, le cui linee, i contorni, le forme e la composizione sono determinati dalle sbarre. Per me le linee concretizzano il nostro stato di mortali, la nostra vita affettiva, il nostro ragionamento, persino la nostra spiritualità. Sono i nostri limiti psicologici, il nostro passato storico, la nostra educazione, il nostro scheletro; sono le nostre debolezze e i nostri desideri, le nostre facoltà e i nostri artifici. Il colore invece ha una misura naturale e umana, esso affonda in una sensibilità cosmica” 7 Anche in Klein ritroviamo quella miscela di misticismo e giacobinismo, che è una delle caratteristiche dell’iconoclastia novecentesca.
L’ultimo dei nostri testimoni è Daniel Buren, un altro artista francese. In L’art n’est plus justifiable ou les points sur les “i”, un’intervista del 1968 con Georges Boudaille, Buren afferma a proposito della pittura e dell’arte in generale: “Bisogna eliminare l’illusione quale che sia, e anche l’estetismo, la sensibilità, l’espressione individuale, il che non significa dover lavorare in gruppo, ovviamente, ma che l’opera diventa il reale, il pensiero grezzo e, di conseguenza, anonimo. Insisto sull’eliminazione dell’espressione. Finché le persone si esprimeranno per gli altri, attraverso le arti plastiche, non potranno mai fuoriuscire dal dominio dell’illusione, perché l’opera creata sarà sempre uno schermo ‘espressivo’ sul quale qualsiasi oggetto proiettato apparirà esso stesso sotto forma d’illusione” 8. Buren per certi versi incarna la forma più pura dell’iconoclastia novecentesca, quella che predica l’abolizione pura e semplice dell’arte, attraverso un esercizio di decondizionamento. E tutto il suo lavoro non vuole definirsi altrimenti che una negazione attiva del sistema dell’arte, inteso come illusione conoscitiva e menzogna sociale.

Ritorno a Ponge
Nell’ambito della letteratura, la nozione di “letteralità” ha due punti importanti d’irradiazione nel corso del modernismo, uno di matrice statunitense e uno di matrice francese. La “letteralità” statunitense emerge probabilmente con Gertrude Stein, a partire dal libro Tender Buttons del 1914. In questo contesto, però, è il versante francese che c’interessa. L’autore, da cui ha preso le mosse la riflessione sulla littéralité giunta fino a Gleize, ossia fino agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, è Francis Ponge. E proprio il ritorno a Ponge mi permette di sottolineare aspetti della littéralité che rischiano di perdersi non tanto nella lettura di Gleize – che è scrittore e pensatore sinuoso, capace di sviluppare un discorso forte eppure ricco di sfumature e doppifondi –, ma nella lettura riduttiva che ne facciamo noi, nell’ambito delle scritture di ricerca in Italia, nel momento in cui diamo al concetto una valenza normativa.
Prenderò in considerazione Méthodes, libro di Ponge uscito nel 1961 e contente delle riflessioni di poetica redatte negli anni Cinquanta. In esso, è raccolto il testo di una conferenza presentata in Germania nel 1956 dal titolo La pratique de la littérature. Ponge insistite qui su una caratteristica tipica del poeta – sorta di precondizione psicologica o esistenziale al suo mestiere –, che è la particolare sensibilità all’esistenza del mondo e degli oggetti. Questa sensibilità riguarda, nella formulazione che ne do io, l’esteriorità radicale del mondo, ossia il versante più inospitale della realtà. Versante, per altro, che è sempre schermato dall’interiorità del sistema culturale e linguistico in cui siamo per lo più immersi. Ma Ponge sottolinea un altro aspetto cruciale della postura poetica. Bisogna infatti aggiungere a questa sensibilità generale, una sensibilità più ristretta. Ed ecco cosa scrive: “Quindi, c’è questa sensibilità nei confronti del mondo esteriore. E poi c’è una sensibilità a un altro mondo, anch’esso interamente concreto, stranamente concreto ma concreto, che sono il linguaggio, le parole. Credo che siano necessarie entrambe le sensibilità per essere un artista, ovvero avere la sensibilità nei confronti del mondo e avere la sensibilità nei confronti del proprio mezzo espressivo” 9.
Sembrerebbe una frase tutto sommato banale, se non nascondesse abissi di carattere epistemologico. Nel momento in cui il poeta è colpito, provocato, investito dalla realtà materiale del mondo e degli oggetti, egli reagisce, dando però le spalle a quel mondo, per concentrarsi su un altro mondo, altrettanto materiale, ma più piccolo e sfuggente, che è quello del linguaggio e delle parole. Per altro, in questo scenario si è saltati dal mondo e dagli oggetti al linguaggio e alle parole, senza soffermarsi sul soggetto, sulla sua mente, la sua interiorità, i suoi sentimenti, ecc. Ci si è limitati a sottolineare che il soggetto che scrive poesia dovrebbe possedere una propensione all’attenzione e alla sorpresa nei confronti di ciò che materialmente lo circonda. Ma veniamo al paradosso enunciato da Ponge. Per andare verso il mondo che lo provoca con la sua circostante inospitalità, il poeta è costretto a ripiegarsi sul linguaggio e sulle parole, che hanno una loro specifica consistenza materiale. Ma così facendo, non potrà mai più uscire da quel ristretto mondo linguistico, fatto di certi suoni e certe tracce, per appropriarsi in qualche magico modo dell’oggetto esteriore. L’esito di questa riflessione sembrerebbe condurre allo scacco, all’ammissione di essere finiti in un vicolo cieco. Ma Ponge fa proprio di questa difficoltà lo specifico motore della sua scrittura. La sua strategia potrebbe essere così riassunta: giocare l’estraneità del mondo contro la familiarità del nostro linguaggio; curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo. Ma da cosa bisogna curarlo? Innanzitutto dalle idee che in esso si depositano, dai significati, dagli usi comuni delle parole, ma anche – visto che stiamo parlando di linguaggio poetico – dagli usi che la comunità poetica fa del linguaggio. Quindi il linguaggio va s-poeticizzato, o se vogliamo s-figurato, ossia bisogna liberarlo anche dalle figure letterarie e retoriche. Tutto ciò infatti fa ombra alla realtà dell’oggetto, fa ombra alla consistenza del mondo. Questo tipo di cura è stata ben compresa e valorizzata da Gleize. La littéralité, infatti, è animata innanzitutto da un’ideologia dell’emancipazione, e ciò da cui bisogna emanciparsi sono i significati ordinari, da un lato, ma anche le immagini poetiche, dall’altro. Siamo di fronte al sogno iconoclasta di liberare la lingua dalle immagini soggettive, che sono poi, come già sostenevano gli artisti citati in precedenza, inconsapevoli sedimenti di ideologie dominanti.
In un saggio su Denis Roche, incluso in Poésie et figuration, Gleize evoca le due fondamentali concezioni alternative della poesia novecentesca, quella di ascendenza simbolista, che vede nella poesia l’espressione di una “lingua perfetta, o solenne, o sacra”, e quella di ascendenza modernista, che vede la poesia come “linguaggio essenzialmente, e felicemente, ambiguo”. E aggiunge: “Denis Roche annuncia semplicemente l’apertura di un’altra possibilità: la poesia come linguaggio letterale (non interpretabile). Il linguaggio della verità letterale. Il testo non dice nient’altro che ciò che dice, nel momento in cui lo dice. Un linguaggio, quindi, la cui mancanza di ambiguità ci invita a leggere, a utilizzare, il testo al presente, nel suo e nostro presente” 10. Di questa terza via, Gleize propone una genealogia che da Lamartine, passando per Rimbaud e Ponge tra gli altri, si rivela in qualche modo hegelianamente, nella piena trasparenza di sé, con Denis Roche nel passaggio tra gli anni Sessanta e Settanta. La via letteralista (iconoclasta), però, è già chiaramente rintracciabile in Rimbaud, dove emerge oltre al desiderio di liberazione quello d’integrità: “se lo sforzo poetico è per Rimbaud il tentativo senza sosta rinnovato di una relazione diretta con il mondo, questo tentativo non possiede per realizzarsi che un luogo, il testo poetico, che è un luogo di nessuna parte, dove la relazione al mondo non è né diretta, dal momento che siamo nel linguaggio, né mediata dalla rappresentazione, perché quel che si cerca in queste ‘sedute’ di scrittura è di rompere questa mediazione, di produrre la deflagrazione di queste figure, per reinnestare il linguaggio sulla vita, la pulsione, l’energia, il ritmo, ciò che Rimbaud chiama la ‘danza’ o l’’armonia’”.
Questo aspetto distruttivo, insito nel gesto poetico, è rivendicato anche da Ponge in diverse occasioni, ma ciò non lo conduce verso l’interpretazione riduttiva della “letteralità” che invece emerge progressivamente nella lettura di Gleize. Quest’ultimo, come già accadeva in Ponge, volge le spalle al mondo per agire sulla materia reale dell’espressione, ossia sul linguaggio nella sua forma scritta e stampata, ma il suo movimento è in qualche modo irrevocabile, al mondo non si torna, come non si tornerà alle figure e alle idee che infestano il linguaggio. Nel caso, invece, di Ponge, non vi è mai questo distacco “liberatorio” e definitivo dal mondo. Il poeta gli volge le spalle, ma è costretto in realtà a uno scomodo contorcimento. Egli deve far giocare la pienezza inesauribile del mondo contro la finitezza delle idee e la vuotezza delle immagini. In quest’operazione l’immagine, non è neutralizzata una volta per tutte, ma costantemente evocata e messa in crisi, corretta e oltrepassata.
Vi è un altro passo in La pratique de la littérature che è particolarmente chiaro a questo proposito. Lo cito quasi per intero.
Quando dico che dobbiamo utilizzare questo mondo di parole per esprimere la nostra sensibilità al mondo esteriore, (…) penso che questi due mondi sono stagni, ossia che non vi è passaggio dall’uno all’altro. (…) C’è dunque da una parte questo mondo esteriore, dall’altra parte il mondo del linguaggio, che è un mondo interamente distinto, interamente distinto sennonché c’è il dizionario, che fa parte del mondo esteriore, naturalmente. Ma gli oggetti di questo genere appartengono a un mondo strano, distinto dal mondo esteriore. Non si può passare dall’uno all’altro. Bisogna che le composizioni, prodotte grazie a questi suoni significativi, a queste parole, a questi verbi, siano organizzate in tal modo che imitino la vita degli oggetti del mondo esteriore. Imitino, ossia che abbiano almeno una complessità e una presenza simili. (…) Non si può far passare niente da un mondo all’altro, ma affinché un testo qualsiasi possa avere la pretesa di rendere conto di un oggetto del mondo esteriore, bisogna almeno che raggiunga la realtà nel suo proprio mondo, nel suo mondo di testi, che abbia una realtà nel mondo dei testi. (…) Vale a dire, che sia un complesso di qualità altrettanto esistente di quello dell’oggetto presente. 11
Bisogna, insomma, che il testo si presenti come “un complesso di qualità altrettanto esistente che quello dell’oggetto presente”. Il grado di imitazione poetica qui è garantito dal grado di complessità tra due oggetti di natura del tutto dissimile. Mi sembra questo un punto cruciale, che viene abbandonato nell’interpretazione che Gleize fornisce della letteralità.
Quando il poeta è confinato dentro il piccolo mondo concreto delle parole (certi suoni, certe tracce su carta, certi significati sedimentati storicamente, ecc.), il mondo non è né dissolto né galleggia in una sorta di opacità integrale, inattingibile a qualsiasi considerazione e sguardo. Esso continua, attraverso il vario fronte degli oggetti, a interferire con l’attenzione poetica. Esso continua a esibire i suoi inesauribili strati, le sue densità insondabili. Ed è dentro il linguaggio, che il poeta cerca allora di ristabilire livelli di stratificazione e di densità analoghi. Egli non è in grado di rispecchiare alcuna realtà extralinguistica nel linguaggio, ma può costringere il testo ad assumere articolazioni interne sempre maggiori, in un processo aperto a configurazioni mai compiute e definitive. Nelle parole di Ponge sul “complesso di qualità” che un testo deve esibire in sé, trovo un eco di alcune considerazioni di Adorno intorno al concetto di “articolazione” nell’opera d’arte. “In generale – scrive Adorno – le opere d’arte potrebbero valere tanto di più quanto più sono articolate: laddove non è rimasto nulla di morto, di non-formato; nessun campo che non sia stato percorso dal configurare. Quanto più profondamente questo se ne è impadronito, tanto più l’opera è riuscita. L’articolazione è il salvataggio della molteplicità nell’uno.” 12
La littéralité secondo Ponge, allora, non equivarrebbe tanto a un’enigmatica scrittura che ha programmaticamente censurato ogni impulso figurativo, per non aderire che a se stessa, in una sorta di compiuta e felice intransitività. La littéralité costituisce, semmai, uno dei poli a cui il poeta è ogni volta ricondotto, nel suo inesauribile moto pendolare che va dalla cosa alla lettera, e dalla lettera alla cosa. Vi è letteralità perché ad un tratto il moto oscillatorio tra cose e parole si spegne, e si spegne sempre nella specifica realtà delle parole. Quando la scrittura poetica si arresta, non è perché la raffigurazione è compiuta e adeguata, ma perché il lavoro di configurazione ha trovato almeno provvisoriamente un punto di esaurimento nel testo. L’inquietudine, che il versante inesauribile e inospitale del mondo provoca nel soggetto scrivente, si è trasmessa alle interne articolazioni del testo e si è momentaneamente placata. Le immagini, insomma, comunque le si voglia intendere, non sono eliminate volontaristicamente, per un decreto di poetica a priori, ma sono costantemente incalzate e minacciate per via della loro inadeguatezza al mondo. Quest’ultimo non esce mai dalla scena della scrittura, ma agisce sul suo bordo, come testimone critico di ogni formazione linguistica.
- Bortolotti, Broggi, Giovenale, Inglese, Raos, Zaffarano, Prosa in prosa, introduzione di Paolo Giovannetti, postfazione di Antonio Loreto, Le Lettere, Firenze, 2009.
- Gilda Policastro, Comicità del quotidiano nelle scritture di ricerca contemporanee: una prima ricognizione tra Italia e Francia, “il verri”, n. 60, 2016, pp. 44-57.
- Jean-Marie Gleize, Littéralité, Questions Théoriques, Paris, 2015, p. 344. Tutte le traduzioni dal francese sono mie.
- Ivi, p. 340
- La formula “réalisme intégral è impiegata dello stesso Gleize, e compare già in Jean-Marie Gleize, Poésie et figuration, Seuil, Paris, 1983, (p. 125, p. 165, ecc.).
- Pietro Manzoni, “Oggi il concetto di quadro…”, in Scritti sull’arte, Abscondita, Milano, 2013, p. 22.
- Yves Klein, Le dépassement de la problématique de l’art et autres écrits, Beaux-Arts de Paris, Paris, 2011, p. 49.
- Daniel Buren, Les Écrits. 1965-2012, vol. I, Flammarion, Paris, 2012, p. 31.
- Francis Ponge, Méthodes, Gallimard, Paris, 1961, pp. 277-278.
- Jean-Marie Gleize, Poésie et figuration, op. cit., p. 238.
- Francis Ponge, Méthodes, op. cit., pp. 282-283.
- Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Mondadori, Milano, 2010, p. 461.



L’articolo chiarisce molto bene i termini della poetica ormai consolidata e molto diffusa della cosiddetta prosa in prosa, dando modo di reagire negativamente al fenomeno – e di questa chiarezza quindi non si può che essere riconoscenti alla intelligenza di Inglese. Ovvero, si chiarisce qui – senza circonvoluzioni depistanti – la presa di posizione dell’autore (in prosa e versi) Inglese e dei suoi molti affini. Oggetto unico possibile oggi della poesia sarebbe il realismo integrale, la letteralità. La necessità di una iconoclastia radicale dell’immaginario letterario, e più genericamente culturale, otto-novecentesco, è certamente fondamentale. Il passaggio di secolo è sempre stato un momento iconoclasta nella storia della cultura occidentale, ma l’ultimo, il passaggio di millennio, è stato particolarmente forte e è ancora in corso. Il crollo delle Torri Gemelle Europa-Stati Uniti, ancora in corso (e si spera in rapido esaurimento perché non se ne può più di Europa e Stati Uniti per come sono) non può che esprimersi con una altrettanto violenta iconoclastia. Cosa se ne farebbe oggi la poesia delle figure letterarie e retoriche di un millennio finito e finito in merda? Si prova effettivamente un disgusto profondo per i linguaggi fioriti e dunque il desiderio del sogno iconoclasta sterminatore è certamente in pari coi tempi, con il nostro tempo occidentale esauritissimo. Ma pensiamo sia davvero sostenibile, letterariamente e soprattutto filosoficamente, l’asserzione dell’esistenza di una poesia dotata del “linguaggio della verità letterale” senza “ambiguità”? Cosa è la verità letterale? Dovremmo metterci la maiuscola e parlare di Verità Letterale? La “postura” poetica ed epistemologica che pretende di dirci quale è la verità integrale del mondo, addirittura letterale e senza ambiguità, è condannata a due esiti: la tautologia banalissima e sterilissima (vedi la cosiddetta poesia e narrativa di autori in-significanti quali Gilda Policastro), l’impostura radicale. L’impostura radicale e la banalità tautologica sono gli orizzonti in cui si esaurisce, ad una prima annoiata lettura, la stragrande maggioranza dei libricini ispirati a questa, citando il Gadda poco amante delle franciosate, “scorreggia d’Oltralpe” della “prosa in prosa”.
Due cose Rosaria, per incominciare (e magari anche per finire).
Tu scrivi: “L’articolo chiarisce molto bene i termini della poetica ormai consolidata e molto diffusa della cosiddetta prosa in prosa, dando modo di reagire negativamente al fenomeno – e di questa chiarezza quindi non si può che essere riconoscenti alla intelligenza di Inglese. Ovvero, si chiarisce qui – senza circonvoluzioni depistanti – la presa di posizione dell’autore (in prosa e versi) Inglese e dei suoi molti affini. Oggetto unico possibile oggi della poesia sarebbe il realismo integrale, la letteralità. La necessità di una iconoclastia radicale dell’immaginario letterario, e più genericamente culturale, otto-novecentesco, è certamente fondamentale.”
Ebbene, ho da tempo capito che, anche in ambito letterario, valgono, piacciono, “pagano di più”, le semplificazioni, i contrasti forti, il bianco e nero, anche perché lo spirito del tempo vuole che si scrivano delle cose come si gioca una partita, per sollazzare eventuali lettori, o anche solo addetti ai lavori, perché uno riconosca bene quali squadre sono in campo, con quali magliette, e per chi tifare.
Ora l’intervento che tu hai letto ha l’enorme limite di non seguire questa tendenza, per cui invece di essere un manifesto di poetica mia, è una riflessione articolata e critica su cosa potrebbe voler dire, oggi, una poetica della “littéralité”. Questo testo si puo’ leggere semmai, come un’autocritica della propria poetica – mettiamo la prosa in prosa – ma con l’intento non di liquidarla, bensi di renderla ancora più acuminata. Naturalmente se la domanda che qualsiasi lettore si pone di fronte a questo testo è: ma Inglese sostiene la prosa in prosa si o no? ha la maglia rossa o quella bianca?, allora è chiaro che quanto ho scritto è quasi inutilizzabile.
Io vengo da quella esperienza (prosa in prosa), vengo da quell’ideologia del testo, ma ho fisiologicamente bisogno d’interrogare criticamente anche la mia ideologia del testo, non solo quelle degli altri. Solo che dubito che una della affermazioni proposte all’inizio del mio intervento sia cosi serenamente accoglibile, ossia che non esiste testo, nel regime moderno (e post e tardo) della letteratura, che non si rifaccia in un modo o nell’altro a qualche forma di ideologia. Quindi se si vuole parlare non solo di tifo tra poetiche, ma anche di teoria e poesia, si potrebbe aprire uno spazio di riflessione sui i differenti presupposti che stanno alle basi delle differenti poetiche. E’ quanto ho cercato di fare per quanto mi riguarda, per “la poetica che mi riguarda”. Ma il tuo intervento, Rosaria, mi dimostra che l’operazione non è stata compresa. Ti invito quindi a rileggere con più attenzione, e meno ansia calcistica, il testo.
Prendo atto, poi, della tua avversione un po’ indeterminata per: la linea francese della letteralità (Gleize & company), gli autori più verosimilmente legati al progetto “prosa in prosa”, Gilda Policastro, e la stragrande maggioranza dei libricini ispirati alla “letteralità”. E la tua avversione non posso dire che mi dispiaccia. (Aggiungo perché sia chiaro: non mi dispiace che tu avversi il nostro lavoro indistintamente. Cio’ conferma quello che già so: abbiamo ben poco in comune sul modo di concepire la poesia. Amen.)
Che la letteralità sia entrata a far parte stabilmente della letteratura, a fianco di una necessaria riflessione sulla produzione e condivisione della testualità da parte degli autori nell’epoca attuale, è un fatto da tempo acclarato. Non poteva essere altrimenti, ed è giusto che il fenomeno debba essere continuamente studiato. Mi colpiscono però alcune parole dell’intervento di Rosaria, e mi colpiscono perché mi trovano pacificamente d’accordo: lei parla di “prima annoiata lettura”, di “libricini” e soprattutto di “stragrande maggioranza di libricini”, che sono tutte questioni collegate tra di loro e che contribuiscono secondo me a spiegare anche “l’impostura radicale” e la “banalità tautologica”. Da parte mia mi sono sempre chiesto perché le nuove pratiche testuali, pienamente necessarie, fiorendo a fianco delle vecchie forme di legittimazione abbiano scelto di “fare contrasto” secondo gli stessi criteri delle vecchie forme di legittimazione. Perché abbiano voluto costituirsi come squadra di calcio nel derby delle istituzioni editoriali. Trovo la circolazione dei soliti nomi abbastanza asfissiante, anche le intonazioni di lettura dei nuovi autori di questa “parte” si stanno spaventosamente (è l’effetto che subisco io) uniformando. All’esattezza e necessità dell’analisi teorica/estetica non vedo seguire nuove scelte politiche. Ci sono autori della casta della prosa in prosa (dico semplicisticamente per brevità, mi si perdoni per questo) che pubblicano libricini a spron battuto, che tra l’altro costano quanto libri di poesia più canonici, se non di più, rendendo difficoltoso, almeno per me, seguire poetiche e voci molto interessanti. Mi domando perché la letteralità debba aver paura di parole che hanno la sola colpa di essere state “orfiche”, “innamorate”, di essere state metafore in epoche passate. Non vedo attenzione, per esempio, per piattaforme underground come Tumblr, dove il discorso teorico della letteralità e l’ibridazione con forme poetiche classiche sono recepiti e praticati quotidianamente e in maniera democratica (lì, con autori altrettanto validi, nuove forme di legittimazione potrebbero ricevere un respiro più ampio se fatte dialogare con gli inevitabili e necessari “insiders” delle istituzioni editoriali).
Mi scuso, Andrea Inglese, se ho preso spunto dal suo intervento per queste mie considerazioni. Lei, d’altra parte, si dimostra sempre critico e autocritico in questa divisione netta tra vecchio e nuovo paradigma, e proprio per questo sento il bisogno di chiedere a lei lumi o riflessioni (anche future) su questo inesistente nuovo coraggio politico generale. Sono forse tempi tuttora troppo acerbi?
estrapolo ……questo inesistente nuovo coraggio politico generale. Sono forse tempi tuttora troppo acerbi?….
Massimo Stirneri,
faccio fatica a capire il tuo discorso. Quello di Rosaria, per me, è più semplice da capire. Non ha mai digerito che ci fosse una realtà importante e nuova, in un territorio in cui credeva probabilmente di avere un ruolo predominante (la ricerca letteraria). Nel tuo caso, oltre la solita stizza nei confronti “dei soliti nomi”, che sono accusati di pubblicare, e magari di avere delle poetiche comuni, e magari anche una posizione critica nei confronti di altre poetiche – tutta roba che fa parte un po’ fisiologicamente dello scrivere, che sia poesia o qualcosa di dissimile… dico nel tuo caso aggiungi anche un discorso “politico” che mi sfugge. Parli di democrazia, di insiders delle istituzioni editoriali. Ma le istituzioni editoriali sono le piccole case editrici che si prendono il rischio di pubblicare dei libri, anche se non hanno la potenza della grande distribuzione. E gli insiders è gente che scrive da vent’anni, su blog, riviste, organizza, fa e disfa, e quindi magari ogni tanto pubblica pure un libro. Per il resto, la scrittura non è un diritto. Essere pubblicati non è un diritto. Non puo’ essere trattato in questi termini rassicuranti. E’ un rischio. Nessuno ti ha chiesto le cose che scrivi. Se arrivi a convincere qualcuno a leggerle e a fartele pubblicare, è già una gran cosa.
Andrea Inglese,
mi scuso, mi sono accorto di non essere riuscito a centrare il punto, e questo per aver voluto esprimere con troppa fretta considerazioni personali di lungo corso. Ancora peggio, le sono apparso come una persona stizzita nei confronti dei nomi della prosa in prosa. Lungi da me tutto questo. Il suo intervento riguardava la teoria & la poesia, e io condivido pienamente le considerazioni su integrità ed emancipazione. Apprezzo il modo con cui lei ha fatto vibrare questi termini tra due poli necessari quali sono stati Gleize e Ponge – necessari non solo per la scrittura di ricerca come si sta configurando nell’attuale panorama italiano, ma anche per la poesia che siamo soliti considerare secondo forme più canoniche e riconoscibili. Mi domandavo semplicemente (sperando di essere più centrato stavolta) quali forme di legittimazione alternative alla tradizione questo rifiuto (semi)totale della rappresentazione in nome di un affresco più veritiero della nostra epoca avesse deciso di adottare o di esplorare. Mi sembra, se non ho letto male, che anche lei si pone il problema della legittimazione all’inizio dell’articolo.
Se la realtà è presa “alla lettera”, se la realtà è più complessa dell’interpretazione fallace del singolo, come facciamo a convergere sulla “qualità” di un determinato autore? Ha ancora senso parlare di qualità, e se sì, in quali termini? Le piccole case editrici, quando prendono i propri rischi, parlano di qualità? Nell’ambito delle scritture di ricerca, quanta ricerca delle scritture si fa? Si ragiona per dottrine o si ragiona per opere ispiratrici (non solo, spero) di dottrine?
Chiedo non stizzosamente: c’è un rischio che l’autore, l’editore, l’indottrinatore convivano nella stessa persona? Quanto è esteso oggi questo rischio? Si può parlare di prove più e meno riuscite tra le opere che uno scrittore di ricerca ha il merito di farsi pubblicare?
Ci sono oggi, per usare un’espressione montaliana, “scrittori di ricerca laureati” che si muovono lungo l’elenco completo dei nomi delle piante letto con merito tutto d’un fiato durante le presentazioni?
Chiedo e mi chiedo questo (e altro) da molto tempo non per rivendicare il diritto di tutti a essere pubblicati. Ci mancherebbe. Per me la questione sta tutta dalla parte della lettura e della leggibilità del mondo. E il mondo non è tutto accademico. L’attenzione accademica alle nuove e necessarie scritture (che vengono da lontano e devono andare lontano) ha come contraltare nel mondo oceani di disattenzione e di lettura sbrigativa, superficiale. Eppure sempre si vuole definire l’ambito di legittimazione. Ed è giusto.
Di innumerevoli pratiche e testualità nessuno domanda niente, è una decisione personale, è l’assunzione del rischio. Ma delle scritture di ricerca attestate, della poesia attestata, degli autori attestati e meritoriamente pubblicati, io chiedo con semplicità e umiltà qual è la differenza, come agisce il testo, come posso insediarmi in esso, come mi fa agire, quanto mi rende inospitale (od ospitale) il mondo, inospitale il mio stesso vocabolario. Siccome però anch’io, da non scrittore, aspiro a integrità ed emancipazione come sforzo culturale, chiederò in un secondo momento: perché proprio quell’autore è stato legittimato a raggiungermi? – e: sarà stato legittimato legittimamente? – e: le politiche di legittimazione saranno al passo con le testualità del mondo che scorrono per essere lette?
La mia, insomma, non era invidia per gli scrittori pubblicati. Era invidia per i teorici che possono indagare più assiduamente di me e mettendo a punto strumenti di gran lunga migliori le possibilità che tutte le scritture, vecchie e nuove, implementandosi, mettono a disposizione ora.
Grazie di aver voluto chiarire, e in effetti ora il discorso mi risulta più chiaro, e anche tocca un nodo vero e forte.
“Si può parlare di prove più e meno riuscite tra le opere che uno scrittore di ricerca ha il merito di farsi pubblicare?”
e
“perché proprio quell’autore è stato legittimato a raggiungermi? – e: sarà stato legittimato legittimamente? – e: le politiche di legittimazione saranno al passo con le testualità del mondo che scorrono per essere lette?”
La domanda (la prima) è ovviamente legittima, ed è anche vero che , nell’ambito delle scritture di ricerca, è un po’ più imbarazzante forse che in altri ambito, per tante ragioni che sarebbe anche lungo dire. Per l’importanza che hanno i procedimenti, per il fatto che si vuole sfuggire ai criteri di letterarietà esistenti, ecc. Ma la domanda rimane comunque pertinente. Nel modo più chiaro e esplicito dovrebbe essere compito della critica arrischiarsi a rispondere a questa domanda. Ma una critica che sappia almeno accettare la legittimità delle scrittura di ricerca come “autentiche” scritture dentro quella pluralità di cose che è la poesia contemporanea. Spesso pero’ i critici partono già delegittimando l’intera famiglia di scritture, quindi diventa poi difficile distinguere prova da prova.
Sulla seconda domanda. Chi legittima i legittimatori? Innanzitutto oggi sono indebolite tutte le forme istituzionali di legittimazione letteraria, e questo per un’evoluzione generale del sistema culturale ancor prima che di quello letterario, e io ho già scritto che questo indebolimento per certi versi mi sembra una buona cosa. Ma non credo neppure che tutto si equivalga, e inoltre rimangono istanze legittimanti, e già noi leggendo e reagendo a quanto leggiamo, stiamo già contribuendo a questo processo. E a questo punto mi rendo conto che la mia risposta esigerebbe in realtà un lungo sviluppo, praticamente un saggio. Ma spero di aver almeno contribuito a chiarire questo meccanismo facendo appunto, nell’articolo, riferimento alle ideologie del testo.
“… una critica che sappia almeno accettare la legittimità delle scrittura di ricerca come “autentiche” scritture dentro quella pluralità di cose che è la poesia contemporanea”. Sono completamente d’accordo.
Sulla seconda parte: spero di imbattermi sempre più spesso in interventi critici che problematizzano la questione. (Anche) la scrittura di ricerca deve fare problema per un autore, essendo esposta a una serie di contraddizioni (anche) per la sua adamantina aderenza al reale e uniformità di strategie testuali. Ribadisco solo due punti: 1) se decidiamo di escludere l’interpretazione classica che ci espone al rischio di ricadere – schiavi – in veteroarchitetture mentali e culturali, con cosa sosteniamo e validiamo ora il momento della lettura/leggibilità dei testi e delle proposte letterarie? 2) se le nuove strategie testuali si pongono in modo tautologico come dispositivi di reazione nel quotidiano delle scritture (mostrando quindi che il cambiamento è già pacificamente acquisito e praticato ad ampio spettro), se l’indebolimento è generale e investe inevitabilmente anche la ricezione del “fatto poetico/letterario”, come giustifichiamo la necessità di porre tutta questa attenzione al fenomeno? quali conseguenze finora inedite sta delineando? quali decisioni possono essere spinte finalmente a prendere, da indebolite e indebolendole ancora, le forme istituzionali?
@Andrea Inglese,
In merito alla sua frase: “Non ha mai digerito che ci fosse una realtà importante e nuova, in un territorio in cui credeva probabilmente di avere un ruolo predominante (la ricerca letteraria).”
Qual è questa realtà importante e nuova?
Gli autori di “Prosa in prosa”, e diversi altri che assieme a loro hanno creato e animato gli incontri e le pubblicazioni di EX.IT.
Se leggo Gleize trovo i nomi di Artaud e di Maurice Roche, ad esempio. In Italia, mi pare che, invece, si ripeta la lezione in stile universitario, per cui si finisce per parlare, perché si deve, di Denis Roche e Tarkos, autori che pochissimi hanno letto, perché poco, quasi nulla, tradotti (“Louve basse” fu tradotto da Spirali in anni non sospetti) e di cui altri ripetono solo i nomi. Se leggo Gleize trovo riferimenti a Tel quel, TXT di Prigent (chi ha mai avuto l’idea di tradurre i suoi saggi letterari?), al “Nouveau roman”. Se leggo Gleize capisco “Basta poemi”. E “Basta romanzi”. Mi chiedo allora come si concilia tutto ciò, ad esempio, con un titolo come “Parigi è un desiderio”. “Basta poemi”, come si concilia con un titolo così poco oggettivo e letterale. Il romanzetto dalla copertina ammiccante come si concilia con la “littéralité”? Sinceramente trovo anche molta piaggeria nel tuo saggio, prima di tutto verso Gilda Policastro, che per illuminazione dall’alto sembrerebbe aver scoperto le scritture francesi (ma anche recensito “Parigi è…”). Ora, non la si può scambiare per Sanguineti, che scriveva buoni saggi letterari sulle scritture francesi, conosceva Tel quel e traduceva. Oggi sono fossilizzati su Blanchot. Possiamo anche continuare…
Organismi fragili sono anche organismi mutevoli, disponibili alla trasformazione. Il problema è che spesso non vengono riconosciuti dalle istituzioni storiche che si occupano di incarnarli. O meglio queste istituzioni continuano a forzarli nell’identità e nel nome che essi hanno già mutato, senza rendersi conto che non solo le funzioni di trasmissione di senso vengono comunque esercitate a prescindere dal nome, ma anche che a volte è davvero opportuno che il nome cambi per cercare di seguire in qualche modo plasticamente e sensatamente il cambiamento.
Riponi girano voci che sei l’incarnazione di Ghérasim Luca, ma alcuni sostengono William Blake. Chi ha ragione?
Ha ragione Gleize quando apre il suo libro su Ponge dicendo che «Il est toujours, et depuis toujours, incessamment le contraire de ce qu’il est»… leggere la lista… da «chantre subjectif de l’objectivité… communiste solitaire… protestant baptisé… franciscain… telquelien… disciple foudroyant de Mallarmé» per finire al «petit autoportrait de l’artiste en escargot : Seul, évidemment l’escargot est bien seul…»… non ha bisogno di «amici» per la sua felicità…
Caro Andrea, la mia risposta al tuo interessante articolo sarebbe troppo articolata per apparire in un commento. Ti ho risposto qui: http://www.guardareleggere.net/wordpress/2018/07/14/la-letteralita-impossibile-risposta-ad-andrea-inglese/
Caro Daniele, ti leggo. Ma sono nelle due sacre settimane di dovuta sconnessione, quindi avrai ritorni non immediati. In ogni caso, grazie di aver letto, discusso e linkato il tuo intervento.
Se ho capito bene, questo saggio segue la compiutezza testuale? Storicizzare è marcare una differenza o prendere una distanza. Il saggio è come al solito molto interessante, Inglese possiede una vena sentimentale che presta vita anche a robe del tutto inanimate, ma la vita è la sua e come in altri lidi, dove si parla di questioni poetico-letterarie come di scambi tra ministri degli esteri, mi pare emerga al fondo una rivendicazione sindacale, di ruolo prima che di testi, che peraltro nessuno nega. E’ che nessuno più si occupa di queste robe a questo livello, quantomeno in ambiti anglofoni e quindi nelle province imperiali come questa italiana. Vedo qui un po’ la situazione dei filosofi della scienza, stretti fra gli storici della scienza (che lavorano sul passato ed hanno un mappamondo finito) e gli scienziati (che lavorano nel presente ed hanno il riscontro del capitale): cosa resta loro, quale compito svolgono? Lavorano per informare il futuro, viene detto loro alle conferenze. Se non poeti, allora, quantomeno filosofi della poesia. Saluti e buona estate.
Giusco, idem come sopra. Ma il tuo commento, mi ricorda (da sentimentale) i bei tempi dei thread dalla “coda lunga”. Saluti a te.