Piegare e stirare versi: il blues di Eugenio Lucrezi e la disciplina del bucato
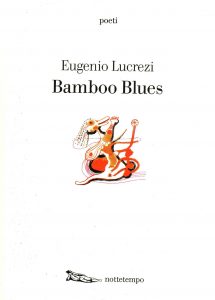
di Giulia Niccolai
La nuova raccolta di poesie di Eugenio Lucrezi, edita da Nottetempo, ha titolo Bamboo Blues, in omaggio alla grande Pina Bausch e al suo omonimo spettacolo. Così, come in una sezione del volume – una serie di testi dedicati tutti a quei personaggi che, con la loro bravura e la loro arte, hanno profondamente emozionato l’autore – vi è una poesia dallo stesso titolo, con dedica “a Pina Bausch, in mortem”. Due versi di chiusura ci lasciano meravigliati e grati: sanno rivelarci, in pura semplicità, l’essenza della sua magia: «…a Pina in un istante, / e sei tutta abbraccio intorno al nulla, concentrata.»
Ma Bamboo Blues, per il piacere uditivo dell’assonanza, è anche il doveroso segnale del fatto che, amando Eugenio le parole del quotidiano e il come finiscano con l’intrecciarsi, combinarsi e giocare tra loro, anche visivamente assurte a materia, (non solo suono e fiato), esse abbiano, per lui, qualcosa di meravigliosamente trasparente, luccicante e guizzante come biglie che si inseguono dentro e fuori le gallerie di un castello di sabbia: «… il sospirato bip del tuo segnale / sanbernardo cordiale» (L’arte della conversazione); «Pensiero, non posso / esimermi dal pensarti» (Pomaia, in Dittico toscano del vuoto); «Sei nata numerosa / nessuna delle dita si riposa» (Illustrando la Divina Commedia); mentre «un gran soffione d’aria nel vestito» ci fa vedere un Angelo del Pontormo. Due versi, in un testo di infinita ammirazione per Maria Callas e la sua voce intitolato Giardino (M. C.), sono, come quelli dedicati a Pina Bausch, assolutamente magistrali: «Voce della corrente, pieghi e stiri / la disciplina nei pozzi della mente». Così, per contrasto (?), quando ho letto Parola cuscino, quale titolo di una sua poesia, e in conseguenza di ciò, mi è capitato di vedere subito, nell’occhio della mente, l’immagine di un bambino che abbraccia con amore il proprio orsacchiotto, mi sono sentita in dovere di scrivergli che doveva essere uno degli uomini più felici della terra, dato che provava una tale gratitudine per il suono e la morbidezza di un oggetto al quale nessuno pensa mai, perché lo diamo tutti per scontato. Ha avuto la faccia tosta di rifiutarsi di ammettere la propria felicità!
Eppure, secondo me, solo una persona aperta, e ripeto, tanto a p e r t a alla vita, da sapersi ancora meravigliare, a sessanta e passa anni, per la parola “cuscino”, può riuscire a scrivere “pieghi e stiri la disciplina…” a proposito della Callas. Per quanto mi concerne, se io poi faccio l’esempio del cuscino, in relazione al “pieghi e stiri la disciplina” e aggiungo: “si tratta sempre di bucato”… questo mio umorismo vuole solo “abbracciarli” entrambi, con gratitudine e complicità. Nei confronti della poesia di Eugenio, della vita stessa. Perché la vita è proprio “quella cosa lì…”.
Così, a proposito del suo rifiuto di venire da me definito “felice”, mi sono vendicata, scrivendogli, che l’illustrazione più corretta per la sua raccolta sarebbe stata il logo delle edizioni Nottetempo, quel signore sdraiato per terra, scalzo, con un Borsalino in testa, che fa pensare agli anni Cinquanta e a Cary Grant in Costa Azzurra, tanto è sicuro di sé. Ecco, da vecchi (lo sono, 83), si può avere, a volte, l’impressione di portarsi dentro un carico eccessivo di memoria, conoscenze, immagini ecc., una sorta di Big Mac di storia, mitologia, film, libri ecc. che, in certi momenti di scrittura e concentrazione, si fanno tutti vivi, per farsi avanti e macchiarti la camicia.
Lui, invece, zitto, anche ‘sta volta.
Poi, c’è anche da tener presente il ritmo di certi suoi versi, la prorompente energia, come in Dietrofront, dove tutti i termini della parte centrale del testo, privi di articoli, ci fanno accelerare la lettura fin quando, arrivati alla fine della poesia, dobbiamo ricominciare tutto da capo, compitando, per poter anche capire. Questo, per spiegare l’abilità della sua tecnica, perché ovviamente, il contenuto stesso del poemetto esige proprio questo da noi: un galoppo sfrenato che ci costringa poi a tornare sui nostri passi.
I trabocchetti che Eugenio semina in continuazione danno rigore ai suoi testi “lirici” che non sono mai consolatori, piuttosto ci costringono a meditare. Un suo verso della poesia intitolata Paradiso mi ha fatto capire per la prima volta che ci sono le “mani” nella parola “anima”.
Vorrei citare, in chiusura, due blocchetti di versi dal poemetto Gran Paradiso, dalla Mole Antonelliana (beh, sì, pensa anche in grande), per avere l’ultima parola a proposito della sua personale felicità e della sua capacità di trasmetterla ad altri: «…del bacio che ci demmo come tanti / in un chiostro d’aprile in mezzo ai teschi». Proprio questo tipo di contrasti (nonché il suono di chiostro/teschi), rendono vivissimo il testo e felice il lettore, costretto a ridere, a essere grato all’autore, perché appunto l’antitesi è l’essenza e la beffa della vita che noi tutti conosciamo.
Dopodiché: «… qualche cosa / trova forte radice, ed una mano/ fa presa sulla roccia. Docilmente/ seguo i chiodi e le funi». Ah, la bellezza di quel “Docilmente”!
Poesie da Bamboo Blues
a Pina Bausch, in mortem
Bamboo Blues
Non credo a quel che vedo, la fotografia
scattata quasi a caso, di pomeriggio,
a te che prendi il vento negli ariosi
capelli, e ad Agropoli muovi un impercettibile
passo di danza, torcendo
appena un poco il busto mentre alzi
le braccia all’altezza del viso che si profila
di spalle nel cielo caricato
di sole e di calante azzurrità commossa
e respirante fiati e fiati di vite
diffuse e riposanti nei filacci
d’estate, ad occhi chiusi a fresco,
in memoria del mare,
con le ascelle che bevono luce
moderata alla fine, che accoglie
la grazia del tuo passo, e di tuo figlio
che ti guarda da presso,
dice l’amore incredulo che piangi
a Pina in un istante, e sei tutta
abbraccio intorno al nulla, concentrata.
L’arte della conversazione
E sì che l’arte della conversazione
mi vede sempre in bilico su lame
taglienti e scivolose dalle quali
precipite soccombe l’asserzione
nelle valanghe del non so dove.
Tramortito, rinasco se ritrovo
a fondo valle, nelle morene,
il sospirato bip del tuo segnale,
sanbernardo cordiale; e se considero
l’inservibile arnese della voce.
Pomaia
Arti nel sonno,
punti di rosso
pungono il bianco
come chele di granchio.
Punto su punto
tesse rime.
Pensiero, non posso
esimermi dal pensarti.
Illustrando la Divina Commedia
Il tuo pregio consiste
− parlo di te che pitti, mulier faber,
nell’aprire una luce al suo destino.
L’apparenza persiste, la sai fare
cattura inveterata della retina.
Trama miracolosa
che raccatta, dimentica, rispolvera,
l’epifania di care cose morte.
Sei nata numerosa,
nessuna delle dita si riposa.
Amo da pesca, lenza
che lanci con perizia al pesce-cuore
Smarrimento perenne,
ricorri al fissativo se ristretta
in lacrima trabocchi
dal marmo raggelato di acquasanta.
Angelo del Pontormo
Nube. Nubesco. Potenza delle ali.
Testa rivolta ai venti della volta.
Un gran soffione d’aria nel vestito.
Sono nube di guerra. Non sorrido.
Vento che ti schiaffeggia. Non mi vedi.
Arrivo nel gran peso delle ossa.
Non c’è buco che tenga la caduta.
Angelo dell’intonaco, sono orma
della grazia sul ponte, sono inchino
di veleggi rigonfi al paradiso
chiuso nella navata.
Nel giardino ( Maria Callas )
E dunque non era questo possibile,
che durasse nell’aria l’espressivo
ricorso delle onde che ci tengono
in contatto a distanza, e in qualche caso
ci spingono, nonostante noi stessi,
nel non creduto giardino dove suonano,
se ti conservi attenta, quanti
di grazia che si spende in levità
e in moto di accoglienza, e pure suonano
infinitesime particelle tristi,
fuori frequenza, che per tanto stonano
impercettibilmente, rincorrendo,
con aria d’immanenza, l’immortale
morte, qui nell’adesso insopportabile
che gioca di posticipo un delay
che non finisce mai.
E’ inutile perciò cercare le ragioni
tra i fogli degli appunti, o nel respiro
costellato di spume dell’Egeo.
Si tratta di ridare fiato al vento,
gli studi e le fatiche alla navale
prora elegante, proprio mentre affonda.
Tu non ti eserciti, dopo che hai provato
a stare dalla parte delle scale.
C’è un loggione che freme, che si chiede
dove ti affondi quando te ne vai.
Voce nella corrente, pieghi e stiri
la disciplina nei pozzi della mente.
Smetti e subito parli del silenzio,
ne parli quieta, come fosse niente
deporre l’ardimento nella terra,
l’aria delle frequenze nel giardino.
Parola cuscino
Non c’è sussurro, il fiato
si libra liberando nessun suono,
s’inanella voluta su voluta,
ad astra sale su fino al soffitto.
Accanto è lontanissimo, se vuoi
starmi molto vicino.
Gli occhi di chi, che siano aperti o chiusi,
sconfinando si superano?
Notti così, è pieno l’Universo.
Tienimi sul cuscino, non disperdere
i fondali stellati, non cadere,
in preda alla vertigine, oltre il bordo
nebulare del letto.
Dietrofron
Può darsi che l’esattezza
dei versi, che molti degli scivoli
ben oliati che rapide consegnano
le parole all’opaco
sentore dell’eterno,
in una valle di suoni e vividezze,
mentre ripetono magnetici indistinti
clamori ripetenti, misti di
voci viventi e sogni mal finiti
dai passati remoti,
tutto ciò che si leviga può prendersi
vacanze inusitate, e consegnare
brevi volumi al giorno che riprende
la breve luce e la voce solista
di un evento caduco, rigirando
il carro sui binari, e riportando
l’infinito al finito, e l’eufonia
raggelata del senso al batticuore.
Paradiso
Il gran ristoro di cui parli, vuoi,
senza che veda il vento lanciasassi
di ghiaccio, punteruoli che trapassano
angeli inconsistenti che trattengono
bave di carne, se la neve sfrangia
bandiere di nazione paradiso.
Desolazione di cui parli, vuoi,
in questa notte di buio abbagliante.
Inizia la visione dove cessa,
per eccesso ipotermico di luce,
la febbre figurale del racconto.
Non sai che farne, sconfino dello sguardo.
Sai che non puoi tentare una ventura
con animo di volpe che leggera
lascia sul manto passi inapparenti.
Fuggono ad una ad una, le figure,
anche quelle viziate dalla luce
in una posa illogica, di affanno.
Anima su due zampe che saltella,
t’inoltri, bianca lepre senza manto,
sulle coltri sottili.
In fondo, dove
non c’è niente da fingere, ti aspetta,
mite, la dedizione ad una carne
di quelle che non mangi per rifiuto
di chi non ti appartiene, e che non vuoi.
Gran Paradiso, dalla Mole Antonelliana
Così fa bellavista dell’eterno
lo scorcio appena schiuso, ridente,
della tua chiostra dentaria, bianca
come velo di suore, e tuttavia
afflitta da appuntamenti mancati,
per fretta e distrazione, col dentista,
e pure con la gioia inusitata
del bacio che ci demmo, come tanti,
in un chiostro d’aprile, in mezzo ai teschi.
La vista è reversibile, ambidestra,
siamo inabili e lievi, mentre il velo
dell’apparenza s’inerpica.
Non so quando, se ieri,
se alla fine dei tempi, se forse
nel freddo siderale. Qualche cosa
trova forte radice, ed una mano
fa presa sulla roccia. Docilmente
seguo i chiodi, e le funi.
Eugenio Lucrezi, Bamboo Blues, Nottetempo, Milano, pp.96, € 10.

