Le assenze di Enrico De Vivo
di Marino Magliani
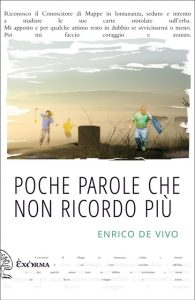 Ho un file, da buon ligure ogni volta lo riciclo, si intitola Assenze, non ricordo da quale racconto o sottititolo provenga. Mi dico lo sapevi che prima o poi veniva a taglio. In effetti, se devo trovare un titolo a questo romanzo di Enrico De Vivo, Poche parole che non ricordo più (Exorma, 2017), uno migliore non potevo trovarlo. Ma assenze presume che al testo manchi qualcosa. Vediamo dunque cosa manca… Il paesaggio? La musica? No, inizia con due mani sul pianoforte che accompagnano le onde… Ogni pezzo di questo libro è come un quadro la cui cornice si intreccia a un altro quadro, ma non sullo stesso piano, come se dal precedente procedesse in discesa, e le onde scendessero disciplinatamente e miracolosamente da un muro. E ogni pezzo, senza aver la presunzione di farlo, è come se portasse dentro la memoria del precendente, tant’è che Gargiulo, l’eroe forse, non perché vive per primo, ma perché in un modo o nell’altro lo lasciamo che scappa dagli aggressori all’inizio e mentre leggiamo vorremmo solo salvarlo, tant’è che Gargiulo è quasi sempre lì sul punto di riapparire e tarda ma poi riappare, e allora tutto si lega, anche la mano destra e quella sinistra che suonano all’inizio. Ma vediamo dunque cosa mancava… Il paesaggio? No, abbiamo il Sud polveroso, con i paesi e le sterpaglie, gli sterrati, le rovine, rive di laghi e laghi e la città. Mancano i personaggi? Neanche, il romanzo è un’antologia, un festival di personaggi, abbiamo Gargiulo, il fratello che non abbiamo mai avuto, e le signore di colore e gli sciancati, abbiamo Rossana (“Rossana aveva l’aspetto di una maga nordica dall’età indefinibile, dotata, allo stesso tempo, di tutta la bellezza e l’inquietudine della gioventù e della vecchiezza”), abbiamo i cani bianchi e i poeti-filosofi e forse sì, a questo punto compaiono alcune assenze (“Nel futuro, per una disposizione legislativa, sarà vietato leggere e scrivere. Non esisteranno più librerie, scrittori, lettori. Sperdute in posti lontanissimi, sopravvivranno soltanto delle tipografie-samizdat”), ma questo succederà solo nei sogni. Poi ci sono gli abitanti delle rive del lago, l’instancabile Conoscitore di mappe, etnografi, e uccelli dall’espressione serena, e persino l’omino rotondo, Kurz il camionista, e non menziono gli amici fragili e incredibili dell’io narrante che scendono in campo in seguito. Di quale assenze si parlerebbe dunque, quando si parla di Poche parole che non ricordo? Assenze di una trama, di storie? Non direi, in qualche modo abbiamo fughe e viaggi e cose che succedono e si succedono e abbiamo la comicità, eppure sì, continuiamo ad ammettere che c’è un’assenza. Non è forse che De Vivo ha semplicemente scritto una storia assente, come se fosse andato a prendere un treno e gli avessero detto brav’uomo il treno è già passato, sediamoci qui al fresco sotto il porticato del primo binario e raccontiamocene una? No, non è neanche questo, caro Enrico De Vivo, che non la conosco, se non per averle scritto una volta per il suo Zibaldoni, il fatto è che qui non è che il treno è passato, ma è che leggere Poche parole che non ricordo più dà quell’incredibile e bellissima sensazione di essere stati in un luogo dove non mancava nulla, e non sapevamo cosa, nulla è assente, c’è il paesaggio, la gente, il sole, le rive del lago, persino le tipografie, e ci siamo noi che però siamo andati a prendere il treno e non c’è più la stazione, e uno si siede lì sulla catasta di traversine e binari e i libri che si vorrebbero leggere in treno sono questi, diceva qualcuno, ogni tanto alzare gli occhi e gettare uno sguardo sul paesaggio oltre il vetro e sentire la nostalgia perché non possiamo scendere e guardare.
Ho un file, da buon ligure ogni volta lo riciclo, si intitola Assenze, non ricordo da quale racconto o sottititolo provenga. Mi dico lo sapevi che prima o poi veniva a taglio. In effetti, se devo trovare un titolo a questo romanzo di Enrico De Vivo, Poche parole che non ricordo più (Exorma, 2017), uno migliore non potevo trovarlo. Ma assenze presume che al testo manchi qualcosa. Vediamo dunque cosa manca… Il paesaggio? La musica? No, inizia con due mani sul pianoforte che accompagnano le onde… Ogni pezzo di questo libro è come un quadro la cui cornice si intreccia a un altro quadro, ma non sullo stesso piano, come se dal precedente procedesse in discesa, e le onde scendessero disciplinatamente e miracolosamente da un muro. E ogni pezzo, senza aver la presunzione di farlo, è come se portasse dentro la memoria del precendente, tant’è che Gargiulo, l’eroe forse, non perché vive per primo, ma perché in un modo o nell’altro lo lasciamo che scappa dagli aggressori all’inizio e mentre leggiamo vorremmo solo salvarlo, tant’è che Gargiulo è quasi sempre lì sul punto di riapparire e tarda ma poi riappare, e allora tutto si lega, anche la mano destra e quella sinistra che suonano all’inizio. Ma vediamo dunque cosa mancava… Il paesaggio? No, abbiamo il Sud polveroso, con i paesi e le sterpaglie, gli sterrati, le rovine, rive di laghi e laghi e la città. Mancano i personaggi? Neanche, il romanzo è un’antologia, un festival di personaggi, abbiamo Gargiulo, il fratello che non abbiamo mai avuto, e le signore di colore e gli sciancati, abbiamo Rossana (“Rossana aveva l’aspetto di una maga nordica dall’età indefinibile, dotata, allo stesso tempo, di tutta la bellezza e l’inquietudine della gioventù e della vecchiezza”), abbiamo i cani bianchi e i poeti-filosofi e forse sì, a questo punto compaiono alcune assenze (“Nel futuro, per una disposizione legislativa, sarà vietato leggere e scrivere. Non esisteranno più librerie, scrittori, lettori. Sperdute in posti lontanissimi, sopravvivranno soltanto delle tipografie-samizdat”), ma questo succederà solo nei sogni. Poi ci sono gli abitanti delle rive del lago, l’instancabile Conoscitore di mappe, etnografi, e uccelli dall’espressione serena, e persino l’omino rotondo, Kurz il camionista, e non menziono gli amici fragili e incredibili dell’io narrante che scendono in campo in seguito. Di quale assenze si parlerebbe dunque, quando si parla di Poche parole che non ricordo? Assenze di una trama, di storie? Non direi, in qualche modo abbiamo fughe e viaggi e cose che succedono e si succedono e abbiamo la comicità, eppure sì, continuiamo ad ammettere che c’è un’assenza. Non è forse che De Vivo ha semplicemente scritto una storia assente, come se fosse andato a prendere un treno e gli avessero detto brav’uomo il treno è già passato, sediamoci qui al fresco sotto il porticato del primo binario e raccontiamocene una? No, non è neanche questo, caro Enrico De Vivo, che non la conosco, se non per averle scritto una volta per il suo Zibaldoni, il fatto è che qui non è che il treno è passato, ma è che leggere Poche parole che non ricordo più dà quell’incredibile e bellissima sensazione di essere stati in un luogo dove non mancava nulla, e non sapevamo cosa, nulla è assente, c’è il paesaggio, la gente, il sole, le rive del lago, persino le tipografie, e ci siamo noi che però siamo andati a prendere il treno e non c’è più la stazione, e uno si siede lì sulla catasta di traversine e binari e i libri che si vorrebbero leggere in treno sono questi, diceva qualcuno, ogni tanto alzare gli occhi e gettare uno sguardo sul paesaggio oltre il vetro e sentire la nostalgia perché non possiamo scendere e guardare.
NdR: Marino Magliani ha scelto il passo che segue da “Poche parole che non ricordo più” di Enrico De Vivo (Exorma, 2017), e lo pubblichiamo con il beneplacito dell’editore
«Solo ritmo e cadenze»
Quella sera d’inverno era andata a finire che io e Gargiulo scappavamo a bordo della sua scalcagnata vespa bianca. Scappavamo di notte, mentre uomini armati di bastoni ci inseguivano a bordo di un’Alfetta marrone. Gargiulo diceva che conosceva un posto sui Monti Lattari dove saremmo stati al sicuro: «Vedrai, li sperdiamo facile facile, parola di Gargiulo!».
Gargiulo era il mio amico musicista, vecchio amico d’infanzia, che aveva trascorso tanti anni in giro per il mondo a suonare il blues. Adesso era tornato e diceva che finalmente avrebbe potuto insegnarmi tutto quello che volevo, soprattutto come si diventa poeta, che in effetti era il mio sogno di gioventù. Per la verità, era un po’ di tempo che io non pensavo più a certe cose, e dunque di preciso che cosa volevo che lui mi insegnasse non lo sapevo, o forse non lo ricordavo più. Per me bastava che fosse tornato, ero già contento così. In ogni caso, per non dispiacergli, avevo preso a fargli domande vaghe sulla poesia, alle quali lui rispondeva sempre allo stesso modo, e cioè che si trattava soltanto di imparare a seguire ritmo e cadenze. «Solo ritmo e cadenze», ripeteva, poi tutto sarebbe venuto naturale, non mi dovevo preoccupare. Aggiungendo anche: «Ricordati che con le stesse parole si possono dire cose diverse».
Gargiulo era un analfabeta ignorantone, e sentirlo parlare in questi termini mi intimoriva e divertiva insieme. Ma il suo modo di fare aveva qualcosa di convincente, e infine avevo accettato di seguirlo. Mi aveva condotto in un piccolo cantiere edile deserto, in una stradina di campagna con il Vesuvio a nord-est. Era lo stesso cantiere – rimasto tale e quale – dove andavamo da ragazzi già ammalati della vita ad ascoltare la musica dallo stereo della sua Fiat 850 e a dare aria ai nostri sogni: io a quello di diventare poeta, lui a quello di diventare musicista blues.
Erano passati tanti anni, non saprei nemmeno dire quanti. Adesso faceva molto freddo, era dicembre. Avevamo acceso un fuoco in un androne scalcinato del cantiere e Gargiulo si era messo a sfogliare dei quaderni pieni zeppi di misteriosi segni. Dopo averli sistemati su un ripiano di legno sorretto da sei mattoni di tufo, aveva cominciato prima a parlare di luna e nenie notturne, poi a cantare dolcemente, con me seduto per terra di fronte a lui ad ascoltare. Ma era durato tutto pochi minuti, perché all’improvviso erano arrivati gli uomini armati di bastone con l’Alfetta marrone ed eravamo stati costretti a scappare.
Da quel poco che avevo avuto modo di capire in quei minuti, Gargiulo aveva imparato da autodidatta a trascrivere una specie di ideogrammi molto simili alle lettere dell’alfabeto fiorite di ghirigori e di figure che si vedono disegnate nei codici. Recitava questi segni ad alta voce, cantandoli come da una partitura, con un sottile filo di voce quasi impercettibile. «Questo è niente!», mi diceva infervorato nelle pause del suo canto. «Capirai il resto quando sarai in grado di decifrare anche tu i segni che si trovano qui dentro», e sventolava i suoi quaderni.

