Un mare di muri
di Daniele Comberiati
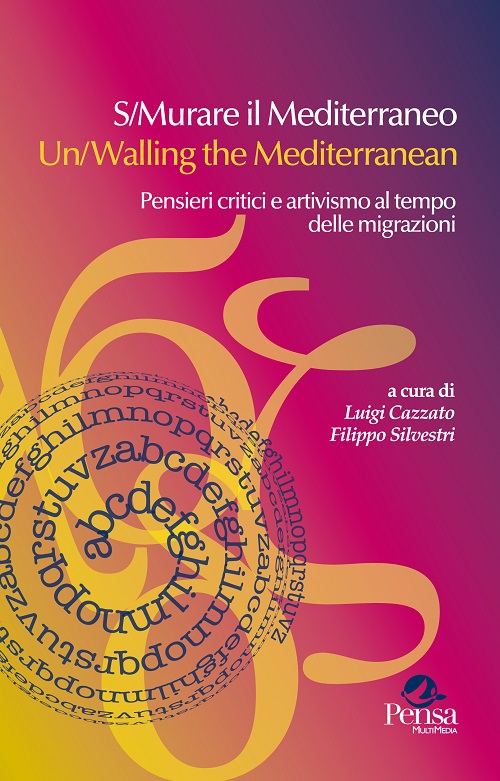
Vi sono luoghi e momenti difficili da dimenticare anche sotto un assedio mediatico e una proliferazione visuale senza precedenti. Ho sempre immaginato, io ragazzino, l’otto agosto del 1991 come una scena dei Visitors, quelli del 1983 però. Famiglia bianca davanti alla televisione, edizione straordinaria del notiziario, il padre che alla vista degli alieni dal divano esclama: “Sono esattamente come noi, hanno due gambe, due braccia, due mani!”. Mai previsione si rivelerà più errata. In Italia invece si assisteva, per la prima volta in diretta, all’arrivo della nave Vlora al porto di Bari. L’Adriatico, allargatosi solo in apparenza, immediatamente si restringeva e diventava prima canale, poi prigione (con i corpi degli albanesi ammassati nello stadio di Bari, quasi a rendere ancora più ridicoli gli sprechi del Mondiale di calcio da poco concluso), infine frontiera respingente.
Doveva essere ancora più piccolo, l’Adriatico, il 28 marzo del 1997. E infatti era già quasi finito, giù per il Canale di Otranto, mentre la motovedetta albanese Katër I Radës veniva speronata e affondata da una nave della Marina Militare Italiana. 1991-1997, si era chiuso un cerchio. L’acqua del mare improvvisamente si faceva solida, fino a divenire un muro altissimo e gommoso, capace di adattarsi a qualsiasi tipo di corpo e provocargli un movimento contrario pari almeno alla stessa forza d’urto. Se qualcuno dovesse cercare un inizio e una fine (illusoria) delle centinaia di tragedie dei migranti, queste due date potrebbero essere usate come un’efficacissima sineddoche.
Ripenso a queste due immagini, secondo me cruciali per comprendere le politiche italiane sull’immigrazione a partire dall’inizio degli anni Novanta e la creazione di un preciso immaginario “migrante”, mentre guardo una fotografia di Agnese Purgatorio, Fronte dell’Est, in cui rielabora una foto ormai classica dell’arrivo degli albanesi al porto di Bari nel 1991. Fra i visi che guardano alla sinistra del quadro, quattro volti femminili colpiscono lo spettatore, volgendosi verso gli occhi di chi guarda e riflettendo un’immagine straniante: Anna Magnani, le artiste Marina Abramović e Carla Accardi, la stessa autrice bambina. Che cosa è diventata, Fronte dell’est? Una documentazione storica, una commistione di ricordi e identità, una pagina sbiadita del nostro archivio personale? Del 28 marzo 1997 invece mi rimane in testa una musica, tratta dall’opera da camera di Admir Shkurtaj sul libretto d’opera di Alessandro Leogrande: Katër I Radës. Il naufragio. Una musica che riporta ai reduci più che ai martiri, a chi è sopravvissuto e con quella memoria deve conviverci rispetto a chi non ce l’ha fatta.
Entrambe, fotografia e musica, sono analizzate da Cristina Lombardi-Diop e Giampaolo Chiriacò in un libro recente: S/Murare il Mediterraneo – Un/Walling the Mediterranean. Pensieri critici e attivismo al tempo delle migrazioni, curato da Luigi Cazzato e Filippo Silvestri ed edito dalla leccese Pensa Multimedia. Un libro molto diverso dalle numerose produzioni accademiche sull’argomento, innanzitutto perché nato da un’ottica militante decisa ed esplicitata, nonché dal lavoro a monte, fra gli altri, di Paola Zaccaria. Ne è prova il manifesto-zattera iniziale, che autodefinisce gli autori presenti nel volume come “gruppo” e rimanda al sito e all’account facebook, dove è possibile seguire le varie iniziative, dal crowdfunding per il nuovo film di Gabriele Del Grande fino alle manifestazioni, passando per le riflessioni su Fortress Europe e l’organizzazione di seminari e giornate di studio. Il libro ne costituisce un elemento decisivo, ovviamente, ma è solo una tappa di un percorso ben più lungo.
E giustamente manifesta, il volume, le diversità di approcci e vedute, a partire da un orizzonte teorico che spazia da Mignolo a Derrida, da Bhabha a Anzaldùa, dal postcoloniale agli studi di genere passando per il pensiero “meridiano” di Cassano e Mezzadra. Difficile riassumere in poche righe tutti gli spunti, alcuni peraltro acutissimi, che il libro fa nascere. Due sono le riflessioni più originali, al di là della parte dedicata all’uso del lessico e del linguaggio in ambito migratorio, su cui molto ci sarebbe ancora da scrivere. La prima è, naturalmente, un’inversione del punto di vista. Attraverso le parole di Raffaele Nigro, Vanna Zaccaro ribalta l’immagine classica dell’Italia come “nuova Merica” per gli albanesi negli anni Novanta. Già si intravedevano, in realtà, le crepe nelle ville sul mare della “terra promessa”, tanto che lo stesso Nigro, con il suo “occidentalismo imperfetto”, ne metteva in luce le contraddizioni. E colpiscono oggi le parole del Primo Ministro albanese Edi Rama sugli italiani come “albanesi vestiti di Armani”, in un intreccio identitario ulteriormente complicatosi con l’assottigliamento della frontiera adriatica.
L’altro articolo, a firma di Claudia Attimonelli, colpisce un cuore caldo della narrazione e della rappresentazione dei e sui migranti. Da Calais alla Turchia, attraversando tutto il confine settentrionale e meridionale del Mediterraneo, è doveroso chiedersi oggi che ruolo abbia l’immagine e che cosa sia lecito fotografare, e in che misura. Credo che sia qui, nello spazio labile e talvolta ambiguo della rappresentazione dell’altro, in una fotografia che ondeggia fra “empatia e sensazionalismo”, che si nasconda il vero nocciolo della questione. Quanto si sa realmente di frontiere difformi – poiché i confini mutano a seconda di chi può attraversarli -, quanto è possibile sapere dall’altro, quanto è lecito descrivere?
Identica, la domanda si potrebbe ripetere per il Mediterraneo: quanto conosciamo, oggi, di questo mare? Cosa sappiamo dell’acqua che è diventata muro? E di quel che è nascosto sotto le correnti?

