gli orrori che i paesaggi europei ci nascondono
di Martin Pollack
Quando oggi scriviamo di una zona, di un paesaggio, sembra indispensabile tenere sempre conto anche del passato. Questo ci mette davanti a un compito difficile. Vogliamo cercare di scoprire che cosa successe qui settanta, ottanta o addirittura cento anni fa, anche se guardando di sfuggita, quando siamo di passaggio, in un’atmosfera rilassata di vacanza, non percepiamo niente che susciti la nostra diffidenza. Ciononostante dobbiamo sempre porci la domanda: il paesaggio ha qualcosa da nasconderci? E davvero cosi innocente, idilliaco come sembra? Che cosa troviamo se iniziamo a scavare? Vengono alla luce ossa marce? Possiamo metterle da parte con noncuranza, perche presumiamo che non ci riguardino, perche non abbiamo nulla a che fare con cio che successe qui? Perche ormai e passato tanto tempo? Non dobbiamo invece confrontarci con la storia, per quanto possa essere fastidiosa? Secondo me e imprescindibile rivolgersi anche ai lati oscuri di questi posti.
Non solo a Auschwitz e Treblinka, a Mauthausen e Ravensbruck, ma anche ai paesaggi senza nome, ai vasti boschi e alle paludi, alle steppe, che appartengono a quelle bloodlands che lo storico americano Timothy Snyder descrive in modo cosi vivido. Anche se le bloodlands di cui parlo io si estendono geograficamente su una superficie molto piu ampia che comprende anche l’Austria. E la Slovenia e l’Ungheria. E altri Paesi.
….
….
Occuparsi dei paesaggi contaminati implica sempre la necessita di confrontarsi in modo critico con la lingua. Come le fosse dovevano essere al riparo da occhi illeciti, anche i comandi per uccidere erano spesso camuffati con termini apparentemente innocui o comunque non univoci.
A questo proposito ricordo la mia infanzia a Mitterberg, dove fummo evacuati. “Evacuati” e uno di questi termini. Per la deportazione degli ebrei dalla Germania e dall’Austria nei campi di morte all’Est, nella corrispondenza ufficiale si preferi usare il termine “evacuati”, capace di velare la brutale realta. “Evacuati all’Est” e una formulazione che sminuisce i trasporti dalla Germania e dall’Austria nei campi di annientamento.
Ingannare e mimetizzare.
Fatti violenti non cambiano solo la lingua e le persone che ne sono coinvolte, ma anche i luoghi in cui avvengono. Questo vale anche per i paesaggi. Nella natura, nella campagna vasta e senza edifici, la violenza assume una forma diversa da quella in un lager chiuso e circondato da filo spinato e torri di guardia. Nel paesaggio i colpevoli si comportano diversamente, si adattano alle condizioni del luogo e si muovono in base al terreno, allo spazio che trovano – a cui, viceversa, con le loro azioni, il loro scavare fosse, le esecuzioni, il gettare terra sulle fosse comuni e mimetizzarle, danno un volto nuovo. Soprattutto conferiscono allo spazio un significato nuovo, sinistro.
….
….
A Hrastovec ci sono perlomeno degli elenchi delle vittime, incompleti, ma almeno qualcosa. Il nome della mia prozia è in un elenco: Drolc Pavla, Laško, umrla Hrastovec 26.8. (1945). Drolc era il cognome del marito sloveno. Era la quarantanovesima dell’elenco scritto a mano. Su innumerevoli altre fosse non ci sono informazioni così dettagliate. È questo ciò che contraddistingue l’essenza dei paesaggi contaminati, che i morti che vi giacciono sono quasi sempre senza volto e senza nome. Che nella maggioranza dei casi non sappiamo nulla delle vittime, tranne qualche volta la provenienza, ma anche quella solo approssimativamente: ebrei, rom e sinti, perseguitati e uccisi in quanto zingari, polacchi, prigionieri di guerra sovietici, bielorussi, domobranci sloveni, tedeschi, ecc. In genere non abbiamo fotografie né documenti delle vittime.
Perciò è particolarmente difficile chiudere con questi fatti in modo definitivo. Rimane sempre qualcosa di aperto, la domanda logorante e assillante di chi fossero le persone che furono sepolte così in quella parte di bosco, le cui spoglie vengono trovate solo molti anni dopo. Qual era la loro storia? Da dove venivano? Erano da sole o insieme alla famiglia, all’amato/a, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, agli amici, agli ultimi abitanti del paese o dello shtetl, quando morirono con violenza? Del farmacista Jenö Kohn, che un giorno del gennaio 1945 a Polianka, nei pressi di Donovaly, fu ucciso con la moglie e i due figli dagli uomini comandati da mio padre, sono venuto a sapere per caso. E ho addirittura ricevuto una sua foto. Ora so chi era Jenö Kohn. Un uomo di bell’aspetto, ancora giovane, con i capelli pettinati all’indietro e gli occhiali di corno tondi, che gli davano un’aria da intellettuale. È serio, forse anche malinconico, mentre guarda nella macchina fotografica.
NdR: gli estratti sono tratti dal magnifico Paesaggi contaminati, letto il quale la visione del paesaggio dell’Europa non è più la stessa, pubblicato (2016) da Keller Editore

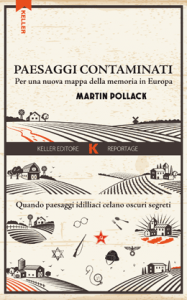

[ davvero molto interessante – leggerò ]
Il placido lago, la palude, davanti al campo di Ravensbrück, a solo una cinquantina di chilometri da Berlino, l’acqua trasparente, i giunchi che oscillano dolcemente al vento si sono nutriti delle ceneri del suo crematorio. Sul terrapieno antistante le deportate, neve, sole, caldo, gelo, caricavano con le pale la terra umida e limacciosa sulle cariole, per trasportarla un po più in là, poi, dopo averla scaricata in mucchi, la dovevano ricaricare e riportare al punto di partenza, così, ad libitum, senza un motivo apparente, se non la crudeltà raffinata di costringere a bastonate a un faticosissimo gesto celibe, inutile. Senza fine e senza un fine.

Poco più in là si continua e si è sempre continuato, anche quando il campo era attivo, a pescare, fare il bagno, andare in barca a vela, in canoa, come nulla fosse.
Solo alla fine delle visite delle comitive di studenti, di qualche ormai rara e molto anziana superstite, dei suoi congiunti [ ché quel dolore non lascia mai il DNA delle famiglie che lo hanno nel cuore ], e nel giorno della commemorazione della liberazione del campo, il 18 aprile, c’è la delicata consuetudine di lanciare nel lago dei fiori, delle rose, dei garofani, che galleggiando nella calma risacca e si allontanano piano a ricordare per un attimo, lenti sulla superficie smemorata, accompagnati da immagini perdute, pensieri, preghiere in tante lingue diverse di tante religioni diverse. Ad perpetuam rei memoriam.
e ⇨ questa è a suo modo una trasformazione/rinascita
,\\’
L’ho letto. E’ un libro che ha delle intuizioni molto forti. Però ho avuto la sensazione che si sia fermate a quelle. Comunque merita.
scusate l’italiano casual, non posso correggere…
io invece trovo che è un libro che riesce a mettere assieme, e dando un nome che resterà (l’efficacissimo “Paesaggi contaminati”), tutti gli spezzoni, vale a dire le innumerevoli stragi e carnai inumani, con le strategie meschine che li guidavano, in particolare proprio per quanto riguarda lo sforzo di “massima riservatezza” (quindi con una consapevolezza anche se forse subliminale del “dopo”), la presenza quasi generalizzata – invece – di testimoni implicati e non implicati, volontari e involontari, l’ubiquità di questi meccanismi e tragedie (che noi tendiamo a figurarci come confinate alle località più tristemente famose), la corrispondenza o la mancanza di corrispondenza tra segni lasciati sul paesaggio e nelle memorie, l’occultamento di questi segni nelle teste delle persone e nelle morfologie della topografia, i suoi motivi e meccanismi mostrati “dal vivo”, e la sola possibilità di riscatto possibile, e cioè dare nome a delle vittime, almeno qualcuna, e riesumare dall’oblio vero o finto che sia le tracce nascoste…; certo molte di queste cose le sappiamo, non tutte (quanti cittadini europei sanno che molte delle fosse comuni sono state oggetto di macabro setacciamento sistematico da parte di “cercatori d’oro” mossi dal mito dell’ebreo ricco …?), però questo libro ha il pregio di riuscire a dargli una coerenza d’insieme, e appunto non astratta, ma legata allo spazio fisico occupato dalle persone, i paesaggi che vediamo alla televisione e conosciamo e attraversiamo, quelli stessi dove si giocano ora altre partite potenzialmente altrettanto sordide, e che chiamiamo Europa;
e lo considero un libro anche molto bello, intendo come scrittura;
ma anch’io scrivendo male…
Ehi, non t’arrabbiare! Ho detto che m’è piaciuto! ;-)
non mi arrabbio Gianni, figurati, provavo a argomentare!!
Non il “dopo” ma il ”durante” stava a cuore agli architetti della Soluzione Finale. Loschi figuri come Heydrich temevano che una maggioranza di pavidi sostenitori del Reich potessero inorridire e titubare di fronte al loro progetto di sterminio. Da qui la massima riservatezza e l’utilizzo di codificati eufemismi nei documenti ufficiali.
Bravo! L’autocritica fa sempre bene. L’importante è farne tesoro per migliorare la propria scrittura, altrimenti non è altro che autocommiserazione.
che toni! (da che pulpito parli con condiscendenza, mi sfugge?)
Non ho capito: che cos’è che le sfugge?
Comunque, non mi sembra di avere adoperato toni fuori luogo: mi sono limitato a correggere una sua interpretazione storica, e a farle un complimento con un’esortazione.
Di fronte a tanti scrittori primedonne per i quali qualsiasi critica o silenzio è sempre frutto di motivazioni extra-letterarie, è rincuorante vedere che ci sono scrittori che ammettono i limiti della propria scrittura.
L’esortazione finale l’avevo intesa come un augurio a migliorarsi: spero che lei non l’abbia vista come un’espressione di condiscendenza da parte mia nei suoi confronti, se è questo quello cui lei si riferisce nel suo commento precedente.
[ arrivato ore 10 e letto al volo stamattina tutto di seguito – senza stacchi ]
Credo che il libro preluda a un vero e proprio progetto di una archeologia dei paesaggi contaminati, di una mappa dei luoghi dimenticati di moltissime violenze rimaste segrete.
Colpisce molto quanto sia spesso restia la stessa popolazione dei luoghi a scoprire e a idenficare il loro ormai quieto e intatto paesaggio, i loro orti rigogliosi, con un cimitero a cielo aperto.
Coprire l’identità dei morti, è coprire anche l’identità dei carnefici.
Dare ai numeri dei genocidi un nome, un volto, una storia è restituirgli l’umanità e la dignità calpestata. Cosa molto attuale anche per il nostro mediterraneo/cimitero, mi pare.
Davanti alla tomba vuota di mio nonno, scomaparso a Mauthausen, ho spesso provato con profondo dolore e inquietudine queste sensazioni.
Pollack cita la poesia di Evtušenko su Babij Yar, un fossato nei pressi della città ucraina di Kiev, dove 29 e il 30 settembre del 1941, i nazisti con la polizia collaborazionista ucraina massacrarono 33.771 civili ebrei. Poi nei due anni seguenti circa 90.000 ucraini, zingari e comunisti furono massacrati nel fossato.
Credo sia importante rileggerla.
Evgenij Aleksandrovič Evtušenko
Babij Jar
Non c’è un momumento
A Babi Yar
Il burrone ripido
È come una lapide
Ho paura
Oggi mi sento vecchio come
Il popolo ebreo
Ora mi sento ebreo
Qui vago nell’antico Egitto
Eccomi, sono in croce e muoio
E porto ancora il segno dei chiodi.
Ora sono Dreyfus
La canaglia borghese mi denuncia
e mi giudica
Sono dietro le sbarre
Mi circondano, mi perseguitano,
mi calunniano, mi schiaffeggiano
E le donne eleganti
Strillano e mi colpiscono
con i loro ombrellini.
Sono un ragazzo a Bielostok.
Il sangue è ovunque sul pavimento
I capobanda nella caverna
Diventano sempre più brutali.
Puzzano di vodka e di cipolle
Con un calcio mi buttano a terra
Non posso far nulla
E invano imploro i persecutori
Sghignazzano “Morte ai Giudei”
“Viva la Russia”
Un mercante di grano
picchia mia madre.
O mio popolo russo
So che in fondo al cuore
Tu sei internazionalista
Ma ci sono stati uomini che con le loro
mani sporche
Hanno abusato del tuo buon nome.
So che il mio paese è buono
Che infamia sentire gli antisemiti che
senza la minima vergogna
Si proclamano.
Sono Anna Frank
Delicata come un germoglio ad Aprile
Sono innamorato e
Non ho bisogno di parole
Ma soltanto che ci guardiamo negli occhi
Abbiamo così poco da sentire
e da vedere
Ci hanno tolto le foglie e il cielo
Ma possiamo fare ancora molto
Possiamo abbracciarci teneramente
Nella stanza buia.
“Arriva qualcuno”
“Non avere paura
Questi sono i suoni della primavera
La primavera sta arrivando
Vieni
Dammi le tue labbra, presto”
“Buttano giù la porta”
“No è il ghiaccio che si rompe”
A Babi Yar il fruscio dell’erba selvaggia
Gli alberi sembrano minacciosi
Come a voler giudicare
Qui tutto in silenzio urla
e scoprendomi la testa
Sento che i miei capelli ingrigiti
sono lentamente
E divento un lungo grido silenzioso qui
Sopra migliaia e migliaia di sepolti
Io sono ogni vecchio
Ucciso qui
Io sono ogni bambino
Ucciso qui
Nulla di me potrà mai dimenticarlo
Che l’ “Internazionale” tuoni
Quando l’ultimo antisemita sulla terra
Sarà alla fine sepolto.
Non c’è sangue ebreo
Nel mio sangue
Ma sento l’odio disgustoso
Di tutti gli antisemiti
come se fossi stato un ebreo
Ed ecco perché sono un vero russo.
Dmitrij Šostakovič
⇨ Dmitrij Šostakovič Sinfonia n. 13 in si bemolle minore [Op. 113, Babij Jar]
,\\’
Ho sempre creduto che la natura, in particolare l’albero conosce l’anima.
Paesaggio banale che ha tutto cancelato?
Non lo credo. Per chi attraversa questa foreste il cielo griggio o luminoso di freddo si tace.
Il tronco dell’albero ha in memoria
gridi e pianto.
Per sempre questa foreste ha perso
la sua bellezza.
A volte la natura sembra indifferente
al dolore.
Si sente un grande freddo nel cuore.
Lo immagino.
Mi ricordo dei grandi prati in Picardia.
Diventano un lago di papaveri sotto il vento in giugnio.
Un grande silenzio.
E a volte il vento murmura le parole di un giovane soldato.
Provo emozione nei luoghi.
Mi ricordo il ghetto di Venezia.
Mi è sembrato il luogho più misterioso di Venezia.
Un magnetismo che non posso spiegare.
Credo nei fantasmi, nei spiriti che sonno lì, quando mi fermo e ascolto.
Credo che anche il paesaggio si trova nella lettura o nella scrittura.
Un paesaggio fatto di presenza.
Questo libro l’ho letto dopo quello di Tochman, sempre della Keller edizioni, “Come se mangiassimo pietre”, un reportage sull’ex Yugoslavia, nell’odio che permane tra le tre fazioni in continuo conflitto etnico, gli atti sconvolgenti compiuti e il silenzio al genocidio accusato dalla popolazione – principalmente maschile; e la fuga nei boschi, l’accerchiamento, i militari olandesi, a due passi, a guardare con l’abisso negli occhi. Ok, sarà stato questo fluire d’immagini e violenza, con uno stile fluido e mai ripetitivo, a farmi pesare, invece, la scrittura lenta e accademica di Pollack. Un libro molto interessante perché, almeno a me, tutte questo internare e nascondere, e pensare che la gente vive su di esse, magari nella totale indifferenza, quasi come per evitare che sbuchino spiriti e macchine fotografiche, mi era sconosciuto. Molto delicate le prime pagine, quasi filosofiche. Un po’ mi scazzava quel suo “Caro e amato” nonno nazista. Alcune volte un po’ troppo ripetitivo, anche riguardo ai luoghi trattati, quel ritornare sempre sullo stesso tema con le medesime immagini e parole – o sinonimi di esse. Credo che bastasse un piccolo pamphlet per dirci tutto e sarebbe stato più forte e vibrante. Però devo dire che non è scontato. Che ti lascia pensare molto, non solo all’orrore e al mutismo che ancora si cela sotto i nostri piedi, ma dal fatto di come tutt’oggi, tra politica e società civile, si faccia di tutto per mandare la Storia sempre più giù, dove solo le radici degl’alberi conoscono la verità (visto anche la scarsità di documenti; ci si conforta nelle storie o leggende del luogo).