Emanuele Tonon, «Fervore»
di Mario Sammarone
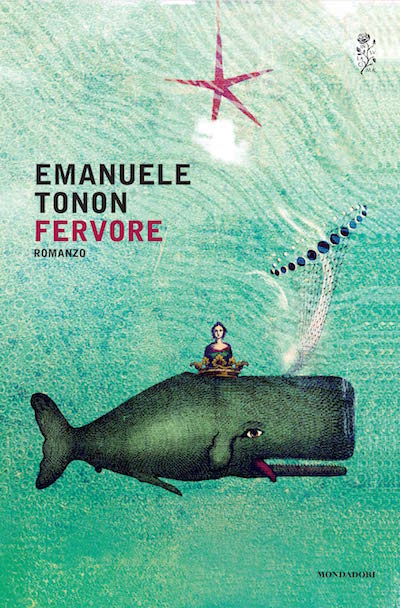
In un monastero dell’Italia centrale, Renacavata, realmente esistente, si celebra questa piccola epopea personale situata in un tempo che però sembra del tutto metastorico. In realtà, leggendo, ci accorgiamo da alcuni particolari di trovarci ai nostri tempi, ma la vicenda potrebbe svolgersi nel Medioevo come pure nell’Ottocento: il protagonista, un ventenne senza nome che potrebbe essere ognuno di noi, vive il suo anno di noviziato in questo convento, in un esilio volontario dal mondo che non sappiamo se sfocerà nel perfezionamento del percorso fino ai voti, oppure sarà solo un episodio di un tratto di vita. In questo convento, fondato nel 1531 da Matteo da Bascio, riformatore cappuccino staccatosi dal tronco principale dei minoriti osservanti francescani, vivono la loro vita frati vecchi, che sembrano fatti di legno come gli stalli del refettorio, e frati giovani, ospiti per l’anno di noviziato, frati primaverili, fatti di nuova linfa vitale e accoccolati nel convento come in un ventre materno pronto ad accoglierli.
Il protagonista è fuggito da una vita insana, terribile e senza senso, da un lavoro in fabbrica che gli chiedeva l’esistenza in cambio di una perdita di memoria e di sé che lo perdesse ad ogni speranza. Si rifugia in questo che chiama il “Giardino”, prefigurazione dell’Eden come egli stesso con i suoi compagni sono prefigurazione della “glossolalia finale”, periodo nel quale ognuno parlerà nella sua lingua autentica e sarà capito, così come a sua volta intenderà quella degli altri. Un anticipo escatologico dunque, questo gruppo di ragazzi che vivono di dubbi e di meraviglie, di fede e capacità di vedere oltre, con un “Fervore”, appunto, come dice il titolo di questo libro di Emanule Tonon (Mondadori, 2016), che dovrà bastare loro tutta la vita, che dovrà essere come un’acqua da mettere da parte per la traversata del deserto che sarà la vita vera fuori del convento, arida e piena solo dell’infinita vanità del tutto.
Nel Giardino tutto è rivissuto in una dimensione estatica, che trasfigura ogni cosa o evento che accada, rendendo tutto poesia e fede assoluta, in un anelito ad impossessarsi di dio prima che Egli sparisca dalla loro vita, di assaporarne la presenza prima di perderlo, quando saranno usciti dal tepore di quel noviziato vissuto come un assoluto, un’occasione che mai più avranno di addomesticare il sacro, il loro Dio.
La via di Damasco del protagonista è stata una gita al santuario di Castelmonte, alla Madonna nera, dove un culto quasi misterico, catacombale, lo colpisce e lo chiama verso qualcosa che non sia più la sua fredda vita incatenata. Scopre una religiosità furiosa – come furiosa era la santità di Francesco, che aborriva la pompa mondana e la sapienza dei dotti per arrivare diritto fino a Dio senza mediazione. Trova nel convento i vecchi frati legnosi, arcaici, ignari della loro stessa santità, burberi ed innocenti, sporchi e sprezzanti di ogni concessione al mondo. Sono gli ultimi santi, disperati per questo, ma felici di avere Dio stretto a loro. Anche i giovani novizi vogliono farsi fontanelle di Grazia, sgorgare in un oceano d’amore, ossessionati di non lasciare da solo Cristo nel Getsemani, invocando una Parusia attesa, vivendo il calendario liturgico come tappe del tempo per arrivare ad essa.
Vivono una vita quotidiana fatta di preghiere mattutine, immersi ancora nel sonno non finito, in notti passate a combattere con un pensiero del peccato da cui sono attratti e respinti, umore tra gli umori primaverili della terra che lavorano in silenzio, rugiada tra le rugiade mattutine. Sono figli di contadini, che sono pagani per istinto, proni alla terra, ma loro vogliono vestire i panni di un’altra povertà. Cantano e pregano, tesi verso l’alto per non entrare troppo nell’abisso dell’anima, in cui la notte cela ogni incubo. Vivono ogni cosa con innocente gravità, nella nostalgia del Paradiso perduto, della Gerusalemme celeste: il Carnevale, con le sue vestizioni in cui ci si traveste per gioco compagni femminili, diventa l’occasione per creare l’essere androgino, l’unità dei sessi primigenia; le vipere, a cui dedicano una specie di culto bambino, che al pari degli angeli vegliano benevole su di loro, per morderli ai calcagni mentre giocano a pallone, per donare loro così in anticipo una scorciatoia per il cielo, vipere amiche perché in questo modo risparmierebbero loro il perdersi nella vita esterna, in balia del Signore di questo mondo.
Sono fraticelli ortolani, lavorano la terra inchinandosi ad essa, come poi nel coro si inchinano a Lui nel canto e nella preghiera. Le due Sante – con il nome di Teresa, d’Avila e di Lisieux, sono lette e meditate dal novizio protagonista nel silenzio della sua cella, frequentate in ore impensate, alle 5 del mattino così come la sera rubando tempo al sonno, e così questi giovani vivono una specie di continua trance, un dormiveglia in cui il loro bisogno adolescenziale di riposo vira verso un delirio continuo di allerta mistica, di ardente abbandono al Tutto, di essere solo un pensiero di Dio senza necessità di una coscienza di sé, in un delirante ardore di preghiera.
Francesco, lo “stregone medioevale” e certamente non ancora il Santo con le stimmate, funzionale alla Chiesa regnante, aleggia su tutto, presenza ed esempio, desiderio di tutti loro in un unico sogno collettivo che copre il convento come una coltre onirica. Quel convento, nascosto nel segreto dei boschi, come Francesco nelle grotte, dovrà essere abbandonato dopo l’anno di noviziato, il “ragazzo vestito di sacco” deve uscire dal “Giardino”, uscire dalla porta della sua cella che è Porta Santa, dalla culla segreta, dal suo Sabato del tempo e dal suo universo dove c’è tutto ed ogni cosa, e andare verso lo svelamento, verso il mondo. Oppure decidere di restare. Continuare a lavorare la terra con la stessa devozione che hanno verso Dio, sfinendosi di fatica perché tutto deve farsi pane. Non lasciare che la vita disperda il loro goffo, innocente fervore. Restare protagonisti della narrazione cosmica, immemore e necessaria affinché essa si racconti. Essere l’epifania inconsapevole, nel tempo, di ciò che è fuori del tempo. Essere trottole nelle mani di un Dio bambino. Tracciare, come piccole lumache, un segno di bava nel Giardino sicuro, accordati alla voce di Dio. Farsi vita allo stadio puro, iniziale, che crea il mondo e gli dà forma. Rimanere nel saio come in una nuova pelle. Essere carità e profezia fatte carne, fuoco sacro che arde senza bruciare, come il roveto ardente di Mosè. Restare nel ritmo divino, impresso al mondo all’inizio dei tempi: “Così fu sera, e poi fu mattina”.
Questa stupenda “storia di un’anima” scritta come un diario per concessione di Padre Gianni al protagonista, è un commovente ed intenso percorso mistico degno degli scritti di Teresa di Lisieux. La prosa di Tonon, visionaria e poetica, è in pieno accordo con il contenuto, che diventa esso stesso preghiera. Uno scritto raro nel panorama nel panorama letterario, è una vera “dossologia” narrativa che porta alla meditazione e ci dona una storia “laterale”, insolita, ma necessaria per ripensare ciò che siamo stati come comunità e, forse, non sappiamo più essere.

