A pietre rovesciate
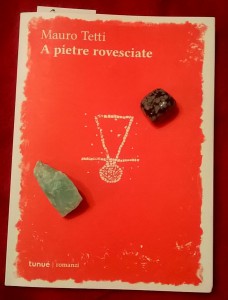 di Francesca Matteoni
di Francesca Matteoni
“Tu devi avere paura del sole, diceva, del vento e della pietra. Del sole che acceca, del vento che spinge, della pietra che uccide”, mette in guardia nonna Dora, le cui storie si mescolano a quelle del nipote dentro A pietre rovesciate, singolare, toccante esordio letterario di Mauro Tetti. Ovvero, parafrasando l’ammonimento, è la vita con le sue forze primordiali che farà sempre di te quel che vuole. Devi avere paura di ciò che ti muove, del sole che riscalda, del respiro che è come un vento, della pietra che sostiene – guardali da un altro punto di vista e queste sono le armi micidiali della fine. Cosa fare allora? Nulla, forse, aspettare. E mentre si aspetta, favoleggiare.
Nel libro si viene tessendo una fiaba disperata, fatta di regine che diventano pietra, principesse tristi che si seccano al sole, uomini dalla forza erculea che nascondono la propria viltà, donne tragiche che preferiscono il fondo del pozzo a un destino senza amore. E come le autentiche fiabe questa non è che il potentissimo specchio del vero: c’è la Sardegna dall’altra parte,
aspra e sospesa tra la stagione arcaica dei nuraghi e un futuro apocalittico dove il selvatico riaffiora nelle rovine industriali, montagne di elettrodomestici, neon e pelo di animali. La città è Nur,“mucchio di pietre”, ma anche, quale nome proprio di origine araba, “luce” – la luce, mi piace pensare, che il racconto getta sulla fissità, la durezza della pietra. La storia di Nur ha inizio attraverso una genesi mitica e orale, è un libro non scritto della memoria, fatto dalle “labbra degli anziani” di chi ricorda com’era il tempo impastato alla terra e dunque lo evoca. Eppure quanto viene evocato si fa mortifero, non trova altro scampo se non proprio nell’essere detto da chi ha cercato ovunque, ribaltando le pietre, una via d’uscita, un senso diverso agli eventi e ai sembianti. Questa, infatti, è una fiaba compromessa dalla stortura umana. C’è l’innamorata, Giana, ragazzina dal ventre gonfio di birra, colei che è morta e non torna e tutto il viaggio dentro le pagine è un viaggio di fallimento e redenzione per poterla afferrare. Il protagonista si sottopone così alle prove impossibili che nelle storie risvegliano le principesse o guariscono i re e le regine gravemente ammalati, tuttavia qui siamo a Nur, in una città di orchi-adulti, orchi-uomini che non svaniscono; il tesoro non può essere trovato, anche se è bello sapere che resta segreto da qualche parte; le ombre non saranno mai catturate e portate in dono. Giana, “quella che è morta”, chiede e si fa beffe del narratore-amante, Giana forse sa già prima di lui che il futuro precipita nel nulla e allora meglio viaggiare all’indietro. Giana che è jana, fata e strega del folklore sardo, si fa ogni creatura femminile delle storie di nonna Dora, si fa Lucia Rabbiosa degli Animali, pazza del villaggio dagli occhi brutalmente cavati, che ha il potere di curare, ma non quello di essere compresa dove vige la legge del coltello e del sopruso. Le fate non si salvano, anche se maledicono; muoiono e non operano magie, o, si capisce con qualche strano organo alchemico dentro di noi, la magia viene compiendosi proprio mentre si ascolta, si riprende il filo di una voce e lo si lega a un’altra, mentre si lascia che il mondo sia feroce e corra verso la distruzione. È la magia dell’orlo ad animare il libro, a far brillare quei due opposti primitivi che rendono all’umanità tutto il suo mistero: la violenza e il sogno, il male che si impone e devasta e la sua unica cura – la grande, personale, collettiva leggenda dell’amore e della morte a cui non siamo sopravvissuti.


Grazie per questa presentazione. E’ terra magica che invita alla caduta, all’immersione. Invita alla lettura.