La bestia feroce che ride
di Antonella Falco
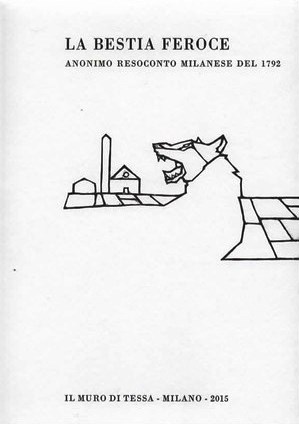
Milano, estate 1792. La grande e moderna città, fulcro dell’Illuminismo italiano, viene scossa dalla notizia di alcune morti violente avvenute nelle campagne circostanti. Le vittime, uccise a pochi giorni di distanza le une dalle altre, sono tutte molto giovani, bambini o ragazzi, per lo più intenti a pascolare il bestiame o a svolgere qualche attività nei campi o nei boschi. Ad aggredirle e ucciderle per poi fare scempio dei loro corpi e cibarsene è una misteriosa «bestia feroce» che alcuni identificano in un lupo, altri in una iena scappata da un circo itinerante, altri ancora in una creatura soprannaturale e demoniaca. I tentativi di catturare la bestia messi in atto dalle autorità cittadine si rivelano tutti inefficaci finché non si decide di ricorrere alle fosse lupaie, soluzione a quanto pare suggerita dall’anziano filosofo Cesare Beccaria, che dopo aver scritto celebri testi di filosofia giuridica continua a fornire il proprio contributo alla vita pubblica della città in veste di consigliere del Magistrato Politico Camerale, un’istituzione del governo austriaco che attende a tutti gli affari politici, economici e camerali del Comune di Milano.
Il 18 settembre, dopo un’estate di morti e di paura collettiva, si diffonde la notizia secondo cui una bestia, un lupo, è caduta in una delle fosse, nei pressi di Porta Vercellina. I contadini, accorsi dopo aver sentito i suoi ululati, la prendono a sassate e perticate per poi metterle un capestro al collo e strangolarla. Tra i testimoni sopravvissuti alle aggressioni che si recano a vedere la bestia alcuni riconoscono in quell’animale la fiera che li ha assaliti, altri negano con forza che si tratti della stessa belva, d’altra parte «le ugne e i denti di questo lupo non sembrarono adatti a fare le ferite che si osservarono ne’ ragazzi e nella fanciulla che n’erano state vittime» (p. 83). Ad ogni modo dopo tale cattura non si ha notizia di nuove aggressioni e dopo qualche ultimo presunto avvistamento non si fa più parola del misterioso animale e la vita a Milano e nel contado ritorna alla quotidiana normalità.
Questa è la coinvolgente e a tratti fiabesca storia narrata ne La bestia feroce. Anonimo resoconto milanese del 1792, da poco pubblicata dalla casa editrice Il muro di Tessa. Il volumetto, che reca in sovraccoperta una xilografia di Edoardo Fontana, raccoglie sotto questo titolo tanto la cronaca redatta da anonimo autore e scritta contemporaneamente all’accadere dei fatti – ossia il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre – peraltro mai fino ad oggi pubblicata integralmente malgrado sia stata diverse volte citata da molti studiosi, quanto un interessante e accurato saggio introduttivo scritto da Raffaele Russo e intitolato La bestia che ride.
Proprio questo saggio merita una più attenta disamina per la molteplicità e la ricchezza degli spunti che offre al lettore. L’autore sottolinea come nessun altro animale al pari del lupo abbia avuto una così notevole e duratura fortuna letteraria: «fin dalle letterature più antiche, la figura di questo predatore è stata presentata in rapporto alle vicende degli uomini, e nel corso delle varie storie ha preso spesso su di sé alcune delle caratteristiche umane più rilevanti» (p. 18). Il lupo ha subito un processo di antropomorfizzazione per il quale si è visto attribuire qualità tipicamente umane, divenendo creatura infida, astuta e malvagia. Ma «l’immagine mitopoietica» del lupo presenta anche aspetti positivi: dalla storia della lupa che ha allevato Romolo e Remo dando luogo al mito di fondazione dell’Urbe, fino alla vicenda di Mowgli che nel Libro della giungla di Kipling viene salvato proprio da una famiglia di lupi. Motivo per il quale Raffaele Russo sostiene che «potremmo insomma parlare di una strutturale duplicità dell’immagine culturale del lupo nel corso della storia letteraria, e vederlo come un terminale simbolico della caratteristica ambiguità di quel predatore ben più pericoloso – l’uomo – con cui la sua storia è così spesso mescolata. Forse si può addirittura sostenere che per il lupo (in letteratura e nella storia della cultura) si può spendere meglio che per ogni altro animale diverso dall’uomo l’intraducibile parola greca deinòs, quella con cui Sofocle descriveva la specificità dell’uomo stesso: un essere capace di azioni grandi e benevole, così come delle più crudeli e miserevoli ferocie» (p. 19).
Le storie letterarie che nei secoli passati hanno posto al centro della narrazione la figura di un lupo mangiatore di uomini, per quanto oggi inverosimili, non hanno fatto altro che dipingere, e a volte accentuare con tratti fiabeschi, una possibilità che per tutta l’età medievale e anche moderna ha costituito un rischio concreto, soprattutto per le popolazioni rurali che vivevano al limitare di boschi e foreste. «Le antiche storie trasfiguravano e rendevano ancora più spaventosa una possibilità del tutto concreta. Del resto nel mondo tradizionale le favole avevano una chiara funzione educativa, erano storie di avvertimento, che servivano a rinforzare le indicazioni educative ed etiche dell’istituzione familiare. Si trattava di quella che Clara Gallini chiama “pedagogia della paura”, per la quale “l’oggettivazione del mostro sempre configurava pericoli e interdetti ben precisi e pertinenti al limitato ordine delle possibilità contemplate dal contesto» (p. 21).
La godibilità del saggio di Russo risiede tutta nell’excursus letterario-filosofico che lo attraversa. Viene così chiamato in causa un racconto di Maupassant, Il lupo, risalente al 1882 ma ambientato nel 1764, vale a dire in piena età illuministica e antecedente solo di pochi decenni alla vicenda milanese. Nel tardo Ottocento l’uomo non si relaziona più alla figura del lupo con la «fatalistica rassegnazione» (p.22) che si può ad esempio rintracciare nelle fiabe dei fratelli Grimm, ancora legate a una tradizione di matrice medievale; tra Sette e Ottocento le storie che parlano di lupi hanno ormai poco a che fare con Cappuccetto Rosso e raccontano invece di come il progresso abbia portato l’uomo a imprimere il proprio dominio sulla natura, dominio che si esprime anche nel relegare la figura del lupo, inteso come l’incarnazione più selvaggia e pericolosa del mondo naturale, in ambiti sempre più circoscritti e lontani.
Date queste premesse è ovvio che quando particolari condizioni climatiche e ambientali determinano un riavvicinamento dei lupi ai centri abitati, con conseguenti aggressioni a uomini o animali domestici, «il loro tornare a far danno non quadra più con l’immagine che l’uomo ha di se stesso e del suo rapporto con la natura» (p.23).
Scatta allora il sospetto, se non la convinzione, che a rendersi protagonisti di aggressioni tanto efferate non possano essere dei lupi normali: tanto orrore non può che avere un’origine inquietante e soprannaturale, se non tutti almeno uno di questi animali – quell’unico al quale si attribuiranno tutte le stragi, non importa se avvenute a grande distanza le une dalle altre – deve possedere una natura demoniaca. Russo, rievocando il racconto di Maupassant, sottolinea come lo scrittore francese faccia riferimento a condizioni climatiche avverse e al fatto che l’eccezionale rigidità di quell’inverno ha reso i lupi particolarmente feroci, ma ricorda anche come ben presto nelle campagne abbia iniziato a circolare la leggenda di un lupo bianco di enormi dimensioni, estremamente aggressivo e pericoloso e dotato di un’astuzia tanto perversa e raffinata da non potersi attribuire a un semplice animale. I cacciatori hanno ucciso altri lupi ma non lui, che è sempre sfuggito alla cattura tanto da indurre chi gli dà la caccia ad usare pallottole benedette per poterlo finalmente uccidere. Il soprannaturale ha ormai fatto irruzione nella vicenda, non si tratta più di una semplice caccia, quel lupo diviene un’ossessione, ucciderlo è per i cacciatori una questione di vita o di morte, costi quel che costi bisogna ammazzare il lupo bianco anche se questo può comportare la perdita della propria stessa vita (cosa che puntualmente accade a uno dei protagonisti del racconto). Questa folle caccia autodistruttiva, come ben sottolinea Raffaele Russo, ricorda un’altra memorabile caccia: quella altrettanto folle e ossessiva ingaggiata da Achab contro Moby Dick (che con il lupo di Maupassant condivide il colore bianco e rappresenta al pari di esso «il potere irredento della natura», p. 24).
Anche nella vicenda milanese l’attenzione viene focalizzata su un’unica bestia i cui tratti subiscono ben presto una trasfigurazione in senso fantastico e diabolico.
Una cosa Russo non dice nel suo saggio, ovvero che in Francia proprio nello stesso periodo in cui è ambientato il racconto di Maupassant, e quindi pochi decenni prima dei fatti avvenuti nell’alto milanese, ossia per l’esattezza tra l’aprile del 1764 e il giugno del 1767, un’altra bestia, per molti versi analoga alla nostra, terrorizza la regione del Gévaudan. Questa creatura, nota appunto come la Bestia del Gévaudan, uccide e ferisce uomini e animali in un’area vasta una novantina di chilometri. Le vittime, per lo più donne e bambini, vengono sgozzate e poi divorate parzialmente o integralmente. Si contano 136 morti accertate su un totale di 270 attacchi, ma si stima che il vero numero delle vittime debba aggirarsi tra le 150 e le 200 poiché a un certo punto per volontà del re Luigi XV si smette di contarle. Delle 136 vittime accertate 14 vengono decapitate, forse a causa del trascinamento del cadavere con conseguente trazione del collo. Per ordine del re un gran numero di valorosi cacciatori si reca nel Gévaudan per uccidere la bestia. Molti di essi asseriscono di averla uccisa o ferita in maniera mortale ma questa torna ogni volta a mietere vittime. Il che induce la popolazione locale a credere che essa sia dotata di poteri soprannaturali e che sia in sostanza immortale, altri pensano addirittura alla presenza di un licantropo. Altre ipotesi, non supportate però dal riscontro di prove, parlano di un serial killer travestito da animale, ma le impronte ritrovate accanto alle vittime sono sempre e soltanto di animali e non di esseri umani (cosa che per certi versi avvalora la teoria del lupo mannaro). Si pensa anche alla possibilità che la bestia possa essere un leone sebbene le orme e i morsi non siano compatibili con quelli di un grosso felino ma sempre riconducibili invece a un canide, sia pure di grandi dimensioni. L’ipotesi più accreditata è dunque quella riconducibile a uno o più lupi, forse appartenenti alla stessa famiglia, forse ibridi o probabilmente affetti da acromegalia, malattia che provoca un’ipertrofia nella crescita delle ossa (tra i testimoni c’è chi asserisce che la fiera abbia l’aspetto di un lupo ma le dimensioni di un vitello). La Bestia del Gévaudan, che indubbiamente deve aver affascinato la fantasia di Maupassant, ha esercitato la sua suggestione anche sull’industria cinematografica che a distanza di vari anni l’uno dall’altro le ha dedicato due film, La bestia nel 1975 e Il patto dei lupi nel 2001.
Il saggio di Russo inquadra la vicenda della «bestia feroce» nel quadro politico culturale e sociale della Milano di quegli anni, gli ultimi dell’impero austriaco. Quattro anni dopo, il 15 maggio 1796, Napoleone sarebbe giunto trionfalmente a Milano; in quell’estate del 1792 nei salotti, nei circoli illuministici, nei caffè letterari in cui l’argomento prevalente sono le speranze e i timori legati a quanto sta contemporaneamente accadendo nella Francia rivoluzionaria, la notizia della belva assassina irrompe destando, se non una vera e propria preoccupazione, almeno la curiosità degli intellettuali cittadini. Tra questi si interessa alla vicenda Pietro Verri, il quale in una lettera al fratello Alessandro compie delle argute riflessioni su cui l’autore del nostro saggio si sofferma attentamente.
La lettera, datata 1 settembre 1792, dice a proposito della fiera:
«La Bestia se la ride di tutti noi, delle taglie nostre, de’ nostri tridui e delle paralitiche nostre risoluzioni; sin’ora ella ha mostrato più spirito e condotta di quello che abbiano fatto da noi gli uomini; e poco vi manca ch’io non mi dichiari del suo partito, poiché sono sensibile al merito, e infine poi se noi mangiamo e uccidiamo non è maraviglia ch’ella faccia altrettanto, persuasa com’ella sarà che anche per lei è fatto il mondo» (p. 25).
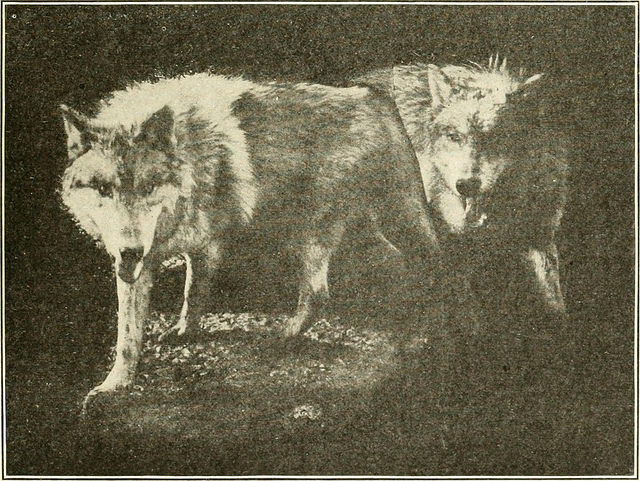
Raffaele Russo commentando la lettera si sofferma innanzitutto sulla «notevole immagine della bestia che ride» (p. 25), sottolineando come questa rientra in quella forma di antropomorfizzazione del lupo di cui si è già detto, essendo il riso una peculiarità precipua dell’essere umano. Non mancano poi le critiche nei confronti delle istituzioni, le cui decisioni in merito alla vicenda sono definite «paralitiche», e non mancano soprattutto l’ironia e il sarcasmo tipicamente illuministici nei confronti dei «tridui» e delle pratiche religiose messe in atto per allontanare il flagello. Ma la cosa più importante è che per la prima volta si sposa il punto di vista dell’animale, dal momento che se noi ci nutriamo e per farlo (e per difenderci) ammazziamo altre creature, allo stesso modo essa farà altrettanto nella persuasione che anche a lei spetta un posto in questo mondo. Una posizione molto moderna e aperta, di netto relativismo culturale, che come giustamente sottolinea Russo ha avuto un precedente importante nell’affermazione contenuta in un saggio di Michel De Montaigne a proposito delle popolazioni autoctone del Brasile dedite al cannibalismo. Siamo nel Cinquecento e Montaigne fa notare come questa pratica, che gli esploratori e i missionari europei ritengono barbara, non è poi tanto diversa dalla barbarie delle torture e dei martiri ordinati dai tribunali dell’Inquisizione. Ma Verri va oltre, compiendo «un passo avanti scandaloso, anche rispetto alla già scandalosa posizione di Montaigne: il punto di vista altro che propone non è infatti solo quello di un altro tipo di uomini, distanti da noi, come i cannibali brasiliani, ma è quello di un’altra specie animale. […] Il passo avanti di Verri, rispetto al relativismo culturale di Montaigne, giunge a mettere in discussione lo specismo che è stato il presupposto indiscusso di ogni riflessione sul rapporto fra uomo e natura fino all’età dell’illuminismo, e oltre» (p. 27).
In questa riflessione del Verri, Russo vede «uno dei primi sintomi dell’incrinarsi dell’immagine dominante e antropocentrica dell’uomo come signore razionale (signore perché razionale) che aveva caratterizzato l’epoca precedente» (p. 28).
Il saggio si sofferma anche sulle descrizioni che della bestia sono state fornite da chi è sopravvissuto alle aggressioni o dai contadini che l’hanno vista e affrontata. Tali descrizioni, degne di un bestiario fantastico medievale, sono tutte accomunate dalla mescolanza di tratti fisici appartenenti ad animali domestici – e pertanto familiari – quali ad esempio capre, cavalli e maiali. Si tratta ovviamente di una descrizione assai poco realistica che evoca e mette in scena le paure più recondite, i terrori più ancestrali della povera gente dell’epoca e che molto ha a che fare con la categoria freudiana del perturbante.
Chi ha assistito – o peggio ancora è stato vittima – di un attacco da parte di un lupo non può che fornire un identikit della bestia trasfigurato dalla paura, la quale trasforma un comune lupo in una belva favolosa. Accortamente Russo ricorda come il perturbante sia «un peculiare tipo di paura» che si prova «quando una persona, una situazione o un animale viene avvertito come familiare ed estraneo allo stesso tempo, e genera una dolorosa sensazione di confusione e disorientamento» (p. 34). «Il perturbante» secondo la nota definizione di Freud è appunto «quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare».
A questo va ad aggiungersi la constatazione di quanto particolare e delicato sia il periodo storico nel quale si colloca la vicenda della «bestia feroce». Come si è detto, sono anni di fermento e di profondi cambiamenti: un’epoca di transizione, dunque, in quanto tale perfettamente congeniale all’insorgere di una «crisi della coscienza collettiva» che secondo il sociologo Émile Durkheim produce nella società uno stato di disorientamento e angoscia, una condizione di ansia dovuta al vacillare delle vecchie certezze e all’incapacità di trovarne di nuove. A tutto questo Raffaele Russo riconduce la paura collettiva che ha pervaso le genti delle campagne intorno a Milano in quell’estate del 1792, portandole a convogliare nella figura di un unico portentoso mostro assassino le aggressioni messe in atto da numerosi lupi sbandati, che circostanze ambientali e climatiche eccezionali hanno indotto ad abbandonare le loro abituali sedi montane, spingendoli nei boschi delle pianure, fino al limitare dei centri abitati.
La bestia feroce, conclude Russo, non rappresenta altro che la presa di coscienza della vulnerabilità umana malgrado l’illusione di dominio sul mondo che deriva dal vivere in luoghi fortemente antropizzati e civilizzati:
«Il fascio di luce della civilizzazione ci racconta una bella favola su noi stessi, ci fa credere invincibili ed eterni. Ma appena oltre il piccolo fascio di luce, ciò che abbiamo sempre temuto è ancora in agguato. Poco più in là, forse anche tutt’intorno a noi e dentro di noi, ci sono ancora, irredente, le forze naturali che abbiamo imparato a ignorare, ma non abbiamo mai veramente vinto. Abbiamo sempre saputo che alla fine sarebbero tornate. A volte in effetti ritornano sotto forma di malattia, altre volte di tempesta o di terremoto. Qualche volta, eccezionalmente, possono prendere la forma di una bestia feroce. Un lupo, ad esempio» (pp. 36-37).
Come si è detto, gran parte del pregio del volumetto risiede nel ben congegnato saggio di Raffaele Russo e nella molteplicità degli spunti di riflessione che esso fornisce. Ma interessante risulta anche la cronaca dell’anonimo autore milanese per il valore documentario e per la sua godibilità come “fiaba nera”, ossia per gli aspetti gotici del narrato, i quali, come indica il Verri nella sua lettera, potrebbero anche rendere inclini a parteggiare per la bestia attribuendole i connotati antropomorfici del serial killer con tutta la fascinazione che tale figura ha esercitato ed esercita nell’immaginario letterario-cinematografico. Si legga a tal proposito il bel saggio di Michele Mari contenuto ne I demoni e la pasta sfoglia nel quale, elencando i motivi per cui l’uccisore seriale può riscuotere la simpatia del lettore o dello spettatore, l’autore scrive «si può parteggiare per lui […] perché all’esprit de géométrie unisce volentieri l’esprit de finesse […] ma soprattutto perché è solo, cosmicamente solo in un mondo che parla altre lingue e segue altri dèi» (M. Mari, I demoni e la pasta sfoglia, Cavallo di ferro, Roma 2010, p. 366).
Nel caso della nostra «bestia feroce» la fusione tra esprit de géométrie e esprit de finesse potrebbe rintracciarsi nell’astuzia beffarda con la quale ella, secondo quanto riportato nella cronaca, inganna le sue giovani vittime fingendosi un cane e avvicinandosi ad esse scodinzolando come se volesse giocare.
Sembra quasi di trovarsi di fronte al lupo di Cappuccetto Rosso, calato però in un contesto decisamente più efferato e grandguignolesco. Non mancano infatti le scene “splatter” di squartamenti e sgozzamenti e smembramenti: la belva, avida di sangue, beve dal collo delle sue vittime e lascia nei campi cadaveri mutilati e semidivorati.
Ma non bisogna credere che l’autore del testo indugi nel gusto del raccapricciante con sadica morbosità: la sua è una cronaca scritta in tempo reale, un diario dei fatti, un testo redatto in uno stile composto e discreto, del quale si può notare l’immediatezza senza che sfugga al lettore attento una certa settecentesca sorvegliatezza. Chi lo ha scritto è comunque persona avvezza a usare la penna, frequenta i circoli illuministici del capoluogo lombardo ed ha modo di consultare i documenti dell’amministrazione cittadina.
Difficile non pensare, per affinità di tematica, a un’altra opera di ambientazione poco più tarda (inizio Ottocento, sebbene scritta allo scoccare dell’ultimo decennio del Novecento), opera letteraria, questa volta, e non cronachistica, benché anch’essa composta ricorrendo all’escamotage del diario: mi riferisco a quel piccolo (per numero di pagine) preziosissimo gioiello che è Io venìa pien d’angoscia a rimirarti del già citato Michele Mari. Qui un giovanissimo Leopardi, in odore di licantropia, attende agli studi che ne faranno il grandissimo letterato che tutti conosciamo e affina quella fascinazione lunare che tanta parte avrà nelle sue poesie, sotto lo sguardo perplesso e sempre più preoccupato del fratello Orazio Carlo, autore del diario. Anche qui non mancano le morti efferate e i misteri declinati secondo un gusto dell’atavismo e del doppio, oltre che del gotico, da sempre estremamente cari allo scrittore milanese, ma l’opera brilla, al di là delle tematiche affrontate, per la scelta di uno stile arcaizzante che ci restituisce il duplice prodigio di una prosa apocrifamente leopardiana da un lato, e di una lingua tuttavia nuova e attuale dall’altra.
Non sarebbe una cattiva idea leggere in successione le due opere – La bestia feroce e Io venìa pien d’angoscia a rimirarti (quest’ultima, tra l’altro, dopo le tre edizioni Longanesi, Marsilio e Cavallo di ferro, ormai introvabili, sarà ripubblicata da Einaudi nella collana Arcipelago nei primi mesi del 2016) – tanto più che quella del lupo antropofago è una figura che non conosce periodi di crisi né in campo editoriale né in campo cinematografico contribuendo a tramandare quell’immagine perturbante del mostro che da sempre dialoga col nostro subconscio svelandoci che tutte le storie di mostri sono alla fine storie di uomini e che la teratologia non è altro che lo studio del lato oscuro della nostra psiche.


bellissimo, Davide, grazie, si legge con interesse crescente, aspetto con ansia che Einaudi ripubblichi Mari.
Grazie Sparz. Ossia, grazie a Antonella Falco!
[…] OGGI ON LINE: Al lupo, al lupo! […]
Si bellissimo, lupo eterno
Il tipo di vittime degli attacchi (donne, bambini e giovani soli in aree isolate in orari solitari) è compatibile con l’attacco da parte di lupi. Insolita è forse la zona, forse un inverno rigido e la pressione umana nelle aree boschive ha privato un branco degli ungulati di cui si nutre normalmente. Il territorio lombardo era in passato molto meno boscoso di oggi, per via dell’intenso sfruttamento del legname e dell’agricoltura. Mi hanno sempre colpite le fotografie d’epoca della val Brembana di fine ‘800, le montagne erano brulle pelate per il passaggio doppio dei boscaioli e dei carbonai.
Sul mito del grande lupo feroce ha scritto un bel romanzo giallo Fred Vargas, L’uomo a rovescio, ambientato nel massiccio del Mercantour.
Non perderei di vista anche Giorgio Caproni e “Il conte di Kevenhüller”.