La famiglia che perse tempo
di Elena Frontaloni
Singolare, da rileggere, da ristampare: sono alcuni degli epiteti che Maurizio Salabelle, scrittore nato a Cagliari nel 1959 e morto a Pisa nel 2003, di professione insegnante, s’è guadagnato spesso negli anni passati, e che sono tornati a visitarlo con più frequenza negli ultimi mesi grazie alla pubblicazione per Quodlibet, a febbraio, de La famiglia che perse tempo, il suo primo romanzo rimasto fino ad oggi inedito. Gli epiteti nel fondo sono tutti giusti, perché davvero Maurizio Salabelle fu scrittore “singolare”, dotato di una voce riconoscibile, pudica, per questo non troppo intonata alle mode del suo tempo e del nostro – con autori sempre nel mezzo delle storie che raccontano, tirannici rispetto all’espressione che il volto del lettore deve prendere quando si trova davanti un loro testo (riso, pietà, avvilimento, adesione, pianto); e poi perché i suoi cinque romanzi pubblicati in vita sono tutti piuttosto difficili da reperire e varrebbe la pena di metterli a disposizione di chi li vuole leggere o rileggere. Per chi ha già letto e per chi comincia con La famiglia che perse tempo, in ogni modo, adesso c’è questo racconto di una famiglia colpita da una recrudescente e oscura malattia, proposto da Salabelle ad almeno tre editori, lavorato dalla fine degli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta, mai pubblicato anche per volontà o preferenze del momento da parte dello stesso autore (che propose in seguito altri testi a chi glieli stampò) e giustamente presentato da Ermanno Cavazzoni nella quarta di copertina come “il più tipico, forse, della sua fantasia”, “scritto in modo limpido, scintillante e impercettibilmente comico”.
C’è da dire che Salabelle scherzò parecchio in vita sui recensori che parlavano solo vagamente dei libri, usando metafore e trucchetti vari perché li avevano appena sfogliati (fece ad esempio una serie di memorabili recensioni fisiognomiche in forma di ritratti a partire da foto inventate di autori inventati anch’essi: se ne può leggere uno qui). E forse non sarebbe troppo contento di chi, per parlare di un libro ne riporta per cominciare la quarta di copertina. Però in questo caso partire dalla quarta della Famiglia che perse tempo e da Cavazzoni mi sembra quasi un movimento igienico: perché a Cavazzoni spetta il miglior ritratto complessivo di Salabelle scrittore (posso consigliare di leggerlo qui); perché Salabelle, scrittore “singolare” e a suo modo orgogliosamente isolato, prese parte all’esperienza del “Semplice”, una rivista che ebbe tra i suoi animatori appunto Cavazzoni, del quale fu amico e che fu uno dei primi (dopo Giuseppe Pontiggia) a scoprirlo e a proporre di pubblicarlo a Giulio Bollati (ne uscì L’assistente inaffidabile, 1992); infine perché comicità e fantasia sono forse le due parole che andrebbero tenute a mente per capire qualcosa della sua scrittura esatta e cangiante, tanto padrona della lingua (d’uso e letteraria) quanto capace di prendersene gioco, tanto abile nell’individuare i luoghi esatti in cui la grande e piccola letteratura s’incontra spesso dolorosamente con la grande e piccola vita di ciascuno (famiglia, malattia, lavoro, scuola), quanto pronta a fare dell’una e dell’altra, e dei loro punti d’incontro, una velenosa parodia.
Dunque secondo me vale la pena di osservarle meglio, la fantasia e la comicità di Salabelle, anche al prezzo di dire banalità o ripetere cose note o già dette da altri. Per quanto riguarda la fantasia, può tornare utile una definizione da enciclopedia (Treccani, per la precisione) secondo cui sarebbe la facoltà della mente umana di creare immagini, corrispondenti o no alla realtà. La definizione, per quanto ampia (serve anche a individuare temi ricorrenti in questo autore, e ne parlerò un po’ ora e un po’ dopo), aiuta a cogliere una qualità profonda della fantasia Salabelle, e cioè la sua esattezza nel creare immagini grazie a una lingua e un periodare di insolito nitore, che rendono oggetti persone e luoghi plausibili alla visione interiore di chi legge e fors’anche in odore di cinematografabilità, ma nello stesso tempo, e inesorabilmente, fanno urtare queste immagini con il senso comune, l’idea vulgata di normalità, di realtà, di immagine, di racconto o evento che proceda in qualche direzione, a colpi di cause e di effetti. Si può leggere al proposito l’avvio del romanzo, che sembra fare il verso alla documentatissima chiacchierata stenografica di Natalia Ginzburg nella Famiglia Manzoni, ma contemporaneamente getta il lettore in un’atmosfera che ingloba, burlandosene impietosamente, l’opera omnia di Buñuel: “in quel periodo, che denominammo successivamente ‘Periodo del tempo veloce’, nostro padre restava sempre chiuso in camera a sperimentare con i suoi liquidi. A quell’epoca abitavamo in una casa dal portone privo di vetri. Con l’arrivare dell’estate entravano mazzi di strani fiori, che ci stupivano sempre di più e ci mantenevano in uno stato letargico. Per proteggerci da ciò provavamo a indossare cappotti scuri, foderati di pelliccia o coperti di fitta lanugine, ma succedeva in egual modo che ci accasciassimo sulle sedie”. Più avanti, quando uno dei figli, che è medico, fa un lungo discorso sulla situazione del padre malato, con varie ipotesi sul suo stato tra cui una che lo vorrebbe “liscio come una parete, abraso”, “simile a una fotografia che pare piena di rilievi ma che vista di profilo smette di esistere”, l’effetto sulla famiglia viene così descritto: “Mentre mio fratello enunciava […] queste sue teorie complicate, qualcuno di noi osservava la faccia di nostra madre mentre assisteva alla conferenza. A tutti noi sembrava che cercasse di seguire seriamente quei ragionamenti intricati, pensando ora a una voragine e subito dopo a un deserto piatto, mentre in realtà (come capimmo tempo dopo in seguito a una sua confessione) guardava la barba di mio fratello che risultava per lei un’allucinazione”.
Certo queste righe sconcertano e insieme inclinano verso qualcosa che potremmo definire comico (Marco Ciriello in una recensione assai bella ha fatto il nome di Aki Kaurismaki e va bene, salvo togliere a Salabelle molta partigianeria per le vicende umane degli strambi); e senz’altro la fantasia di Salabelle è comica. Ma per capire meglio a che tipo di comicità le sue immagini vadano incontro, per evitare sovrapposizioni con doloranti umorismi (Pirandello) o realismi magici velati di malinconia (Cortázar) e ritrovare i padri conclamati di questo autore (sono tutti o quasi in epigrafe ai suoi libri: Svevo, Tozzi, Flaubert, Walser, Perec), è il caso per un verso di rileggere un suo testo molto chiaro, che si trova in rete, e per l’altro di ricorrere ancora una volta a Cavazzoni, a un suo pezzo del 2012, Il comico senza strategia. Qui si dice che l’uomo, a differenza degli angeli (che non ridono, si leggono reciprocamente nella mente, sono intelligenze integrali senza difetti, non sbagliano le parole e la pronuncia delle stesse), è un essere multiplo, pieno di pensieri dubbi e fantasticazioni, simile in questo a un cestino dell’immondizia, dal quale se si prova a tirar fuori qualcosa è verosimile che non si tragga una cosa sola, ma vi rimanga casualmente appiccicato qualcosa d’altro, o più scarti d’altro. Dunque quando l’uomo prova a cavare delle fantasticazioni da sé, per parlare e scrivere, questi diversi pensieri tutti appiccicati e scomposti che escono dalla pattumiera possono collaborare (e vien fuori l’inizio della Divina commedia), oppure i pensieri possono urtarsi, contrastarsi, o anche dare l’impressione che “dietro al discorso ci siano due rotaie” le quali, più o meno leggermente, divergono. Nel primo caso abbiamo uno stile alto e forte, che dice l’uomo e l’epoca quasi senza smagliature, con una serie di complessità radunate dentro ogni parola che prova a dire il pensiero; nel secondo caso entriamo nel comico, che ha questo d’istruttivo: “mostra che c’è qualcosa di dissociato interno alla parola e al pensiero”, fa vedere che nel fondo stesso del linguaggio c’è qualcosa di comico, anche quando produce frasi solenni e forti.
Il comico di Salabelle mi pare rispondere del tutto a quest’ultimo pensiero; e forse fa anche qualcosa di più: si colloca, molto umilmente, in un limbo senza nome, tra i cieli degli arcangeli, di cui pare misteriosamente consapevole, e le pattumiere umane di cui sembra aver fatto parte in un tempo lontano. Per questo diverte e angoscia insieme, per questo è sempre spiazzato e spiazzante. Nelle storie di Salabelle infatti ci sono voci che “stanno” con incredibile candore e però “non si trovano” nei propri luoghi, nella propria epoca e neppure nella razza umana; sono dissonanti, vivono nella dissonanza, la prendono come regola, registrano quel che succede o si fanno registrare nei loro movimenti dal narratore; e forse non sono nemmeno uomini ma loro residui, o residui d’angeli, se si vuole, che hanno dimenticato come si fa la lettura del pensiero: somigliano a spettri, morti fantasmi, smorfie nemmeno troppo simpatiche di burattini che ricordano però il linguaggio, le storie, le immagini umane: un po’ vagamente. Dunque non parlano e non pensano veramente, ammiccando al lettore, ma piuttosto fanno il verso al linguaggio e al pensiero umani; con maggior distanza, certo, ma non con minor possibilità di dire che le cose, i fatti, le epoche (La famiglia che perse tempo racconta anche molto del secolo passato: i suoi tabù, le sue storture, i suoi mezzi di intrattenimento: radio, riviste, fumetti, cinema, televisione), le mappe dei luoghi ci sono, eccome: però non tornano, non sembrano avere un qualche senso, anche se qualche personaggio, insieme al lettore, s’affanna a trovarne uno. Di questo scarto tra la parola e il pensiero, tra come si potrebbero dire le fantasticazioni e come nei fatti le si dicono, tra il posto in cui il testo è gettato (il lettore) e quello da cui si getta (la voce che racconta, che interna o esterna al racconto è sempre decentrata e sonnolenta rispetto alle pastoie umane in cui si trova a vivere), è fatta, mi sembra, la scrittura di Salabelle, e dunque anche le prime righe citate della Famiglia che perse tempo e giù giù tutto il romanzo, dove arbìtri, rigidità del discorso (sinonimi, omografi, metafore morte) e del quotidiano (stranezze e regole interne a un nucleo familiare) suggeriscono continuamente spostamenti di senso, sospetti sulla realtà delle cose e linee di fuga alla ragione e all’immaginazione. Sono queste linee di fuga e sospetti i regali migliori che Salabelle fa al lettore, che può vedere la sproporzione, il difetto e riderne, oppure trovare la dismisura che avvolge ogni piccolo atto nostro, sorprendersene, amareggiarsene e sapere di non poterci far nulla, trovando così l’ultimo dono di questa scrittura: la libertà davanti a un testo, la forza liberatoria di un testo che non vuole darci ragione, torto, consolazione o rendersi in altri modi interessante, nonostante la triste condizione di essere tutti incatenati al linguaggio e ai limiti terrestri.
Il titolo stesso del romanzo è insieme descrittivo e fuorviante, se La famiglia che perse tempo è la storia di una famiglia che, tecnicamente, in ogni riga ed in ogni episodio del testo, perde il tempo. Ciò accade perché il tempo si è ammalato, e a lungo e in modi differenti la famiglia di rimando s’ammala, s’imbambola e s’angustia – a partire dal padre infetto per primo fino a coinvolgere tutti i membri, gli oggetti, le varie dimore abitate nel corso della storia –, per via di “perdite di periodi”, che hanno come primo malato il padre e come primo sintomo lo sporcarsi degli orologi da muro a da polso. Si tratta, per provare a dire più nel dettaglio, di momenti che sembrano rispondere a una teoria della relatività e dei quanti imperfette (un richiamo in questa direzione è all’interno del romanzo, a p. 114, in chiave ironica, tra i nuovi saperi che la famiglia rifiuta, ed è stato colto da Marco Belpoliti). In questi momenti difatti lo scorrere del tempo all’interno delle case e delle stanze abitate – il succedersi delle ore, la consistenza delle medesime, lo spessore del passato e del presente – si spazializza e insieme impazzisce, rallenta, ritarda, si disperde, si rintana in angoli della casa come un animale selvatico o spaurito; infine non coincide con quello convenzionale del “fuori”, che è un’imprecisata città di mare, con i suoi quartieri o meglio zone malamente conosciute dalla famiglia (“zone nere”, “zone dei germi”, per esempio; ma anche il quartiere di Sassa – vicino Montecatini e nelle prossimità di Pisa in Toscana c’è una Sassa con cento abitanti, forse un lieve riferimento autobiografico). Con il tempo e le residenze della famiglia, che ne cambia almeno sei nel corso del libro, s’appannano anche i percorsi d’autobus della città, le sue mappe e vie: diventano misteriosi e solo vagamente collocabili anche per qualche avventore della storia (il conducente d’autobus Obhes, ad esempio), oltre che per i componenti della famiglia. Questi, alla fine del romanzo, sperduti nella loro stessa casa, sapranno peraltro che la misteriosa città (città-fumetto o borgesiana mappa consunta, a dimensioni reali, di una città vera?), ha subìto un trauma irrimediabile. Poco prima, la voce della madre si era fatta sentire, riportata con complice e perfida austerità dal narratore: “Nostra madre mi confessò uno di quei giorni di non capire più la realtà del mondo. ‘Mi sembra di essere perennemente ubriaca,’ borbottò più di una volta poco prima di mettere in tavola. Dopo cena, un attimo prima di ritirarci per andare a leggere in camera, tutti e due ci scambiavamo delle occhiate con cui ci interrogavamo sull’esistenza”. Vale la pena di aggiungere che è Italo Svevo, La coscienza di Zeno, ad esser citato in epigrafe di La famiglia che perse tempo (“quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo”), e Salabelle dice così, come fa anche in altri romanzi con Walser (le sue storie che danno da pensare), Tozzi (il suo manierismo ruvido, con qualche traccia di ferocia), Flaubert (la ricerca vera e un po’ finta della parola giusta) Perec (la sua capacità di creare spazi dove non ce ne sono), di dover qualcosa a quest’autore, all’ironia disarmata del triestino. Però lì c’è un’analisi mancata e un’apocalissi sognata in prima persona; qui, e lo si capisce subito, un referto spaurito sulle tante analisi possibili di un male e sull’accadere di una apocalissi che nella scrittura si danno per certe o forse no, e che il lettore può supporre, se vuole, come solo sognate o più vere del vero, e più tremende del vero che riesce tutti i giorni a percepire.
La voce che ci racconta la storia della Famiglia che perse tempo, lo spettro o fantasma in vestiti d’uomo di cui si diceva prima, è anche quella attraverso cui conosciamo il resto dei personaggi. Si tratta del figlio maschio Phatrizio Gerdy, già cronista come la sorella di questo brano di storia familiare in due diversi manoscritti, entrambi perduti e disprezzati dal padre (ancora una nota: Manzoni e De Amicis possono venire in mente, ma Salabelle ci avverte subito che la strada è breve e si può cambiar direzione, perché non ci sono documenti di partenza da controllare e non c’è padre premuroso a riscrivere; e inoltre il tema della scrittura scoraggiata è un altro dei suoi rovelli – si legga lo strepitoso passaggio dell’Assistente inaffidabile in cui lo zio propone al nipote spiantato che ha scritto un romanzo a suo modo di vedere brutto (“non avevo mai letto niente di più insensato”) di prendere un nuovo lavoro: “cercano uno scrittore alle prime armi. Deve semplicemente produrre racconti. Potrebbe essere la soluzione del tuo problema, un modo per smettere di perdere tempo”, gli dice). Phatrizio racconta quasi tutta la vicenda in una prima persona plurale ondivaga che a volte prende il punto di vista dei figli, a volte quello dell’intero nucleo familiare: “inizia il giorno in cui la prima affezione colpì la casa dove abitavamo, e finisce quando su di noi si abbatté una catastrofe alquanto insolita”, spiega impersonalmente nella Prefazione; ma aggiunge anche, dopo qualche pagina, di esser entrato una volta in cucina e di essersi sentito “un essere straniero penetrato per sbaglio nell’appartamento”. Il suo nome e le sua attività possono destare un qualche interesse, specie se confrontati con quelli degli altri personaggi che vivono insieme. Phatrizio infatti a quanto pare non fa nulla, non sappiamo bene che età abbia, si aggira spesso per casa con una grossa radio sotto l’ascella, lavorerà per poco come conducente d’autobus, perdendosi in città e forse portando a casa malattie sconosciute, così che i genitori ad un certo punto lo scoraggiano dal proseguire il lavoro. L’altro fratello della storia (tutti i componenti della famiglia come si diceva vivono sotto allo stesso tetto) è medico, uno dei tanti medici capaci di far diagnosi e conferenze ma non di guarire che s’incontrano nei romanzi di Salabelle, e si chiama più semplicemente Federico; la sorella cronista e scrittrice, non si sa se in formazione per diventar madre di famiglia sua o per sostituire la madre della famiglia di partenza, è, vezzosamente, Maria Paola (ad un certo punto si dice che “russava in modo intermittente che ricordava lo stile della sua cronaca”); il fidanzato per una stagione della sorella (compare in un capitolo del romanzo pubblicato come racconto su “Riga” 6, dedicato a Delfini) è qualcosa di simile ad un intellettuale, forse dotto di materie scientifiche: porta il biblico o anche evangelico nome di Giuseppe. Il padre mischia liquidi, legge giornali o li sposta; la madre infine non ha nome, ma come tante donne di Salabelle si segnala per le sue notevoli dimensioni, per il suo avere in mano o brandire qualcosa quando entra in scena (un mestolo, una patata, una rivista), e per i suoi commerci piuttosto oscuri con un proibito di bassa lega, un po’ provinciale (sigarette d’incerta provenienza, donate a chi fa l’uomo di casa in quel momento; biglietti con su scritte scommesse familiari sul prossimo film che si proietterà in cucina). Ecco dunque, per restare sulle generali, si può dire che diversi personaggi di Salabelle hanno nomi e attività come quello di Phatrizio, tra il verosimile lontano, il fallimento previsto e l’assurdo anche rispetto a quelli di altri personaggi dello stesso libro; in molti nomi di questi personaggi disutili l’acca è aggiunta e sottratta con minimo capriccio (il protagonista dell’Assistente inaffidabile si chiama Filip; c’è poi il Lhardo del Mio unico amico e il Philippo dell’Altro inquilino, per fare qualche esempio). Ed è forse questo un altro modo per ricordare da lontano il linguaggio e il fare umani, attaccandoli per così dire nelle loro zone più arbitrarie, i nomi propri e le occupazioni, e insieme per ribadire il meccanismo garbatamente ma puntualmente deragliante nei confronti dei saperi ricevuti e delle convenzioni narrative che Salabelle pone a presidio della sua scrittura e dei suoi racconti.
Sul trattamento di queste convenzioni e saperi la Famiglia che perse tempo contiene tutta una serie di luoghi noti alla letteratura e ricorrenti nelle opere di Salabelle, tanto che il libro si dà, oltre che come testo da leggere per sé, come una sorta di atlante di temi sviluppati altrove da questo autore in modo simile eppure differente (è il segno o no di un grande scrittore esercitarsi su temi non nuovi, mantenendo il proprio tono e la propria riconoscibilità di visione in tanti plot che sono sempre diversi?). Il tema della malattia, per esempio, tanto frequente nelle sue scritture, è qui come in altri libri affrontato nella chiave di un positivismo ridotto ai minimi termini ed estremizzato, spesso messo in bocca a un medico o a una persona che evidentemente riporta pareri tecnici di medici o specialisti un po’ meccanicamente e un po’ mettendoci del suo, di certo senza aver letto nessuno dei libri cui questi specialisti in genere attingono. Oggetti, posti e uomini democraticamente s’ammalano alla stessa maniera, e se sono sempre gli oggetti e i luoghi ad avere, nell’idea dei personaggi, il potere infettivo iniziale, anche oggetti e luoghi davanti agli occhi del lettore muoiono, si bucano, vanno in autocombustione – il fratello medico Federico esaminerà un giornale, ad un certo punto, verosimilmente infetto: “Questo giornale è già morto”, la sua diagnosi, “inizierà a puzzare tra due o tre ore; bisogna provvedere immediatamente”. La famiglia, poi, è un microuniverso chiuso, una fragile gabbia che per tenersi insieme si protegge dal fuori e infine lo contagia e ammala. Questo microcosmo ha le proprie regole arbitrarie, pazze e tuttavia scalfibili solo dall’interno (“dentro la stanza di nostro padre l’avvicendarsi delle ore seguiva un ritmo piuttosto rapido, a causa del quale gli orologi si muovevano come impazziti. Chiamavamo questo fatto semplicemente ‘l’ora legale’ sottintendendo che eravamo noi nella legge”). E dunque la famiglia è del tutto simile, nel concetto, ad altri luoghi chiusi prediletti di Salabelle: il negozio d’abbigliamento in rovina dove si può organizzare un omicidio per sbaglio come ordinare un abito fatto interamente di tabacco per provare a smettere di fumare; o ancora la scuola, questo mondo alla rovescia dove vige un linguaggio ignoto al resto del mondo (“fare” e non “leggere” Foscolo; “finire” il programma; “segnare” su un “registro”), dove si trovano oggetti infettivi in sommo grado e fatiscenti (banchi, lavagne, cattedre), e infine dove s’impara, specie grazie alle materie letterarie, a “dire l’esatto contrario di ciò che sarebbe normale dire” per esprimere invece ciò che l’istituzione accetta che al suo interno venga detto. È in posti come questi che il “dentro” arbitrario riesce a prendere il peggio dell’arbitrarietà e delle provvisorietà del “fuori”, a masticarle e ributtarle nel mondo come morbo dilagante, fino all’esplosione atomica. Esplosione che negli altri romanzi di Salabelle non c’è o viene smorzata, e che invece nella Famiglia che perse tempo avviene e viene descritta con un pudore e una ferocia introvabile nella letteratura di quegli anni e di questi nostri. Nell’ultimo capitolo del romanzo si legge del disastro tutto intorno, della fine del tempo interamente consumato e fatto nullo tra le pareti domestiche, del trionfo della televisione che prima proietta film scialbi (meno belli di quelli che la famiglia proiettava in cucina tempo prima) e che adesso fa posto a immagini di città distrutte, poi a uno speaker che dice non c’è più niente da fare: salvatevi da soli. Phatrizio cerca di scrivere un saggio sullo spazio e sul tempo, non ha più voglia di leggere, il padre che era scomparso per esser troppo malato ritorna in casa, lui subito dopo s’ammala, viene visitato da un medico anziano “con alcuni apparecchi lucenti, la cui assurda inutilità mi si rivelò nel giro di un attimo” (“Non deve bere acqua dal rubinetto per perlomeno una settimana. E non deve fare sforzi non necessari”, la diagnosi dell’attempato luminare). Dunque il tempo è finito, i giornali sono morti, la televisione è scappata, le voci della radio e le immagini del cinema non ci sono più: la vita malata della famiglia però continua, una volta buttati gli orologi nel cestino. Al lettore, s’è già detto, spetta di scegliere cosa fare di queste parole, vetri affilati che deturpano vecchio e nuovo, mostrando come trionfante solo il peggio. Salabelle, per parte sua, mette punto. E senza scomporsi troppo, com’è sua natura, ci consegna una delle più limpide e disturbanti storie della morte e dell’orrida, immediata resurrezione degli ingranaggi del mondo scritta (descritta?) negli ultimi quarant’anni.

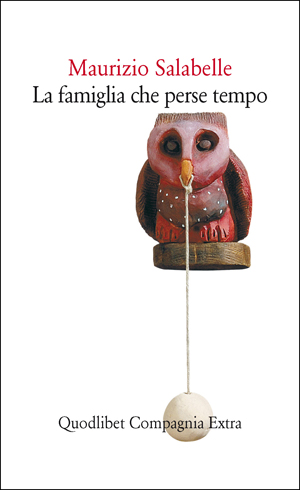

[…] di ELENA FRONTALONI, “Nazione indiana”, 24 giugno 2015 […]
Molto intrigante !!!